Anno Accademico 2023-2024
Vol. 68, n° 4, Ottobre - Dicembre 2024
Simposio: Le malattie del peccato
07 maggio 2024
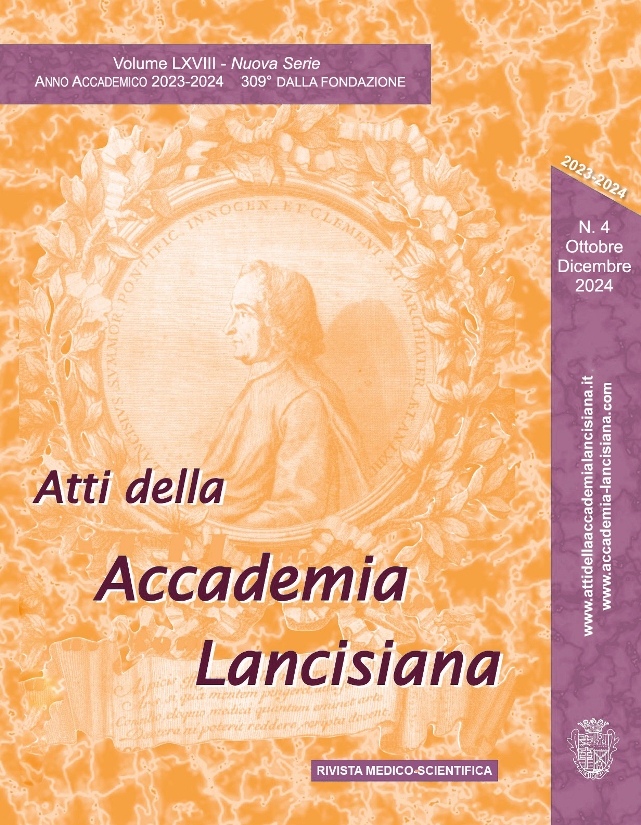
Simposio: Le malattie del peccato
07 maggio 2024
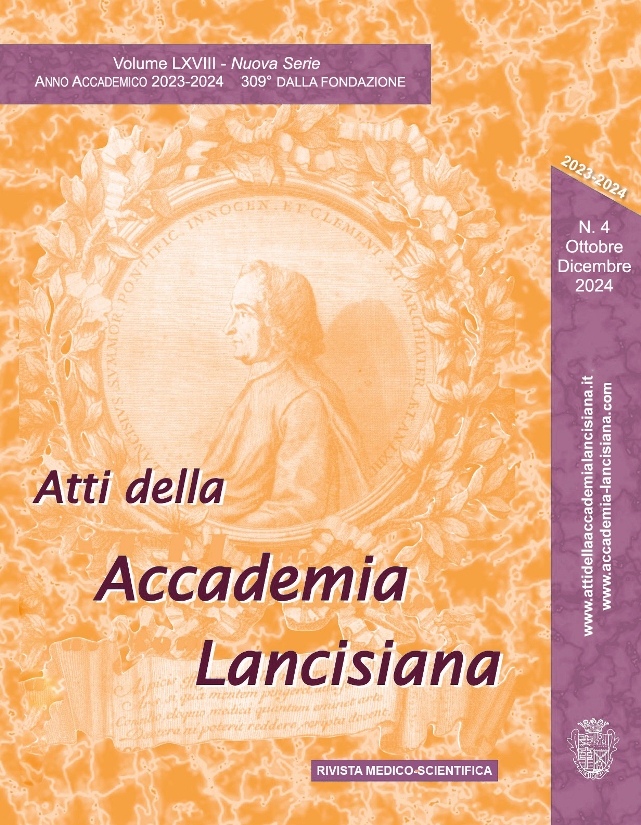
Versione PDF dell'articolo: Download
Il tema trattato, per meglio comprendere il messaggio che si propone, vede in modo sintetico, il coinvolgimento di altre tre relazioni che mirano ad evidenziare a tutto tondo aspetti e conseguenze degli abusi e delle trasgressioni da parte di certi comportamenti della storia dell’uomo che riconduciamo alle “malattie del peccato”.
Partendo dai vizi capitali, è intuibile come la lussuria e la gola, siano emblematiche di corruzioni e sregolatezze, eccessi e abusi, per soddisfare piaceri e appetiti, sessuali e da tavola.
Per la lussuria prevale “l’abuso” sessuale unito alla trasgressione a volte della innaturalità, con conseguenze di malattie specifiche, principalmente la blenorragia gonococcica o la sifilide; mentre per la gola l’esagerazione della ingordigia del mangiare, tende in genere all’obesità, al diabete, agli squilibri metabolici, ecc.
Inoltre, aspetti di più evidenza psichiatrica si evincono da queste trasgressioni, quali quelli tendenti al suicidio nel peccato di gola, o di dipendenza ludica, o di droghe, o disturbi neurologici, per la lussuria.
Nell’arte poi, numerose sono le rappresentazioni che descrivono un concetto così peculiare e chiaro quale quello della peccaminosità della trasgressione. Riguardo alla teologia, nel complesso della dialettica filosofica sul tema della disputa della carne e del cibo, e quindi di un’alterazione dell’etica, di amoralità, un esempio in tal senso lo si può ben apprezzare nelle belle pitture in affresco che ornano l’abside della chiesa dedicata a San Giorgio ad Albenga in Liguria. Qui i demoni, ben raffigurati in modo severo e torvo, puniscono i lussuriosi attorno a tavole imbandite di succulente pietanze. Altra bella rappresentazione è una illustrazione contenuta in un manoscritto francese depositato alla Biblioteca Nazionale di Francia (6185-foglio 255), dove alcuni commensali seduti in una tavola ben apparecchiata, osservano una giovane coppia, che dentro ad una vasca si scambia effusioni amorose. Brevemente, alcuni aspetti diffusi della lussuria:
• eccesso del piacere sessuale e del modo di vivere;
• frequentazione case di tolleranza;
• uso di sostanze inebrianti (dipendenza alcol, sigarette, droghe);
• deriva psicologica (ossessiva-compulsiva);
• mal d’amore perdica (carme latino-incesto-consanguineità);
• dipendenza gioco d’azzardo.
L’abuso del sesso e le possibili conseguenze di malattie sessuali
Ripercussioni frequenti a carico dei genitali femminili:
• vulvite, uretrite, vaginite, Bartolinite, cervicite;
• inf. extragenitali: proctite, congiuntivite, mastite;
• raramente sepsi, artrite, cute (lesioni ipercheratosiche);
• infezione da Clamidia;
• tricomoniasi;
• papilloma (condilomatosi);
• herpes genitale;
• piattole, pidocchi del pube e altre parassitosi;
• HIV.
Ripercussioni frequenti a carico dei genitali maschili:
• uretrite, epididimite, prostatite, vescicolite;
• balanopostiti del tipo:
- semplice o sovrapposta HPV, o gonococcica, sifilide o ulcera venerea;
- Candidosica;
- erosiva cincinnata;
- fimosi congenita o acquisita;
- piattole, pidocchi del pube e altre parassitosi;
• HIV.
Ci soffermiamo qualche momento sulla malattia della Sifilide e sulla blenorragia gonococcica che sono patologie contagiose a carattere sessuale, che hanno determinato, e a tutt’oggi persistono, la promiscuità sessuale sia femminile che maschile (vedi saggio Margariti su questo stesso simposio).
La blenorragia gonococcica attualmente ad alta diffusione, è ben storicizzata, infatti ritroviamo una discreta documentazione già al tempo della prostituzione a Roma.
Ne parlano: Profluvia geniturae viris (Plinio Nat. XXII, 40-XX, 33), (Celso Med. IV, 28), (Areteo chr II,5), (Cel. Aur. Chr. III,18,78), (Galeno Aff. VI, 8).
Sempre in periodo romano, dalle narrazioni dei cronisti del tempo, Marziale, Giovenale, Petronio ecc. apprendiamo che la prostituzione a Roma (Lupanaria-scortum), provocava malattie e che le più diffuse erano:
- ulcera molle (Plinio Nat. XXX,22), (Cel. Med. Indurata e veteres duritia VI,18,6), (PLINIO G. epi. 1,16,24 maritus ex diutino morbo circa velanda corporis ulceribus putrescebat), (ORA. Stultorum incurata pudor malus ulcero erat Epi I, 16,24), (MAR. Parte gulosam solvit indecens morbus Epi. XI,61);
- Condilomatosi, Escrescenze dolorose (Celso Med.VI,18,8 ), (Plinio Nat. XXI, 83 -XXII, 16-XXVI, 58-XXVII,5).
Del resto una rappresentazione puntuale, in termini archeologici, circa le possibili malattie dei genitali, ci viene fornita dalla consegna degli ex-voto in terracotta alle divinità, che in area etrusco-laziale, svariati santuari hanno restituito dalle favisse scavate (buche di deposito di ex-voto). Eccezionali i genitali maschili ritrovati in località Corchiano, con accenni di condilomatosi, o al Santuario di Legnesina di Vulci con in evidenza la tecnica di circoncisione. Stesse considerazioni per i genitali femminili, vulve e mammelle con indicazioni precise di possibili malattie (vedi G. Baggieri “L’antica anatomia nell’arte dei donaria”). Al santuario di Lanuvio interessanti gli ex-voto che rappresentano la malattia di Peyronie (vedi G. Baggieri in Journal of Surgery 2019).
Per comprendere meglio alcune malattie, non possiamo esimerci dal fare un accenno ai richiami d’igiene a Roma: infatti non va sottaciuto come gran parte di questi contagi sessuali descritti in letteratura antica, siano per lo più da attribuire all’assenza di igiene. Marziale (II sec. a.C.), ci racconta dei Fullones, le tintorie che provvedevano a tingere i tessuti, ricaviamo come fosse importante approvvigionarsi di urina per l’utilizzo e diluizione dei colori ed anche per sbiancare i tessuti attraverso l’ammoniaca in essa contenuta. Venivano quindi collocati e ritirati periodicamente per le strade della città dei dolia, contenitori con funzione di orinatoi. Successivamente questa usanza, vedremo sarà fatta propria da Vespasiano che trasferirà nel classico Vespasiano la funzione di orinatoio pubblico, conservando anche il dolia, per il quale occorrerà pagare una tassa. Ma anche Giovenale ci offre testimonianza di assenza d’igiene, in questo caso delle feci, egli così dice: Giovenale (conductor foricarum, latrina stercorare con carretti Plaustra di notte), (concime eccellentissimo lo definisce-Columella).
A questo riguardo merita un cenno anche il bagno pubblico; ebbene in alcuni di essi (Ostia), era presente a fianco della latrina, appeso al muro uno scopino, il tersorio, un bastone che aveva alla sua estremità una sorta di spugna. Immerso in un secchiello d’acqua e aceto, veniva usato per pulirsi dopo aver fatto i bisogni un po’ come il bidet di oggi, (straordinaria intuizione igienica), tranne se non fosse stato ad uso pubblico, quindi promiscuo.
Ma tornando alla pratica della prostituzione, altre interessanti rappresentazioni figurative di periodo medievale, sono la bella illustrazione La casa delle donne (XV sec. Maitre de Bourderoles Bibl. Des art decoratif, Parigi) ed ancora la molto più suggestiva illustrazione Bibl. Medico-Laurenziana cod. chirurgico XII sec. che descrive la visita alle prostitute da parte di un medico.
La sifilide appare prepotente in Europa dopo la scoperta delle Americhe a seguito dei viaggi di Cristoforo Colombo. Il mal serpentino, così chiamata la sifilide o lue, comparve per la prima volta nel 1493 a Barcellona. Il dibattito aspro e molto intenso sulla presenza della spirocheta pallida, se prima della scoperta del nuovo continente, o se invece importata dalle Indie, col carico delle donne indigene a seguito di Cristoforo Colombo potrebbe trovare un compromesso, secondo gli studiosi moderni, con la teoria della congiunzione: il treponema che sussisteva in Europa poteva essere un batterio attenuato che trovò la sua esaltata virulenza, cioè una mutazione genetica nell'incontro con un altro treponema americano, generando il Treponema Pallidum in grado di provocare gravi danni alla salute dell'uomo e al dilagare a macchia epidemica. Riguardo a riproduzioni artistiche, che inneggiano alla sifilide, non possiamo non citare le statuine con raffigurazione diffusa delle macule sulla cute, anteriormente e posteriormente al corpo, esposte al museo antropologico di città del Messico, ed al Louvre di Parigi. Oggetti riconducibili a periodi precolombiani attestati a qualche migliaio d’anni prima della scoperta delle Americhe. Così come anche la dimostrazione di resti scheletrici di oltre duemila anni, con stimmate da sifilide sulle superfici craniche, rinvenuti in centro America.
Ecco il Mal francese che compare alla fine del ‘400, si diffonderà con una rapidità impressionante in tutta Europa. Ovviamente gli snodi di diffusione sono i focolai portuali, dove l’incrocio degli equipaggi del mondo allora conosciuto si concentrava in particolare nelle case di prostituzione. Un interessante documento del 1500 della coll. Galieti, tratta di una lettera di rimostranze sulla compravendita di schiavi fatta a Venezia, e vi si dice della restituzione di uno di essi perché affetto da mal francese.
Il proseguo della storia della malattia è ben conosciuto, citiamo solamente alcuni provvedimenti del secolo XIX che furono adottati per combattere la terribile sifilide. I primi a rendersi conto delle attenzioni che andavano perseguite in termini di salute pubblica sulla prostituzione furono le leggi sulla Maison Napoleoniche. Ad imitazione francese abbiamo che nel 1855 Urbano Rattazzi emana le prime organiche disposizioni, integrate nel 1857, precisando che vengono assegnate le competenze in materia alle questure che su questo fenomeno adotteranno, oltre ai controlli e alle registrazioni, la patente d’esercizio e il tariffario, imponendo tra l’altro le regole e le sanzioni sull’adescamento. Nel 1859 le norme vengono estese in modo completo su tutto il territorio dello Stato, del regno d’Italia. Nel 1871 si promulgano leggi sui sifilicomi, primi specifici ricoveri per i malati di sifilide. Nel 1887 il Congresso d’igiene di Vienna prende atto della discrepanza economica tra salute e malattia nella privazione della forza lavoro maschile. Salute dell’uomo un bene da salvaguardare, colpevolizzando in questo modo seppure indirettamente la donna quale responsabile ed emanazione del problema. Nel 1888 il governo Crispi riconosce i dispensari celtici all’interno degli ospedali.
Agli inizi del novecento si assiste ad una propaganda piuttosto incalzante sulla lotta alla sifilide. Un manifesto particolare, famoso al tempo, illustra due famiglie, una dopo la cura della malattia, felice ed in piena attività, l’altra con il marito zoppicante ed i figli malaticci. Peccato che le cure siano un’illusione sino all’avvento della penicillina. Infatti, fin dai tempi del guaiaco importato dalle Americhe, per passare ai vapori delle stufe o botti del Campailla, terapia a base di mercurio e incenso, la morte a distanza di qualche anno è puntuale. Per i più fortunati, la sopravvivenza si protrarrà tra problemi di deambulazione, psichiatrici e neurologici. Altra interessante propaganda vede la diffusione di formelle prodotte in serie con rappresentate parti del corpo lesionate da sifilide. Provengono da una serie prodotta da Deutsche Hygiene Museum Dresden, realizzate all’Esposizione Internazionale d’igiene tenuta a Dresda tra maggio e ottobre del 1911. Descrivono principalmente la sifilide, la tubercolosi e le ustioni. Le formelle sono il prodotto di una probabile e tipica propaganda tedesca in uso da parte delle industrie farmaceutiche che incentivavano la fiducia dei medici attraverso questi particolari modelli didattici. Il museo di Medicina di Dresda ebbe poi un ruolo particolare nel corso del regime del terzo Reich.
La diffusione della malattia trova una sua precisa espansione in termini di socialità per la sua facile contaminazione nei rapporti sessuali occasionali. La propagazione è ben dimostrata, come già detto, nel periodo dal XV al XIX secolo, nel quale si esprime nei contesti più rilevanti della vita delle società europee, e per tutti i curiosi condizionamenti del quotidiano vivere. Da quelli militari principalmente, a quelli di carattere economico-commerciale, di relazioni aristocratiche, borghesi o popolari. Scenari e luoghi come porti, stazioni, locande, bagni pubblici e così via.
Il desiderio irrefrenabile di congiungersi con donne prostitute, ed anche con uomini, non teneva conto, ad esempio in tutta la storia della sifilide e soprattutto in epoca fascista (dove il mito della virilità veniva esaltato consentendo tacitamente il tradimento dei mariti), del contagio trasmesso dai mariti alle proprie mogli al rientro da una casa di tolleranza.
Ebbene queste circostanze venivano vissute con un senso di vergogna estremo, impedendo alle madri di recarsi dal medico e farsi visitare. Possiamo immaginare le conseguenze, la povera moglie finiva per essere denigrata perché portatrice di sifilide o blenorragia.
Molte finivano allontanate dalla famiglia e ridotte a prostituirsi, è questa una delle scelte che piega le donne a prostituirsi. Altra motivazione alla prostituzione individuava le donne a servizio, sartine, orfane, ecc. che, abusate e rimaste incinte, venivano emarginate dalla comunità dove vivevano. La malattie verranno sconfitte dalla penicillina dopo la seconda guerra mondiale. Una grande vittoria soprattutto per la sifilide, che tra l’altro portava a morte decine e decine di uomini e donne nel breve volgere di qualche anno. Stesse considerazioni valevano e valgono per le relazioni omosessuali. E chi scampava viveva le peggiori condizioni dei disturbi neurologici, la malattia testimoniata anche con riscontri anatomo-patologici depositati ad esempio al Museo di Storia dell’Arte Sanitaria al Santo Spirito.
Si ammaleranno di sifilide importanti personaggi come Franz Schubert, Oscar Wilde, Guy de Maupassant, Charles Baudelaire e tanti altri ancora.
“Ho la sifilide! Finalmente la vera sifilide! […] E ne sono fiero, per tutti i diavoli e disprezzo più di tutto i borghesi, Alleluja, ho la sifilide, e quindi non ho più paura di prenderla!” (Guy De Maupassant).
“Il male che chiamiamo francese non accorcia la vita quando lo si sa curare, lascia solo delle cicatrici, ma ci si consola facilmente quando si pensa che ce le siamo procurate con il piacere, come i soldati che si compiacciono a guardare il marchio delle loro ferite, segno della loro virtù e fonte della loro gloria” (Giacomo Casanova).
«Nel Candide (Voltaire, 1759) il protagonista riconosce Pangloss in un accattone effetto da sifilide contratta dalla prostituta Pasqualina, la quale per ¼ doveva questo regalo ad un cordigliere dottissimo, che per ¼ l’aveva avuta da una vecchia contessa, che l’aveva ricevuta da un capitano di cavalleria, che la doveva ad una marchesa, che la doveva ad un paggio, che l’aveva ricevuta da un gesuita, il quale nel suo noviziato l’aveva avuta da un compagno diretto di Cristoforo Colombo.
L’ingordigia del cibo
A pochi chilometri da Poggibonsi e da Volterra, esattamente al centro alto della Toscana, tra queste due piccole città d’arte posa sonnecchiante la bella San Gimignano. La cittadina si erge solenne con le sue torri a dominare il territorio che traguarda sino a Colle Val d’elsa. Ebbene in questa cittadina visitando la Collegiata di Santa Maria Assunta, è possibile ammirare l’affresco di Taddeo di Bartolo del 1296, meravigliosa opera titolata “La punizione dei golosi, guardare ma non toccare”. Come nell’affresco di Albenga, anche in questo dominano i demoni che sono lì a condannare e punire i golosi che, tutti nudi attorno ad una tavola imbandita, osservano in cerchio i piatti della tavola. Il periodo è foriero di una moralità estrema, Dante che sta completando il suo Inferno, introdurrà un passaggio che riguarda Martino IV (Purgatorio canto XXIV), il papa goloso, che non poteva fare a meno di saziarsi delle anguille di Bolsena cotte alla vernaccia. Alla sua morte si ebbe cura di rispettare le sue volontà testamentarie disponendo che il suo cadavere fosse lavato con vernaccia e trattato con erbe profumate dal farmacista dello Stato Pontificio.
Ebbene l’iniziazione al peccato di gola sembra che appartenga ai monaci. In un certo qual senso è anche spiegabile vista la vita monastica, che consentiva oltre alla preghiera un tempo di intrattenimento nelle cucine a discettare sulle pietanze. Giovanni Cassiano IV-V sec. ci dice: “…la gola è il vizio monastico per eccellenza. Escogitata e concepita nei conventi, cenobi monasteri, è la porta d’ingresso dei peccati. Os vuol dire apertura e non palato, lingua, guance, ma orifizio da cui entra il cibo ed escono le parole termina col ventre che è si lo stomaco gli intestini i visceri, ma anche l’utero e gli organi sessuali e quindi la lussuria”.
Non da meno potevano essere imperatori e generali romani, in particolare Vitellio offriva di sé l’immagine più trucida dell’ingordigia. Dalla Storia dei Cesari di Svetonio ricaviamo “…Pranzava sempre tre, e talora quattro volte al giorno, facendo distinzione tra la colazione, il pranzo, la cena, e l’orgia, e riuscendo a sopportare ogni eccesso per l’abitudine di vomitare. Si invitava da sé, nello stesso giorno, ora da uno, ora da un altro e a nessuno questi banchetti vennero mai a costare meno di quattrocentomila sesterzi. Famosissimo fra tutti fu il banchetto offertogli dal fratello, in occasione della sua venuta: si dice che vi siano stati serviti duemila pesci delle migliori qualità e settemila uccelli. Ma superò anche questo quando inaugurò un vassoio che, per la misurata grandezza, aveva chiamato, ‘lo scudo di minerva, protettrice della città’. Dentro questo vassoio aveva fatto mescolare fegati di scari, (pesci di mare), cervella di pavoni e di fagiani, lingue di fenicotteri e lattigini di murene, che aveva mandato a prendere con le triremi e navarchi fin nel regno dei parti e fino allo stretto di cadice. Ma non era soltanto goloso; era anche ghiottone rozzo e sordido, e non riuscì mai a controllarsi, nemmeno durante le cerimonie religiose o in viaggio: davanti agli altari, s’ingozzava seduta stante con i panini e le carni strappate alle fiamme del sacrificio, e nelle taverne, durante i viaggi, con i cibi fumanti e, persino, con i resti avanzati del giorno prima”.
Mentre Orazio descrive il suicidio di Apicio, per l’impossibilità di poter continuare a banchettare come soleva fare, spendendo milioni di sesterzi per soddisfare gli appetiti mangerecci.
“….e vale la pena sapere come è finito Apicio. Dopo aver sperperato in cucina cento milioni di sesterzi, essersi divorato, cena dopo cena, le innumerevoli largizioni degli imperatori e le immense entrate del Campidoglio, oberato dai debiti, fu costretto per la prima volta a rivedere i suoi conti; calcolò che gli sarebbero rimasti dieci milioni di sesterzi e, reputandosi ridotto all’estremo della fame se avesse dovuto vivere con dieci milioni, si tolse la vita con il veleno” (Orazio Satire).
Diversamente, anche se è una rara testimonianza di come fosse considerato il peccato di gola da parte dei monaci novizi, come narra Aelfric Grammaticus, benedettino nel suo Colluquium:
“ che cosa mangi tu durante il giorno? Adesso mangio ancora carne perché sono un ragazzo che sta sotto frusta. E che cosa mangi ancora? Cavolo e uova, pesce e formaggio, burro e fagioli, tutte le cose oneste che si mangiano e di cui rendo grazie. Allora sei molto ingordo se mangi tutto quello che ti viene messo davanti. Non sono tanto ingordo da poter mangiare tutte le qualità di cibo durante un solo pasto. Ma allora come fai? A volte mangio una pietanza, altre volte un’altra, sempre misuratamente, come si addice a un monaco, non con ingordigia perché non sono un mangione. E cosa bevi? Birra quando ce l’ho, o acqua, quando non ho la birra. Non bevi vino? Non sono tanto ricco da potermi comprare il vino; il Vino poi non è una bevanda per ragazzi e stupidelli, ma per vecchi e saggi”.
Infine per concludere questo brevissimo lavoro citiamo due sculture, una del 1188 collocata al portale d’ingresso del santuario di Compostela che descrive un goloso che si sta strozzando per l’ingordigia di deglutire, l’altra del 1117 al Duomo di Verona che descrive un figura antropomorfa con sembianze di animale, che ingurgita con la testa rivolta in alto.
Inoltre nella produzione in terracotta di periodo etrusco romano, sono molto diffuse le statuine degli obesi che irridono al proprio corpo deforme ed alle bocche con pochi denti, esibite nella commedia dell’arte quali maschere, che hanno pagato il prezzo della perdita dei denti per il troppo mangiare (Baggieri, 1997).
Prof. Gaspare Baggieri, Conservatore del Museo dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria. Consigliere Scientifico dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria. Già Direttore del Museo dell’Alto Medioevo, Roma
Per la corrispondenza: gasparebaggieri@gmail.com
BIBLIOGRAFIA
Aelfricus Grammaticus. Aelfric’s Colloquy. Eds. Garmonsway GN. Londra: Methuen, 1939.
Akkus E. Current Clinical Urology, Historical Review of Peyronie’s Disease de La Peyronie to Devine. In: Levine LA (Eds). Peyronie’s Disease. A Guide to Clinical Management. Humana Press, 2007; 1-8.
Attenni L, Calandra E, Ghini G, Rossi M. La stipe votiva di Pantanacci. Archeologia Viva 2013; 159: 14-26.
Baggieri G. Etruscan Wombs. The Lancet 1998; 352 (9139): 790.
Baggieri G. L'antica anatomia nell'arte dei donaria. 2 ed. Roma: Ministero per i beni e le attività culturali, 1999; 62-3.
Baggieri G. La malattia della vergogna. Una notte da Venere, il resto della vita con Mercurio. Catalogo della Mostra, Museo della Civiltà, Museo dell'Alto Medioevo 'A. Vaccaro', Roma, 19 aprile - 30 giugno 2019. Ragusa: Edizioni di storia e studi sociali, 2019.
Baggieri G. Religiosità e medicina degli etruschi. Le Scienze. Scientific American 1998; 360: 76-81.
Baggieri G. Surgical Correction of phimosis in the Etruscan Period.Paleopathology Newsletter 2003; 122: 14-8.
Baggieri G, Gemek MD, Capasso L. On the paleopathology depicted in a collection of roman votive terracottas. Journal of Paleopathology 1995; 7: 75.
Grmek MD, Gourevitch D. Les Maladies Dans L'art Antique. Paris: Fayard, 1998; 292-5.
Li Vigni I, Rossi PA. GOLA mater amatissima. alimentazione e arte culinaria dall'età tardo-classica a quella medievale. Genova: De Ferrari, 2005.