Anno Accademico 2023-2024
Vol. 68, n° 4, Ottobre - Dicembre 2024
Simposio: Le malattie del peccato
07 maggio 2024
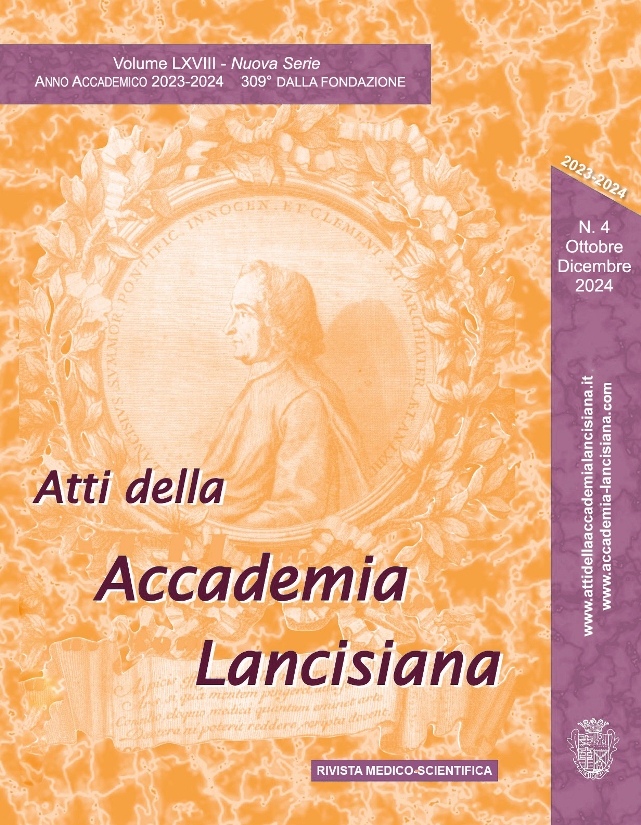
Simposio: Le malattie del peccato
07 maggio 2024
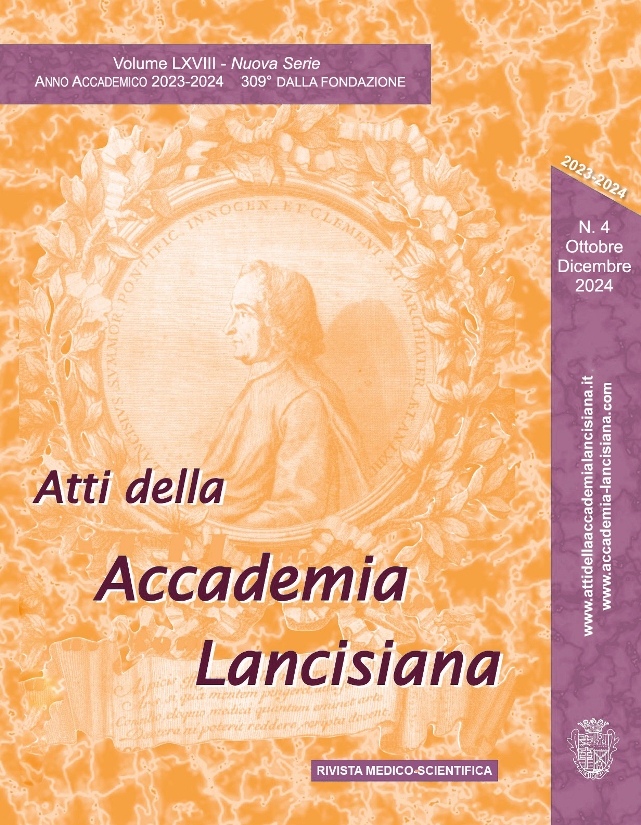
Versione PDF dell'articolo: Download
Introduzione
Il concetto della gola ha avuto sin dagli albori dell’umanità un ruolo significativo. Nella nostra tradizione religiosa, è un aspetto fondamentale il legame metaforico tra la gola e il peccato originale. Adamo ed Eva furono sedotti dal serpente a disobbedire a Dio mangiando il frutto proibito dell'albero della conoscenza, attraverso la maliziosa offerta di una mela appetitosa che simboleggiò il desiderio irresistibile di conoscere il bene e il male. L’associazione tra gola e peccato originale ha avuto profonde ripercussioni tanto che la gola è stata connessa al concetto di vizio, indicando eccesso, mancanza di autocontrollo e ingestione smodato di cibo al di là dei limiti imposti dalla moralità e dalla ragione. Questa visione ha modellato la concezione della gola oltre che come un difetto morale, causa di danni alla salute fisica e mentale.
Il legame tra gola e peccato
Il legame tra la gola e il concetto di peccato ha profonde radici nelle tradizioni teologiche e filosofiche, che rispecchiano questioni morali, spirituali e simboliche legate al desiderio e all'eccesso nella sfera alimentare. Fu Gregorio Magno sulla base delle considerazioni teologiche e filosofiche di Evagrio Pontico e Giovanni Cassiano che nel 590 d.C. associò la gola ai vizi capitali, considerati le radici di altri peccati, che includono l'avarizia, la lussuria, l'ira, l'invidia, la superbia e la pigrizia. Questo desiderio eccessivo di cibo e bevande allontanava l'individuo da Dio e dalle virtù spirituali. Nella filosofia morale, la gola è esaminata in relazione alla virtù della temperanza, che modera i desideri e gli appetiti fisici, compreso quindi il desiderio di cibo e bevande. La mancanza di temperanza nella sfera alimentare può portare a comportamenti dannosi per la salute fisica e spirituale. Oltre agli aspetti morali e filosofici, il concetto di gola e peccato ha un significato simbolico più profondo nelle tradizioni spirituali, rappresentando un eccessivo attaccamento ai piaceri materiali, ostacolando la crescita spirituale e la realizzazione del sé più elevato.
La gola: una preoccupazione storica per la salute fisica e spirituale
Nella storia della medicina, la gola, intesa come eccesso nel cibo e nelle bevande, è stata motivo di preoccupazione fin dai tempi antichi. Si riteneva che la gola fosse la causa principale di disturbi fisici e decadimento morale. Antichi medici come Ippocrate e Galeno sostenevano che il mangiare e il bere in modo eccessivo potevano provocare problemi digestivi, obesità e altre malattie. Esiste una connessione tra cibo e filosofia, considerando il mangiare come una metafora del pensare, un ruolo simbolico e religioso del cibo nelle culture umane. Le abitudini alimentari dei filosofi storici evidenziano come le loro preferenze gastronomiche riflettevano i principi filosofici. La cucina con le ricette riflettevano i modelli intellettuali delle idee filosofiche. Il tema della golosità e la sua relazione con la filosofia si estrinseca come desiderio estetico e affettivo.
La Gola ad Atene e Roma
Nell'antica Atene, la cultura alimentare era intrisa di simbolismo sociale e politico, manifestandosi soprattutto durante le celebrazioni e gli eventi di prestigio. Nonostante non siano pervenute evidenze storiche di eccessi alimentari dovuti specificamente all'ingordigia o alla golosità, l'abbondanza e il lusso erano valori ampiamente rispecchiati nei pasti consumati durante tali occasioni. I banchetti e le festività erano momenti cruciali per esibire potenza economica e sociale, attraverso la generosità dei cibi e delle bevande offerti agli ospiti. La condivisione del cibo durante questi eventi non solo soddisfaceva i piaceri sensoriali, ma serviva anche a rafforzare i legami sociali e a dimostrare lo status dell'ospite.
Al contrario, nell'antica Roma, la gola era vista come una condanna morale, causa diretta di malattie. In un'epoca segnata da carestie e limitata conoscenza medica, l'eccesso alimentare era spesso associato all'insorgenza di patologie, alimentando l'idea che la moderazione fosse un requisito essenziale per il mantenimento del benessere fisico. La società romana, influenzata dalle tradizioni etrusche e greche, considerava il controllo degli appetiti come una virtù necessaria per preservare l'equilibrio del corpo e della mente. Tale concezione morale era radicata anche nelle pratiche religiose, dove il digiuno e l'astinenza rappresentavano atti di purificazione e autocontrollo. In entrambe le civiltà, dunque, l'alimentazione non rappresentava solo un mezzo per soddisfare i bisogni fisiologici, ma era intrinsecamente legata a valori culturali, sociali e religiosi, riflettendo le concezioni dominanti di potere, status e benessere.
La Condanna Morale: La Gola nel Medioevo
Nel Medioevo, un'epoca segnata da profonda religiosità e rigide norme morali, la gola emerge come uno dei vizi capitali. Tuttavia, va notato che questo periodo non era caratterizzato da opulenza e abbondanza, al contrario, era spesso segnato da instabilità e crisi, con risorse alimentari considerate un lusso riservato ai ceti più agiati. Solo coloro appartenenti alle classi sociali elevate potevano permettersi generi alimentari di alta qualità e quantità abbondanti. Così, il peccato di gola era un'osservazione riservata a una minoranza privilegiata, piuttosto che a un fenomeno diffuso. In questo contesto, l'eccesso alimentare se fosse stato una questione di soddisfazione fisica, avrebbe rappresentato una violazione dei principi morali profondi, una deviazione dagli insegnamenti divini. Nell'epoca medievale, dove la religione permeava ogni aspetto della vita quotidiana, la moderazione nella dieta non era consigliata per il benessere fisico, ma era vista piuttosto come un dovere morale.
La Gola nella Divina Commedia: un'analisi approfondita
Nel contesto del Medioevo, un punto cruciale è l'interpretazione dantesca del peccato di gola. Dante Alighieri esplora questo tema in tutte e tre le cantiche della sua Divina Commedia: Inferno, Purgatorio e Paradiso. Nel Canto VI dell’Inferno, Dante dipinge un quadro dei golosi, puniti da una tempesta incessante di grandine, acqua nera e neve, senza alcuna tregua, fino a diventare irriconoscibili, con il peccato che cancella ogni traccia della loro identità. Nel Purgatorio, nel Canto XXIII, le anime devono affrontare fame e sete per purificarsi, in netto contrasto con i loro peccati terreni. Infine, nel Paradiso, Dante dialoga nel Canto XI con San Bonaventura, il quale discute della gola e della sua antitesi, la temperanza. Dante utilizza la gola come esempio di come un peccato possa dominare e consumare un individuo, ma mostra anche come attraverso la penitenza e la virtù possa essere superato. Questa raffigurazione non si limita a una semplice condanna senza speranza. Essa riflette la profonda comprensione di Dante della natura umana, lasciando spazio alla possibilità di redenzione anche per coloro che hanno commesso questo peccato.
La Gola tra Rinascimento ed Età Moderna
Durante il Rinascimento, la religione manteneva ancora una forte influenza sulla cultura, e la gola, insieme agli altri peccati capitali, costituiva un tema ricorrente nell’arte. Gli artisti rinascimentali impiegavano i loro dipinti per esplorare la natura umana e la moralità, rappresentando la gola attraverso personaggi che indulgevano in cibo o bevande in eccesso, offrendo così un monito contro l’ingordigia e l’avidità. Queste raffigurazioni erano intrise di simbolismo e allegorie, riflettendo le complesse idee filosofiche e teologiche del periodo. Emergono anche visioni utopiche in cui il tema dell'alimentazione è trattato con una nuova saggezza e consapevolezza, suggerendo una prospettiva rivoluzionaria sulla relazione tra l'uomo e ciò che lo nutre. Con l’avvento dell’Età Moderna, si osservano cambiamenti significativi. Le grandi scoperte geografiche e una nuova concezione dell’individuo portarono a nuovi orizzonti intellettuali, e con questi cambiamenti la gola divenne riflesso estetico delle tensioni culturali e religiose del tempo.
Dalla Scienza Gastronomica al Fenomeno di Costume: La Gola in Epoca Contemporanea
Nell'epoca contemporanea, il concetto di gola si evolve. Quando parliamo di gola oggi, non possiamo più limitarci a pensare al semplice atto di mangiare. È come se la gola si fosse trasformata in questa intricata trama di significati e sfumature che mescolano scienza, cultura e piacere.
La gastronomia diventa una scienza, una finestra che ci permette di scrutare più a fondo il legame tra noi e il cibo. Grazie a questa disciplina, possiamo davvero capire meglio perché ci comportiamo in certi modi quando si tratta di mangiare. È come se stessimo scavando nei meandri della nostra mente, comprendendo meglio quei meccanismi psicologici e neurologici che ci spingono a scegliere ciò che mangiamo.
La gola non viene più vista come un atto deviato, ma come un'espressione culturale del nostro piacere sensoriale. In pratica oggi rivalutiamo il modo in cui assolviamo alla necessità di alimentarci. In un mondo in cui sedersi a tavola è diventato un momento di connessione e condivisione, il significato della gola si amplifica. È come se mangiare diventasse un modo per esplorare la nostra identità, la nostra cultura, i nostri gusti. La tavola diventa il crocevia dove si mescolano passioni, relazioni e aspirazioni, e il cibo diventa il mezzo attraverso il quale celebriamo la nostra umanità e le nostre connessioni con gli altri.
Gola e Società contemporanea
L'importanza sempre crescente del piacere culinario nella vita quotidiana è influenzata dall'avvento dell'industria alimentare e dallo stile di vita moderno caratterizzato da stress e frenesia. Il cibo diventa non solo una necessità fisica, ma anche una fonte di comfort e soddisfazione emotiva per molte persone. Il cibo e le bevande assumono un ruolo come simboli di status sociale e benessere economico nelle società moderne. Si sviluppa lo scambio culturale nel promuovere la diversità culinaria e nell'aprire opportunità per esplorare una vasta gamma di sapori e tradizioni culinarie provenienti da tutto il mondo.
Conclusioni
E così, giunti alla fine di questo excursus attraverso le complesse implicazioni della gola, sembrerebbe che la gola non sia più un peccato, ma è così? È ancora un peccato?
Le recenti parole incisive di Papa Francesco risuonano potenti, descrivendo la gola oggi come il vizio supremo che minaccia la nostra stessa esistenza sul pianeta. In un'epoca in cui i cambiamenti climatici e i problemi ambientali ci spingono sull'orlo del precipizio, la gola, piuttosto che essere considerata un peccato personale isolato, rappresenta uno dei motori di una crisi globale imminente. È importante sottolineare che tutte le tradizioni spirituali convergono sull'importanza della moderazione e della consapevolezza nel rapporto con il cibo. Quando il desiderio eccessivo di soddisfazione del palato porta a comportamenti dannosi per la salute, sia a livello fisico, mentale che spirituale, ci troviamo di fronte a una distorsione dell'equilibrio che deve essere corretta. Comportamenti alimentari dannosi possono contribuire a gravi problemi di salute pubblica, aumentare i costi sanitari e, non da ultimo, danneggiare l'ambiente. Di fronte a questa realtà, promuovere un rapporto sano e consapevole con il cibo diventa una responsabilità non solo personale, ma anche sociale. Non è sufficiente ricorrere a un moralismo rigido o a restrizioni draconiane sul consumo alimentare individuale. Oggi è essenziale far apprezzare il cibo in modo responsabile, tutelando contemporaneamente la propria salute e l'ambiente. In definitiva, trovare un equilibrio nella relazione con il cibo significa non solo perseguire il proprio benessere individuale, ma anche riconoscere e rispettare l'interconnessione tra le nostre scelte alimentari, la salute della comunità e la salute del pianeta.
Prof. Pier Paolo Visentin, Vice Presidente dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria
Per la corrispondenza: pierpaolo.visentin@gmail.com
BIBLIOGRAFIA
Capatti A, Montanari M. La gola: Peccato, cultura, alimentazione.
La Cleca C. Contro l'arte della vita. Bari: Laterza, 2000.
Montanari M. La gola e il peccato: Studi di storia dell'alimentazione.
Petrini C. Buono, pulito e giusto: Principi di nuova gastronomia. Torino: Einaudi, 2004.