Anno Accademico 2023-2024
Vol. 68, n° 4, Ottobre - Dicembre 2024
Conferenza: La diagnostica nella storia della Medicina-Dermatologia
18 giugno 2024
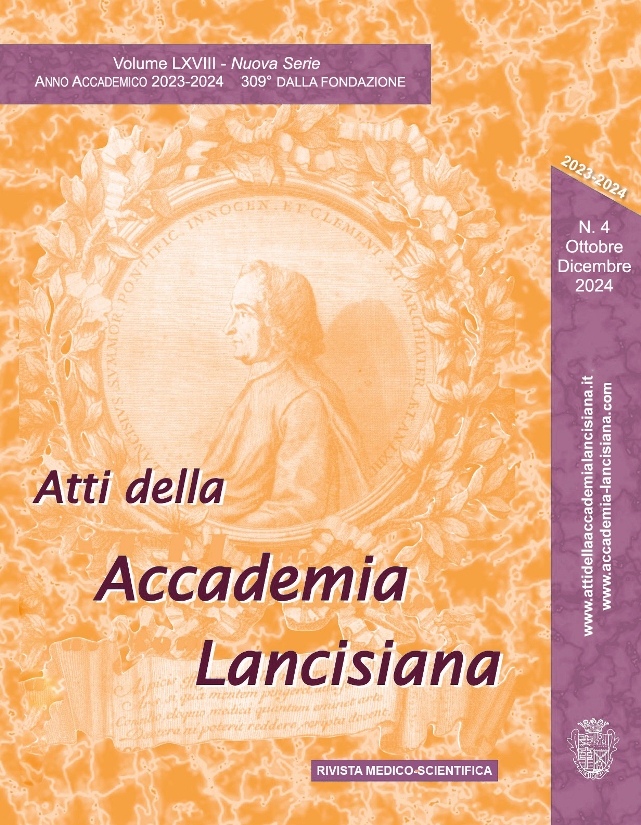
Conferenza: La diagnostica nella storia della Medicina-Dermatologia
18 giugno 2024
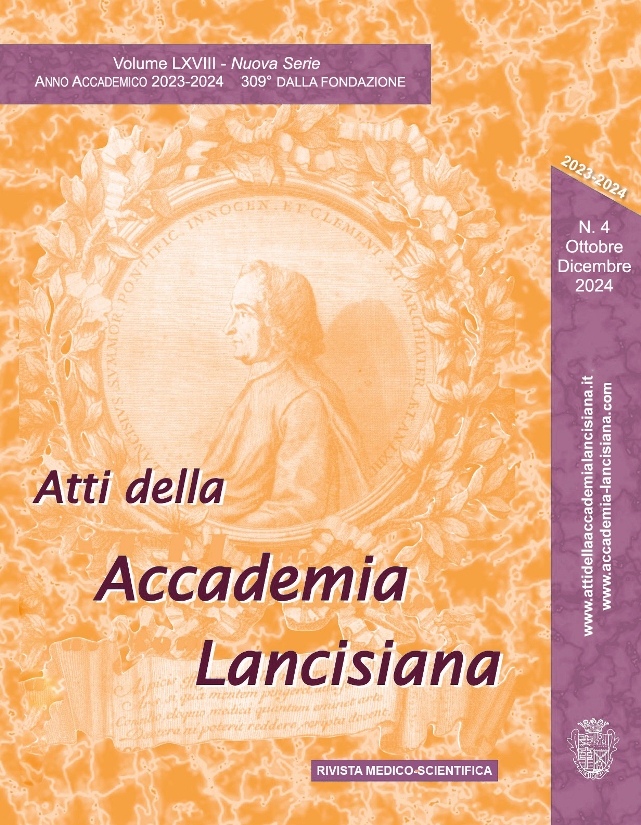
Versione PDF dell'articolo: Download
Anzitutto è bene chiarire perché utilizziamo il termine Medicina-Dermatologia e non quello abituale di Dermatologia e Venereologia.
La prima osservazione e cura del corpo è stata certamente cutanea, cioè dermatologica, e tale è rimasta per molti secoli come espressione di una Medicina esternistica.
Man mano che si è potuto esplorare l’interno del nostro organismo (XVI-XVII secolo), la Medicina è divenuta sempre più internistica e la Dermatologia, dal IX secolo, si è occupata principalmente della cute, dei suoi annessi e delle malattie veneree.
Perciò, in quanto peculiare aspetto esterno della Medicina, la Dermatologia è stata definita da alcuni studiosi Medicina-Dermatologia. Tale appellativo ci spiega perché più si approfondisce la storia della Dermatologia, più si penetra in quella della Medicina, in un continuum e reciproco rapporto bilaterale.
È nozione comune che la diagnosi e relativa diagnostica fossero già presenti nei tempi più remoti e che probabilmente, al pari della malattia, la loro evoluzione possa essere avvenuta parallelamente a quella dell’essere umano.
In effetti quando l'uomo primitivo vede il suo sembiante alterato, si chiede il come e il perché e quindi già, per certi versi, cerca la diagnosi.
Il termine Diagnosi (dal greco διάγνωσις ovvero capire attraverso) indica l'interpretazione della natura e della sede di una malattia in base alla valutazione dei sintomi. La Diagnostica invece è il processo per determinare quale malattia o condizione sia alla base della diagnosi.
Le tipologie diagnostiche sono diverse a seconda del metodo di rilevamento impiegato: nella genetica si comprendono e si valutano i geni di un organismo, nella ecografica si utilizzano le onde sonore per produrre immagini, nella radiologica si impiegano le radiazioni etc. Fra tutte le tipologie, sicuramente la più rilevante sul piano storico e che più interessa il Dermatologo, è la diagnosi istologica che si realizza attraverso la biopsia.
La più antica testimonianza del ruolo della pelle nei rapporti interumani e nella diagnostica medica fin dalle epoche più remote (Preistoria), è Ötzi, la famosa Mummia del Simulaun, risalente al 5.300 a.C. e ritrovata il 19 Settembre 1981 sulle Alpi venoste miracolosamente conservata dalle nevi perenni. Sul suo corpo sono visibili circa 61 punti, linee e crocette, possibili esiti di ferite, incisioni, marchiature, scarificazioni, causticazioni o altre pratiche esercitate sulla pelle (più verosimilmente tatuaggi), al fine di manifestare appartenenza tribale, ritualità religiose, pratiche decorative, terapeutiche o apotropaiche.
La maggioranza degli studiosi ritiene che la Medicina-Dermatologia sia nata in Oriente e che con essa verosimilmente abbiano compiuto i primi passi anche la diagnosi e la diagnostica.
Già nella Medicina mesopotamica (6000-539 a.C.), la malattia è considerata un castigo di Dio e quindi come punizione per una colpa compiuta che deve essere indagata. Nel Trattato Accadico di prognosi e diagnosi mediche, composto da 40 tavolette cuneiformi provenienti da Akkad, vengono menzionate diagnosi empiriche e terapie magiche ed in particolare si accenna anche a moleste sensazioni cutanee da approfondire per una migliore definizione diagnostica.
Nella civiltà indiana (3000-1500 a.C.) spicca la figura di Sushruta, chirurgo e primo autore di importanti scritti diagnostici di Medicina, come pure i famosi Veda, testi sacri della religione Vedica, fondativi del Brahmanesimo e dell’Induismo. La Medicina Ayurvedica (scienza della longevità) trae il suo nome da Ayur = longevità e Veda = conoscenza rivelata e si basa sul principio che il corpo fisico è pervaso da tre Dosha (energie vitali), per cui la patologia viene diagnosticata rilevando lo squilibrio fra queste energie.
Il simbolo rappresentativo della Medicina cinese (3000-221 a.C.) è il Tao, che vuol dire sentiero, e il principio di base è che la “natura è energia in trasformazione”. Per quanto riguarda la diagnostica della salute, essa è rappresentata dall’armonia fra Yin (male) e Yang (bene).
Nella Medicina egizia (3000-300 a.C.) vi è una concezione magica della malattia, per cui la dominante teurgica trapassa in un più diffuso empirismo che si manifesta in rituali, sacrifici, mummificazioni etc. In questa cultura già compaiono primordiali diagnosi mediche, anche dermatologiche, come risulta dai papiri di Edwin Smith e di Ebers, nei quali è rilevabile un approccio scientifico a diverse malattie, anche cutanee, quali dermatite seborroica, alopecia areata, parassitosi, ferite etc. con le relative terapie topiche.
Nella Medicina ebraica (1200-550 a.C.) la diagnosi è ritenuta sacra, in quanto la collera divina si concretizza nella malattia. Nella Bibbia sono presenti due termini specifici: Zara’at, con il significato di impurità, peccato e colpa; e Lepra, ovvero squama, per indicare una patologia cutanea oscura e pruriginosa, denominazione che per molti secoli resterà sinonimo di oltre settanta malattie cutanee quali lebbra, elefantiasi, peste, tubercolosi, sifilide, scabbia, psoriasi etc., creando sempre incertezze e confusioni diagnostiche.
Nella Medicina etrusca (IX-I sec. a.C.) la diagnosi è ieratica e si ricorre perciò a sacrifici ed aruspici per indagare cause e rimedi di diverse malattie.
La Medicina greca (1300-400 a.C.) è essenzialmente laica, in quanto il medico si emancipa dal sacerdote e compare per la prima volta il concetto di ricerca clinica e diagnosi. Di questa grandiosa e innovativa cultura sono protagonisti numerosi personaggi medici e non medici. Per Alcmeone di Crotone (V sec. a.C.) la salute, che lui chiama isonomia, consiste in un equilibrio fra caldo, freddo, secco, amaro e dolce; e la malattia è causata della prevalenza di uno di questi elementi sugli altri. Nel suo innovativo trattato Natura, accenna anche alla diagnosi di varie malattie cutanee e alle loro cure. La genialità di questo personaggio e il desiderio di conoscere l’interno dell’organismo si concretizzano addirittura in un audace tentativo di indagine autoptica, che purtroppo non giunge a buon fine.
Ma certamente il personaggio più significativo di questa nuova Medicina è il grande Ippocrate di Coo (460-377 a.C.), detto “padre della Medicina” perché autore della prima forma di scienza medica e della teoria umorale. Nello specifico separa la Medicina dalle precedenti pratiche sacerdotali, uscendo così dalla fase teurgica per approdare ad una metodologia razionale, rigorosa e scientifica, essenziale per una corretta diagnosi. Nella metodica ippocratica quindi la diagnosi si contrappone alla divinazione: l'esperienza e l'osservazione sistematica dei sintomi permette al medico di risalire alle cause fisiche della patologia e di elaborare una terapia attraverso il ragionamento deduttivo.
Secondo Socrate (469-399 a.C.) “la diagnosi è afferrabile logicamente e, in quanto verità, è divina”. Inoltre sostiene che “non esiste una malattia del corpo che prescinda dalla mente”: forse in questa sua geniale intuizione, c'è già una certa premonizione della futura Psicosomatica. Il metodo socratico si basa sul Dialogo, perché fa nascere la verità parlando con il proprio interlocutore e sulla Maieutica, perché ricerca la verità in sé stessi e la tira fuori dalla propria anima (forse un primo accenno alla Semeiotica).
Per il suo allievo Platone (428-348 a.C.) “la conoscenza vera si fonda sul ricordo delle idee conosciute dall'anima nella propria esistenza passata” e con ciò sembra già di intravedere il concetto di Anamnesi.
Aristotele (384-322 a.C), allievo di Platone e maestro di Alessandro Magno, nel 336 a.C. fonda la Scuola Peripatetica di Atene, definita “scuola maestra dei sapienti” e che rappresenta il primo modello al mondo di scuola superiore. I suoi ragionamenti sono basati sui sillogismi: “una volta scoperto il fatto, va ricercato il perché”, delineando in tal modo il rapporto causa-effetto che è appunto alla base della diagnosi.
Con il glorioso Alessandro Magno (356-323 a.C.) la cultura greca incontra e in un certo senso si fonde con quella egizia. Alla caduta del suo regno, divide il potere fra i suoi Generali, fra cui il più importante è Tolemaico in Egitto, e difende le sue conquiste. Nello specifico fra i tanti studiosi di questo periodo, Tolomeo I Solere, Re d’Egitto, consente persino l’esame dei cadaveri, ma solo a fini didattici.
Nella civiltà romana (750 a.C. - 476 d.C.) la salute è considerata un grande problema pubblico che raggiunge il suo culmine nell'edificazione del primo ospedale pubblico, si tratta del famoso Tempio di Esculapio che sorge nel 289 a.C. sull'Isola Tiberina, per l’accoglienza e il ricovero di bisognosi, appestati, invalidi e scartati a cui dedicare diagnosi empiriche e cure primitive. L'imponente edificio è circondato da un ampio porticato, il cosiddetto “recinto sacro”, nel quale vengono accolti, assistiti, rassicurati e curati i malati, realizzando in tal modo un primo esempio di “sanatio nosocomialis”. Al suo interno è molto praticata “l'incubatio”, ovvero la diagnosi e la cura attraverso il sonno, metodica già eseguita in epoca sumerica e nell'antica Grecia presso il Tempio di Epidauro. In questo contesto, Svetonio riferisce che, nonostante la proibizione religiosa di “aprire il corpo”, il medico imperiale Antistio (I sec. a.C.) per primo effettua un’indagine diagnostica addirittura sul cadavere di Giulio Cesare, ucciso nelle Idi di Marzo nel 44 a.C. e di cui ci lascia un sorprendente referto: “di tante ferite nessuna fu mortale ad eccezione di quella che aveva ricevuto per seconda in pieno petto”.
Il grande Aulo Cornelio Celso (26 a.C. - 50 d.C.) perfeziona il metodo sperimentale mediante osservazione, esperienza e ragionamento e definisce i primi quattro elementi diagnostici della flogosi: “calor, rubor, tumor et dolor”. Nel suo De Re Medica Libri Octo, enumera e denomina moltissime malattie cutanee e veneree, definendole “malattie delle parti oscene dove spesso il pudore impedisce di rivolgersi al medico…”, e con ciò accenna alle difficoltà diagnostiche, con cui ancora oggi i Medici si confrontano nella pratica professionale.
Areteo di Cappadocia (81-138 d.C.), esponente della Scuola Eclettica di Agostino di Troia, per primo scopre e denomina il diabete. Diagnostica le dermatosi squamose ad esso associate (dermatite seborroica, psoriasi etc.) e le ricollega ad alterazioni metaboliche, intuendo così per primo il rapporto fra diabete, psoriasi, prurito e sindrome metabolica, problematica ancora oggi studiata e discussa.
Galeno di Pergamo (131-201 d.C.), detto “padre dei galenici” perché loro creatore, scopre il quinto elemento diagnostico della flogosi, ovvero la “functio laesa”. Inoltre definisce la pelle “involucro di scorie e di escrementi morbosi” e, in 400 libri, descrive molte dermopatie anche veneree sempre connotate da ψώρα (squama) e da ψαο (prurito, grattamento).
Con la caduta dell'Impero Romano, nel 476 d.C., inizia il lungo e controverso Medioevo.
Paolo di Egina (625-690), medico bizantino seguace della Scuola di Alessandria, è l'ultimo esponente della Medicina greco-romana. Nel suo De Re Medica crea un ponte fra la Medicina greco-romana e quella medievale.
L'arabo Alhazen (965-1049), medico, filosofo, matematico, fisico ed astronomo, studia approfonditamente la scienza ottica e con questo getta le basi per la futura invenzione degli occhiali, stabilendo che il potenziamento della visione possa facilitare la diagnosi.
La Medicina Monasteriale (VI-XII sec.) cura i malati con piante ed erbe, pur riponendo sempre le massime speranze di guarigione essenzialmente nel potere divino, per cui la diagnosi è ancora essenzialmente teurgica.
I religiosi hanno la funzione di magazzinieri-farmacisti, che vengono chiamati Speziali e sono anche Medici. È merito di Federico II di Svevia (1194-1250), definito “Stupor Mundi”, la distinzione della figura del medico da quella dello speziale e un importante ordinamento fra le pratiche empiriche.
Nel IX secolo la Scuola Medica Salernitana, sintesi delle culture ebraica, greca, latina e araba, riprende lo studio diagnostico dell'anatomia, già iniziato da Erofilo nel III sec. a.C. e poi abbandonato dai suoi successori, ma solo in base a dissezioni praticate sugli animali. Fondatrice di questa illustre Scuola è Trotula de Ruggero (XI sec.) che, con le sue “mulieres salernitanae”, si dedica particolarmente alle diagnosi e alle cure nelle donne, specie se gravide, e nei bambini. Spetta invece a Mondino dei Liuzzi (1275-1326) il merito di essere l’ideatore della moderna anatomia, in quanto nel 1318 nel Teatro Anatomico di Bologna effettua la prima dissezione di un cadavere umano a scopo diagnostico e didattico: una fondamentale tappa nell'evoluzione della ricerca diagnostica.
Nel 1492 inizia l’Era Moderna, con la scoperta del nuovo mondo (America) e del nuovo morbo (Sifilide). Di quest’ultima realtà il merito principale è del “gigante della Venereologia” Girolamo Fracastoro (XVI sec.). Nel fondamentale testo “Syphilis, sive morbus gallicus” (1530), parla di “mal franzese” che per primo denomina “sifilide”. Nel De contagionibus - contagiosis morbis, eorum curatione, per primo ipotizza la presenza di organismi invisibili “seminaria”, responsabili di malattie contagiose (lebbra, scabbia, tigna…).
Andrea Vesalio (1514-1564) è considerato fondatore della moderna anatomia perché autore nel 1543 della prima opera scientifica sul tema, De humani corporis fabrica libri septem, corredata da numerosi disegni e illustrazioni del corpo umano ottenuti mediante l'osservazione diretta dei cadaveri: un ulteriore grande avanzamento nel processo diagnostico.
Il sommo Galileo Galilei (1564-1642) inventa nel 1614 il suo geniale occhialino, che può essere considerato un primordiale prototipo del futuro microscopio.
Severino Marco Aurelio (1580-1656), detto “luce degli incurabili di Napoli”, è fautore della diagnosi del “medicar crudo”. Scrive nel 1645 il primo testo in cui afferma che il microscopio debba essere diretto all'anatomia secondo il principio della “resolutio in invisibilia”: primo passo verso la Dermatopatologia.
Santorio da Capodistria (1561-1636) inventa metodiche e strumentazioni, fra cui il termometro, per la diagnosi anche cutanea e quindi può essere considerato antesignano della dermatologia sperimentale.
Bartolomeo Bonaccorsi, Professore di Medicina a Bologna nel XVII secolo, scrive nel 1656 il De externis malis opusculum, nel quale elenca le dermopatie in ordine alfabetico: primo tentativo sistematico di diagnosi differenziale in Dermatologia.
Il culmine della diagnostica istologica è merito dalla cosiddetta “triade fondativa”: Marcello Malpighi (1628-1694) autore della Dermatopatologia, Antonmaria Valsalva (1666-1723) ricercatore delle alterazioni delle parti malate sui cadaveri e Giovan Battista Morgagni (1682-1771) creatore dell'Anatomia patologica.
Giovanni Maria Lancisi (1654-1720), archiatra pontificio di Innocenzo XII e Clemente XI, per primo diagnostica “l'Aneurisma Gallicum” dimostrando così che la sifilide non è solo cutanea, ma anche gravemente viscerale.
Siamo nel secolo dei Lumi e molti studiosi si dedicano in particolare alla ricerca degli agenti delle diverse malattie e alla documentazione scientifico-didattica mediante modelli in cera. A tal proposito, famose e innovative sono le cere dermatologiche del maestro di ceroplastica italiana Gaetano Giulio Zumbo (1656-1701), che ben documentano lo sforzo nella ricerca diagnostica e l’intento di produrre un paradigma di riferimento per tutti i cultori della disciplina.
Giovanni Cosimo Bonomo (1663-1696) e Diacinto Cestoni (1637-1718) individuano nel Sarcoptes Scabiei e nelle sue uova la causa della scabbia; comunicano questa scoperta al loro grande maestro Francesco Redi con il testo Osservazioni intorno a’ pellicelli del corpo umano, realizzando così la prima comunicazione scientifica dermatologica al mondo.
Nell'era contemporanea, che inizia nel 1789 (Rivoluzione francese e industriale), Lazzaro Spallanzani (1729-1799) osserva che le orecchie dei pipistrelli sono più efficienti degli occhi per calcolare le distanze e scopre così l'emissione di eco e la trasmissione delle onde ultrasonore, che sono alla base delle odierne ecografie ed ecotomografie: per questa straordinaria intuizione è considerato il “padre della diagnostica ecografica”.
Altri studiosi scoprono nuovi corpuscoli sensoriali cutanei, come Filippo Pacini (1812-1883), Angelo Ruffini (1864-1929) e Bartolomeo Golgi (1843-1926, Nobel per la Medicina nel 1906).
Il biologo, matematico e abate agostiniano, Gregorio Mendel (1822-1884), è ritenuto precursore della moderna genetica perché nel 1865 scopre che le caratteristiche di un soggetto sono trasmesse dai geni che mantengono la loro identità nelle generazioni successive: perciò è ritenuto il “padre della diagnostica genetica”.
Tra ‘800 e ‘900 si verifica un notevole aumento dei test diagnostici batteriologici, immunologici, chimici, microscopici e mediante raggi x. Nel 1895 Wilhelm Conrad Röntgen effettua la prima radiografia medica della storia (Nobel per la Fisica nel 1901).
Nel Novecento si realizza un ancor più rapida e crescente varietà di test diagnostici: basti pensare che negli USA i 160 test nel 1950, diventano 1400 nel 1987.
E a conclusione di questa sommaria carrellata storica, è forse opportuno riflettere su quanto affermato da G. Realdi in Razionalità in medicina e l’avventura della diagnosi (Quaderni di Lettere dalla Facoltà, 2018): “La diagnosi medica è la prima e fondamentale tappa dell’atto medico. È un percorso che richiede l’adozione dei principi della razionalità che consentono una corretta applicazione del metodo clinico, procedimento che, mediante la soluzione dei problemi del paziente e la presa di decisioni da parte del medico, permette di contenere gli errori nel ragionamento e di ridurre l’incertezza della diagnosi”.
Prof. Luigi Valenzano, già Primario Dermatologo Istituto Dermatologico San Gallicano, Roma
Per la corrispondenza: valenzanodermatologia@gmail.com