Anno Accademico 2023-2024
Vol. 68, n° 4, Ottobre - Dicembre 2024
Simposio: La tutela della madre e del fanciullo nell'800 e nel '900
04 giugno 2024
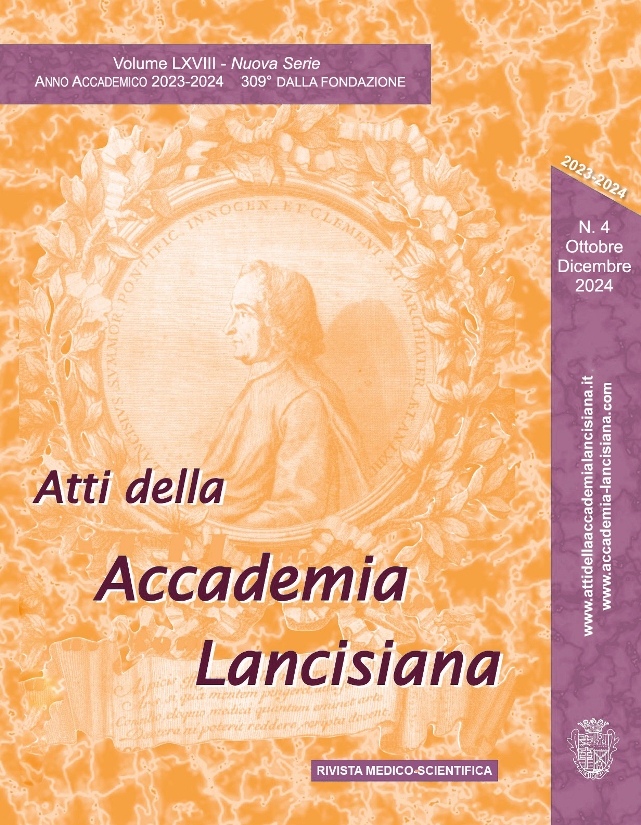
Simposio: La tutela della madre e del fanciullo nell'800 e nel '900
04 giugno 2024
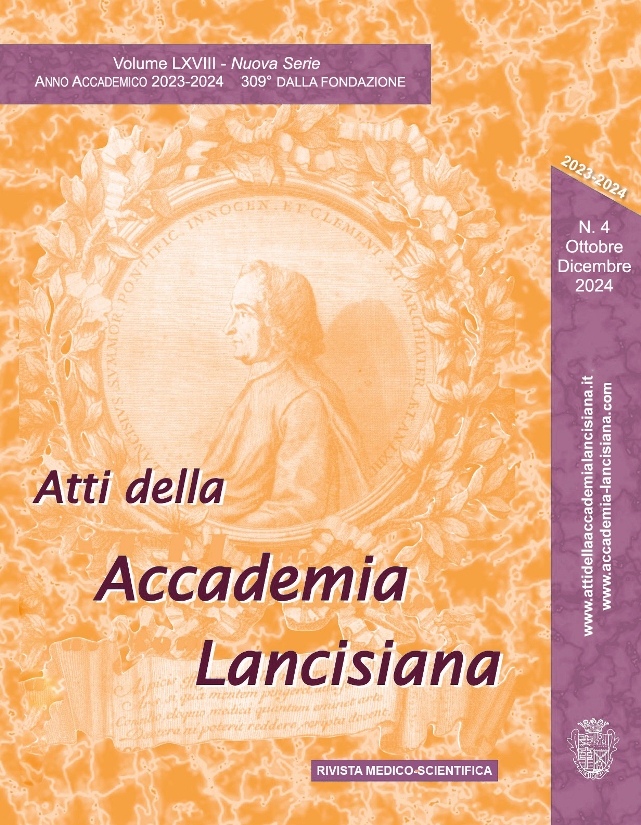
Versione PDF dell'articolo: Download
Nell’anno 2000, esattamente il giorno dopo l’Epifania, fu inaugurata a Roma, una singolare mostra, ad ingresso gratuito, dal titolo “Mater Incanto e disincanto d’amore”, che si tenne alle sale dei Dioscuri di Via Piacenza, alle spalle del Quirinale, con affaccio su Via Nazionale.
Questa precisazione è motivata dal fatto che chi percorreva Via Nazionale all’altezza del traforo poteva osservare in alto il grande striscione alto 12 mt e largo 1,50 mt, calato verticalmente dall’angolo del palazzo dei Dioscuri di Via Piacenza; la scritta recitava “MATER” a caratteri dorati su fondo blu. L’impatto di questo slogan risultava davvero emozionante, un imponente manifesto che entrava misteriosamente nelle appartenenze intime di ogni essere umano. Di ogni uomo o donna che, transitando a piedi o in autobus in quel tratto di Via Nazionale all’incrocio di Via Milano e al traforo, leggeva “Madre”. In quel periodo il Parlamento italiano stava discutendo alcuni emendamenti migliorativi della legge sulla procreazione assistita, tenendo d’occhio ben salda la famigerata legge sull’aborto, la n. 194 del 1978, un diritto civile conquistato con grande sofferenza e confermato con affermazione popolare al referendum del 1981. Oggi banalmente, si vuole ancora ridiscutere un diritto, che al di là di una questione morale, rispondeva principalmente all’eliminazione della diffusa pratica dell’aborto clandestino.
I contenuti della mostra si spiegavano tra oltre duecento oggetti che dalla preistoria ad oggi testimoniavano la condizione della maternità, dal desiderio, al rifiuto, all’abbandono del bambino, per arrivare all’abuso della procreazione. Un tema dirompente, di cui il comitato di settore del Ministero della Cultura che ne aveva approvato il progetto, proposto da un comitato scientifico promotore di tutto rispetto, sosteneva il messaggio di riflessione. Comparivano tra gli altri, nomi come Adriano Bompiani, Dante Manfredi, Mirko Grmek, Romolo Augusto Staccioli, Guglielmo Matzke, Angelo Capparoni, assieme ad altre eminenti personalità che avevano condiviso l’ideazione da parte del sottoscritto.
Dalle veneri in osso delle grotte di Parabita di 20.000 anni, alla sepoltura di S. Maria di Agnano ad Ostuni, madre con bambino nel ventre, di 10.000 anni, agli uteri e altri genitali femminili in terracotta etruschi, ai segni dell’abbandono alla ruota, alle cere ostetriche del Manfredini, ai libri medievali del baliatico, alla scultura madre dello scultore Silvio Amelio, alla pittura raffigurante Innocenzo III che ascolta i pescatori che porgono tra le reti, anziché pesci, bambini neonati gettati al Tevere e così via nella narrazione secolare, la mostra sostanzialmente denunciava storicamente i passaggi più delicati che ha vissuto la donna su questo aspetto esclusivo della riproduzione umana. Il percorso si concludeva in un avveniristico laboratorio di genetica della riproduzione umana. Le opere erano state prestate da importanti istituzioni museali, quali l’Archivio di Stato di Pistoia, il Museo Nazionale Romano, il Museo Etrusco di Villa Giulia, il MAN di Napoli, il MarTa di Taranto, ecc. Alla esposizione si associarono una decina tra conferenze e incontri scientifici, affollatissimi, tenuti nel bel teatro dei Dioscuri all’interno delle sale espositive. Memorabili quelli di Giovanni Berlinguer, di Romano Forleo, di Adriano Bompiani, del prof. Russo della Scuola Ostetrica della Sapienza.
Ne parlarono quotidiani nazionali e locali, il “Corriere della Sera” per ben tre volte, “L’Osservatore Romano”, “Il Sole 24 ore”, “Il Tempo”, ecc.
Ebbene, come spesso accade la mostra suscitò un certo imbarazzo per qualche politico, che sollevò l’interrogativo se poteva influenzare o meno il dibattito in corso al Parlamento (al quale su specifica richiesta furono consegnati un centinaio di cataloghi direttamente prelevati dai viaggiatori con tanto di furgoncino della Camera dei Deputati), sulla procreazione assistita. Questo avvenne dopo che l’Osservatore Romano per la seconda volta recensiva l’iniziativa. Insomma per farla breve la mostra chiuse i battenti anzitempo. Interessante notare che, prima della seconda recensione dell’Osservatore Romano, un mercoledì pomeriggio di gennaio un alto prelato scese dalla sua automobile, una Mercedes nera con targa dello SCV, e defilato sotto una pioggia battente s’introdusse nelle sale espositive. La cosa m’incuriosì e confondendomi con qualche altro visitatore lo seguii passo passo, quando giunse alla grande vetrina dei contrassegni rimase in religioso silenzio ad osservare quegli oggetti di pietà popolare, tra mezze monete, nastrini, carte scritte e biglietti strappati. Lo osservai meglio e mi accorsi che tirando fuori un fazzoletto dalla giacca nera, si asciugava gli occhi dalle lacrime e baciava il grande crocifisso che teneva appeso alla catena del collo. Rimase ancora qualche minuto, e in fretta abbandonò la sala per risalire sull’auto dove un autista ubbidiente lo aspettava aprendogli lo sportello. Cercai d’informarmi chi fosse, qualche tempo dopo seppi da un componente del Comitato Scientifico suo amico, che gli aveva suggerito di vedere la mostra, forse trattarsi di sua Sanità, appellativo attribuito ad un noto Cardinale della Santa Sede.
Ecco, da questa premessa possiamo già immaginare il tenore che un argomento quale quello dell’infanzia abbandonata e povera, possa aver generato e sviluppato nell’arte popolare fin dall’antichità. Un’espressione composita, fatta di vibrati di corde neuroniche innescate dalla pietà e dalla compassione del disagio e del bisogno, del rifiuto o all’allontanamento del bambino per ragioni di nutrimento o per vergogna quale figlio della colpa. Artisti di sensibilità acuta testimoni di un’infanzia sofferta, hanno trasferito dalle loro mani in opere figurative e letterarie, una indiretta denuncia di un mondo dei piccoli che altrimenti non avrebbe trovato ascolto. Senza andare lontano nei secoli, e senza alcuna pretesa, questo breve saggio vuole dare una sintesi del tema con alcuni riferimenti storici del periodo tardo rinascimentale, per giungere sempre in sintesi con incursioni anche a carattere socio psicologico, ad affrontare con spunti di originalità il tema esclusivamente dell’infanzia nell’arte tra XIX e XX sec.
Cominciamo citando gli affreschi del periodo rinascimentale, collocati al Santo Spirito nel retro facciata della corsia Baglivi, che descrivono Papa Innocenzo III che ascolta i pescatori che si lamentano dello scarso raccolto nelle reti, a fronte di una pesca abbondante di neonati annegati. Pittura in affresco di un quadro preceduto dall’omicidio dei propri figli ad opera delle mamme, con una didascalia di Bartolomeo Platina che così recita: “donne perverse cadute in stupro clandestino, per nascondere la propria colpa. Procurano di gettare il parto di notte al fiume”. Le successive sequenze narrano del sogno del Pontefice, che su indicazione dell’angelo costruirà il ricovero del Santo Spirito. Anche se fuori tempo, questa frase, ci dà immediata la percezione su alcuni dei motivi dell’abbandono dei neonati. E quindi le principali ragioni per adottare un simile provvedimento potevano essere:
A questo elenco andrebbe aggiunto l’infanticidio di neonati di colore (ipotesi in corso di studio dallo scrivente). Il Pontefice Innocenzo III è ritenuto colui che in Italia introdusse la ruota degli esposti all’omonimo ospedale, anche se questa appare materialmente, cioè come struttura di ricezione solo nel 1482, con Sisto IV.
Il ricorso alla ruota ha rappresentato quindi, per i secoli avvenire, la salvezza per tantissime di queste creature.
Venivano lasciati alla ruota o dietro consegna diretta dei proietti da parte di intermediari (gli infermieri degli ospizi territoriali, i massari, le levatrici, i parroci, altri soggetti), “dalla porta dei carri” o dalla “porta del campanello”. Il più delle volte si lasciava, ed ecco i primi documenti storici, appeso al bambino o tra le vesti, una parte o un frammento di un riconoscimento cioè un segno, l’altra parte del quale veniva trattenuta dal genitore per una eventuale restituzione che, a mezzo del combaciamento delle due parti, poteva dare prova del proprio figlio. I “Segni”: si trattava di mezzi nastrini, parti di fiocchetti, mezze medaglie, mezze catenine, pezzetti di stoffa con iniziali, biglietti con scritte d’affetto molto spesso autografate da parroci di altre città, (queste in doppia copia) ecc.
In altre città europee, a Parigi ad esempio, presso la cattedrale di Notre Dame, come narra Victor Hugo, una delle modalità dell’abbandono avveniva depositando il “fagottello” in una cesta dell’altare, per consentire a chi desiderava di poterlo prima vedere e poi adottare, ovviamente dopo accordi contrattati con l’abate.
Alfonso La Martine, intellettuale francese, difendeva con passione la condizione della donna stuprata e violentata e la deposizione del bambino nella ruota; così egli diceva “due cose occupano l’immaginazione di un’infelice donna che vuole nascondere il suo fallo, l’ospizio cioè, o l’infanticidio, ma la scelta non potendo essere dubbiosa, preferirà l’ospizio se ciò è nel suo potere, purché le riesca di essere ignorata; chiudete l’ospizio, ed allora non le lasciate che la disperazione e la morte”.
Tutte le ruote si somigliavano, in Italia in particolare, rimarranno in funzione sino al 1875, al primo apparire di una legislazione sulla tutela del fanciullo. Questo ricorso giuridico a risolvere il problema riscattava l’umiliazione dello Stato da un fallimento e da un’onta che il nuovo Regno d’Italia non poteva permettersi. A Firenze presso l’Ospedale degli Innocenti i bambini abbandonati venivano introdotti in una specie di finestrella ricavata su una parete, deposti all’interno di un tamburo di legno di forma cilindrica, che veniva fatto ruotare su di un piatto. Suonato un campanellino vicino alla finestra, dall’esterno passava all’interno dell’ospedale dove le suore, pronte ad intervenire ad ogni chiamata, provvedevano alle prime cure. Al di sopra della ruota, sempre all’esterno, vi era un puttino di marmo con la scritta: "O padre e madre che qui ne gettate / Alle vostre limosine, siamo raccomandati".
A Napoli gli ospiti dell'istituzione venivano, invece, chiamati "figli della Madonna", "figli dell’ annunziata" o "esposti" e godevano di particolari privilegi.
Al Santo Spirito di Roma una targa marmorea con una fessura in alto accanto alla ruota recita ancora oggi, “elemosine per li poverelli”. La ruota, ben conservata, attualmente è tra le più visitate e citate, contiene ancora il piatto rotatorio col suo cilindro in legno, con tanto di sportellino che risale alla fine del seicento, inizi del settecento.
Ora i bambini accolti in questi brefotrofi, come figli di nessuno, acquisivano nome e cognome a seconda del giorno o della notte, del mese e del giorno, dell’anno, dell’orario o del titolo dell’istituzione, oppure su indicazione del segno se era presente; così notiamo cognomi del tipo Bongiorno, Mezzanotte, Tredici, Quaranta, Cinque, Quindici, Febbraio, Marzo, d’Aprile, di Maggio, per avere attribuito cognomi legati al senso stesso dell’abbandono. Molto diffusi i cognomi distinti per città: Esposti o degli Esposti, Sposito, Speranza o Esposito a Napoli; Proietti (Roma) dal latino proiectus (gettato), o Innocenti, degli Innocenti (Firenze), Colombo, Colombin (Milano-Genova), Trovato, di Dio, (Sicilia), Diotallevi, Dioguardi, Diosalvi, Di Noi, Casadei, Conforti, Sperandio, Dellisanti, Santini, Santarelli, Fortunato, ecc. in tante altre parti d’Italia. Sembrerebbe che tre quarti dei cognomi della popolazione italiana abbiano queste ascendenze. Agli inizi del XX sec. e fino al 1954, era diffusa la carta d’identità dove alla voce figlio/a di madre e padre ignoti comparivano le lettere N.N. (nomen nescio), (si veda il bel film di Monicelli, “La Grande Guerra” dove un formidabile Vittorio Gassman, soldato della prima guerra mondiale, ed una incantevole Silvana Mangano prostituta, si confidano le loro origini genitoriali n.n.. Un’ultima curiosità: il termine “figlio di Mignotta” secondo il volgo popolare deriva esattamente dalla congiunzione latina, a sua volta di figlio di matris ignota. Infine, inspiegabilmente appaiono pretesi saggi storici (ndr), che non sono altro che ripetute cronache sul tema dell’infanzia e per differenziarsi appellano titoli, presunti inventati, come I Buttatelli, anziché Gettateli, Trovatelli, Esposti, Proietti, bastardini, ecc. come storia comanda e tramanda, senza peraltro spiegarne l’origine.
BrefotrofioL’organizzazione del brefotrofio, come si può immaginare, prevedeva il baliatico; venivano assunte dietro pagamento, mamme in grado di allattare oltre al proprio figlio anche un neonato trovatello. Nell’arte pittorica, sempre al Santo Spirito nel salone delle feste del Palazzo del Commendatore (edificato da Pio V) una parete intera celebra solennemente il baliatico. Donne giunoniche, in carne, che allattano i neonati, con un contorno di inservienti, fanciulle in età di lavorare, altre in attesa della dote destinata al matrimonio. Gli autori dell’imponente affresco pare siano Iacopo e Francesco Zucchi della seconda metà del cinquecento.
Per inciso le ragazze che non trovavano sistemazione, presso famiglie agiate e nobili, (tutrici, governanti, cameriera, guardarobiera, cuoca ecc.), o nell’artigianato (ricamatrici, sarte, tessitura di arazzi), o che non avessero contratto un buon matrimonio, rimanevano a disposizione dell’Istituto assumendo i voti religiosi divenendo esse stesse suore, oppure potevano far parte del personale di assistenza. I ragazzi, allo stesso modo, venivano avviati al mondo del lavoro come maniscalchi, ebanisti, materassai, ecc., altri invece nelle attività di fatica dell’Istituto, se non avessero trovato un impiego esterno.
Il brefotrofio diviene col tempo un riferimento fondamentale, anche dal punto di vista della costruzione. Infatti, gli edifici saranno costruiti con tutti gli accorgimenti necessari, soprattutto per evitare malattie e contagi. Frequenti erano le epidemie, in particolare di sifilide, di poliomielite, tubercolosi, scorbuto, scabbia ecc. Il tasso di mortalità era molto elevato con una percentuale piuttosto simile in tutta Italia.
Nel 1869 la mortalità al Santo Spirito in Sassia, nel biennio 1867-68, fu del 59%, nonostante la massima igiene e la ristrutturazione degli ambienti fosse stata da poco completata.
Nel 1872 nello stesso ospedale, la mortalità nel primo anno di vita era giunta all'88,78% (va peraltro rilevato che i bambini arrivavano spesso già deboli, infermi o malformati).
Nel 1893 Angelo Celli, docente di Igiene all'Università di Roma, constatava come la mortalità dei bambini dell'80% fosse soprattutto dovuta alla costrizione degli ambienti, rilevando la causa qualche anno dopo alla mancata separazione fra sani e malati.
Sul Mattino del 27 maggio 1897, Matilde Serao denunciava la morte di 853 bambini avvenuta l’anno prima 1896 nel conservatorio dell'Annunziata di Napoli.
Al fine di ovviare agli affollamenti dei ricoveri si suggeriva che i nuovi edifici dovessero sorgere in zone tranquille, lontano dai punti di gran traffico, protette dai rumori e dalla polvere. Devono essere forniti anzitutto d'un vestibolo, dal quale si passi, attraverso una galleria o antisala, alle sale dove soggiornano i bambini. Questi grandi ambienti debbono essere almeno due, uno per i bambini ancora lattanti, e l'altro per gli slattati; in questi locali le madri vengono nelle ore stabilite a dare il latte o a trattenersi con i propri bambini. È anche necessaria una sala provvista di culle per il riposo dei bambini, tanto meglio se suddivisa in piccole camerette da tramezzi. Prossima e in comunicazione col vestibolo deve trovarsi una sala d'aspetto o parlatorio e un ufficio per la direzione. Un assistente deve avere il suo alloggio permanente nell'asilo. Completano l'impianto una stanza d'isolamento per bambini malati, una cucina con apparecchi di sterilizzazione del latte e degli oggetti, un refettorio, una sala da bagno con parecchie vasche di ghisa o ferro smaltato, latrine speciali, ecc. Da tener presente anche l'utilità d'una veranda ampia e di buona esposizione che dia la possibilità di lasciare i bambini all'aperto durante le giornate favorevoli.
Inoltre importante dovrà essere il sistema di riscaldamento e di ventilazione delle sale per i bambini, data la loro delicata costituzione: preferibile il riscaldamento a termosifone. È norma fondamentale che le stanze per i bambini siano poco elevate dal suolo, meglio se a pianterreno, a un'altezza di circa un metro dal suolo circostante. Oltre a tutte le norme igienico-costruttive usuali vigenti per locali di tipo ospedaliero o per abitazioni collettive - facilità di pulizia, acqua corrente, finestre regolabili e completamente apribili per il ricambio dell'aria - si prescrive in generale nei brefotrofi un minimo di m³ 10 di ampiezza per bambino nei dormitori e altrettanto nelle sale di soggiorno. Uno degli esempi più moderni e grandiosi di questo tipo di edifici è quello di Berlino, sulla Kürassierstrasse, opera di L. Hoffmann.
Il brefotrofio di Villa Pamphili completato nel 1905, accoglierà tutti i fanciulli trasferiti dal S. Spirito in Saxia. Di questa importante istituzione rammentiamo il film “I soliti ignoti”, dove uno straordinario Renato Salvatori torna a visitare la casa del fanciullo, per riscuotere dalle sue tre mamme, una delle quali è la splendida Elena Fabrizi, la sua dote da loro custodita.
Nel corso delle due guerre mondiali, per difficoltà di vitto, riscaldamento e altre concause, l'indice di mortalità nel brefotrofio di Roma fu rispettivamente del 60% e del 40,7%. Nello stesso Istituto, fra il 1947 e il 1949, si diffuse un'epidemia di poliomielite: nell'autunno del 1947, nella seconda sezione, furono colpiti 11 bambini; nell'agosto del 1949 nella quarta sezione, restarono paralizzati circa 30 bambini.
I bambini abbandonati nell’arte. Alcuni cenni nella letteratura, nella pittura, nella scultura, nel cinemaNel corso del XIX secolo, gli scrittori hanno iniziato a narrare storie che coinvolgono bambini, evidenziando le pessime condizioni in cui vivevano e le decisioni che i genitori attuavano. Charles Dickens, uno dei più noti scrittori inglesi dell’epoca, ha raccontato storie complesse che delineavano gli aspetti negativi della società, come la povertà, il lavoro minorile e l’infanzia abbandonata. Un suo celebre romanzo del 1837, “Le avventure di Oliver Twist”, è un esempio di denuncia sociale, non meno importante dell’altro suo capolavoro “Grandi Speranze”, dove il personaggio centrale è sempre sottolineato con commozione. Emergono in entrambi i romanzi lo stato di disagio e di abbandono dei fanciulli che da soli dovranno far fronte alla sopravvivenza, privi dei loro genitori, fin da piccoli attraverseranno una serie di imprevisti, che renderanno questi esseri piccoli di età ma già adulti per le loro esperienze. Alla letteratura inglese di denuncia si associa anche quella francese con un altro capolavoro dedicato alle difficoltà di vita dei bambini soli e abbandonati, “Senza Famiglia”, romanzo di Hector Henri Malot. Infine, sempre nell’ambito delle citazioni, non poteva mancare per la letteratura italiana, in particolare, un bel racconto di Giovanni Verga, Rosso Malpelo, drammatica vicenda di un bambino che si ritrova a lavorare in miniera e che subisce le angherie dei suoi amichetti.
Ebbene su questi semplificativi tracciati letterari del XIX sec. si associano rappresentazioni pittoriche e scultoree di artisti che si sono resi celebri con specifici riferimenti figurativi.
Nella pitturaFilippo Carcano (1840-1917), autore di una pittura riguardevole dal titolo, “Operai in riposo”, dove emerge la pietà dei bambini, stanchi, coperti da stracci, a piedi nudi, seduti e sdraiati per terra, che godono di un po’ di riposo (1887). Cirillo Manicardi (1856-1925), pittore emiliano che denuncia anche lui lo sfruttamento del lavoro minorile, con un bel quadro, “Nel casello”, dove un bambino piccolo sale su un piedistallo e gira il gigantesco mestolo nel grande bacile del formaggio (fine XIX sec.).
Ed ancora il pittore Adolfo Tommasi riflette sulla tela l’immagine di due giovani fanciulli in barca sul fiume che si recano a caricare la rena, “a far rena” (1882). E poi ancora Onofri Tomaselli che con un dipinto “La solfatara” rende ragione dello sfruttamento minorile in Sicilia, facendo emergere una violenza del lavoro che ruba l’innocenza della fanciullezza, quadro di notevole espressione drammaturgica (1905). Altro dipinto che rende dell’uso del fanciullo nelle molteplici forme lavorative, “La fruttivendola” di Emilio Longoni, dipinto del 1891 che evidenza come anche le bambine siano in stato di sfruttamento per lavori non adatti alla loro condizione.
Infine citiamo, Enrico Crespi (1854-1906), il pittore degli umili, che ebbe la sfortuna di essere lui stesso orfano, ma la fortuna di essere stato allevato in una famiglia agiata che gli consentì di poter crescere in uno stato di benessere. Un suo dipinto sui fanciulli si richiama ai bambini in chiesa (1897).
Nella sculturaTra i più noti che hanno realizzato sculture a soggetto infanzia e adolescenza Vincenzo Gemito, Giovanni De Martino, Achille D’Orsi, Vincenzo Cinque, Giovanni Varlese, Gabriele Parente, Giovanni Aurisicchio, Bernardo Balestrieri, Menardo Rosso.
Nella scultura bronzea napoletana ricorre frequentemente: Il Pescatorello, l’Acquaiolo, Pastorello, Cipollaro, Scugnizzo.
Per dare una sufficiente idea, citiamo tre scultori napoletani che hanno, attraverso la loro produzione artistica, inciso profondamente nella rappresentazione dei fanciulli nelle condizioni di povertà: Vincenzo Gemito (1852-1929), Giovanni De Martino (1870-1935) e Vincenzo Cinque (1852-1929).
Gemito nasce a Napoli e viene lasciato dalla madre nella ruota dell’Annunziata. La ruota che dal suo triste fascino, come abbiamo visto, si rese una delle più note d'Italia, e anch’essa non venne più utilizzata dal 22 giugno 1875. Gemito, il più rappresentativo e capostipite degli artisti napoletani, condiziona attraverso lo stilismo esecutivo delle sue opere, l’arte di Cinque e di De Martino, collocando nel volto dei fanciulli, la dolcezza, l’innocenza, l’ingenuità, il sorriso, la scaltrezza, la tristezza. Un’applicazione emotiva che genera e restituisce alla pietà popolare la consapevolezza della propria condizione, dalla quale comunque è insita la speranza di un futuro migliore.
Il tema dominante di Giovanni De Martino e della sua produzione, a differenza degli altri scultori, fu soprattutto l’infanzia. In particolar modo furono rappresentati nelle sue opere bambini pensosi, tristi, scarni, sui cui volti affioravano i segni dell’abbandono, della sofferenza. De Martino divenne noto con il soprannome di “Lo scultore di Bambini”. Alcune sue sculture in bronzo riprendono il bambino con tanto di sigaretta tra le labbra. Altri sono pescatori con tanto di cestino e canna da pesca.
Vincenzo Cinque esprime ancor meglio questa condizione. Una delle sculture che ricorre frequentemente è l’acquaiolo, il genere è fortemente rappresentativo, oltre che per la ragione del lavoro minorile, anche perché esprime una condizione sociale di come l’acqua fosse un bene così prezioso, tanto che questo lavoro si meriterà la palma del più ricercato ed esclusivo lavoro da strada.
Di mattina prestissimo, gli acquaioli caricavano sul carretto le anfore e i barilotti carichi d’acqua da bere. Il mestiere era particolarmente remunerativo d’estate, quando il caldo intenso del clima napoletano creava sempre una folla di passanti che, per poche piastre, si assicuravano una bella bevuta di acqua fresca. Gli acquaioli più ricercati appartenevano al Rione Santa Lucia, luogo naturale per la ricchezza di sorgenti dalle cui fontane sgorgava acqua frizzante, proveniente dalla fonte del Monte Echia, l’acqua delle mummarelle che tutti i napoletani amavano. Un bel dipinto di Vincenzo Migliaro, ci dà uno spaccato del rione di Santa Lucia, dal quale la vita e l’intensità del quartiere caratterizza in modo antropologico la napoletanità.
Il chiosco dell’acqua fresca, noto anche come “banca dell’acqua”, rappresentava un traguardo sociale: una garanzia di posto fisso per l’acquaiolo e per tutta la sua dinastia.
Addirittura capitava di leggere nei testamenti le maledizioni alle quali sarebbero andati incontro i parenti eredi che volevano cedere il chiosco.
Il cinemaIn questo ambito artistico, l’espressione cinematografica a mezzo dello scorrimento delle immagini per giunta replicate più volte sullo schermo, ha consentito di far conoscere una serie di problemi e condizioni di vita della società in generale, con notevole rapidità e realismo ad una moltitudine di cittadini inimmaginabile.
PremessaNei decenni scorsi il cinema è risultata l’arte più seguita e ascoltata, oggi soppiantata da altri linguaggi tecnologici, ma che fino a ieri era in grado di condizionare con film di profonda valenza antropologica, scelte anche politiche di rilevanza sociale. I diritti civili, ad esempio, ne sono una testimonianza diretta: attraverso storie e soggetti che trattavano il dramma del divorzio il cinema ha accelerato una conquista in tal senso. Non solo, ma a ben guardare decine di pellicole sono il portato di contenuti sociologici, che racchiudono e spiegano le più impensabili combinazioni negli atteggiamenti enigmatici di una umanità quale quella italiana che usciva dalla seconda guerra mondiale sconvolta, ma desiderosa di dimenticare e affrontare con serenità il futuro. Ed è appunto la corrente neorealista, in specie quella filmografica, che meglio saprà interpretare la nuova formulazione di mentalità e di adattamento trasposta soprattutto nei dialoghi delle sceneggiature, nella fotografia e in primi piani di ripresa, che ci introduce con maestria nel complesso delle psicologie collettive. Ciascun individuo e quindi ciascuna unità psicologica che si auto condiziona e contamina come in un domino, consentendo, drammaticamente, nella somma complessiva di ottenere una forza propulsiva che, ad esempio, per contrapposizione e reazione condusse al Boom economico degli anni sessanta. Una riuscita operazione di estetica sociale, dove l’antropologia culturale interagisce nella complessità delle proprie origini e condiziona a cascata, in forma d’incoraggiamento, la sfida a vivere. Non solo, ma non vengono escluse, all’interno di questi insiemi psicologici, collocazioni personali e individuali che in alcuni casi hanno espresso punte d’intuizioni geniali che sono divenute esempi di emulazione, altre invece hanno trascinato e risentito tragicamente di eredità psicologiche conseguenti ai traumi della guerra. Stati psicopatologici di lieve media e grave entità, che contenevano angoscia, paura, terrore generati, ad esempio, dai bombardamenti vissuti, magari al buio, in affollati ricoveri sotterranei. In questo coacervo di input mentali e di pensiero, non possono essere sottratte spiegazioni che si ricavano dai presupposti di vivibilità in funzione di luoghi spesso isolati, in famiglie e comunità ristrette. In territori a volte distanti decine e decine di chilometri da villaggio o centro abitato con insufficienti servizi di assistenza, dove le relazioni di confronto potevano consumarsi in un emporio, una piazza, una chiesa, un ritrovo creativo. Limitazione che rispecchia modalità di adattamento sul posto, con linguaggio in genere ridotto a pochi vocaboli, fatto più di segni che di parole, queste per giunta in dialetto, relazioni di gruppo e inter gruppo con tempi ed azioni ridotte. L’ambito religioso appare poi determinante, influenza in modo incidente lo spirito ed esalta l’incriminazione del peccato della carne, della gola, della lussuria, vizio capitale costantemente ricordato. Infine, non di poco conto, il matrimonio tra parenti stessi, aspetto quest’ultimo che in alcune comunità isolate aveva raggiunto punte ragguardevoli. Un humus, quello dei vincoli ambientali territoriali e familiari, che si auto-assorbe per naturalità delle mentalità emanate, spiralizzato su sé stesso. Tutto ciò rende e plasma il cervello col percepito a disposizione. Le conclusioni che se ne ricavano rendono ragione di una mentalità, quella italiana, che nel bisogno di riprendersi dalla terribile guerra e dai morti persi in ciascuna famiglia, apre ad uno spiraglio di fiducia, per una nuova speranza. Ebbene questa breve analisi possiamo anche spiegarla associandola e riconducendola a momenti e orientamenti storici ben precisi, non certamente in questa epoca travolgente e rivoluzionaria in cui le innovazioni e gli aspetti tecnologici rendono la comunicazione una fonte di interrelazione continua tra gli individui. Gli ambiti psicologici e psichiatrici, oggi, sono molto dipendenti da fenomenologie di economie di mercato globale, dalle nuove tecnologie comunicative, da contaminazioni incessanti di emulazione, così che un’analisi identificativa di uno stato coscienziale risulta falsata per il multilivello che si verrebbe a rappresentare nella strutturazione della personalità. Occorre forse guardare ad una nuova sociologia, gli stati comportamentali sono dipendenti, con oscillazioni repentine, sia da influenze d’ordine politico che da influenze di modelli proponibili per le più convenienti speculazioni sociali interumane e per i migliori mercati ipertecnologici globali. Ne sono prova le dinamiche di mercato soggette oramai ad analisi di psicologia del lavoro, di marketing, o come in alcune industrie dove è preferibile una dirigenza che abbia, oltre alla laurea in economia, una laurea in filosofia o psicologia.
Siamo ben lontani dal fotografare la psicologia della fine del XIX e di tutta quella del XX secolo, per la semplice ragione che questa psicologia si attagliava soprattutto a società borghesi di tutto il novecento, in comunità di individui di città ricche, dove il sogno era la favola ricca della trasposizione degli usi e dei costumi dell’agiatezza. Abitudini e mode che non erano altro che la maschera adottata, per un necessario allontanamento dalla paura, da individui annoiati, per rifiutare e dissociarsi dal mondo della miseria. La contrapposizione del mondo operaio e borghese in termini psicologici è stata ben interpretata esaltando ancora di più le incrostazioni caratteriali dell’uomo prodotte dall’era industriale.
Il mondo degli adulti e i riflessi della reattività alla sofferenza dei bambini. Vulnerabilità del percepitoIn questa direzione vanno comprese tre opere cinematografiche a firma di Vittorio De Sica, che a mio avviso denotano e contengono un vero manuale di “igiene mentale” che riversa nell’infanzia una costellazione di disturbi davvero puntuali e ben spiegabili. Il regista è stato in grado di mettere a nudo l’intera fragilità del fanciullo nella sua fluida costruzione mentale, di strutturazione personale, e di adattamento psicologico verso gli adulti. L’adattamento del bambino di fronte ad un evento che vive come un trauma interiore, due aspetti questi che, tradotti nella fragilità caratteriale, vanno ad inserirsi nel precario equilibrio di quei mattoncini che vanno ad edificare o meglio strutturare la futura personalità. In questa composizione edificatoria si immettono tra l’altro dosaggi di valore sentimentale direttamente acquisiti dall’affettività genitoriale. Ebbene, se in questo trasferimento compaiono elementi interferenti esterni, il dosaggio di assorbimento affettivo ne risente come disturbo edificatorio. Tanto quanto questa interferenza è intensa e incidente nel tempo, tanto grave potrà essere l’esito di atteggiamento o manifestazione del disturbo. Esempi sono piccole nevrosi come tic, grandi nevrosi con isolamento, iper-eccitazione ecc…. Tornando alle nostre riflessioni “cinematografiche”, Vittorio De Sica nella trilogia filmografica “Sciuscià”, “Ladri di Biciclette” e “I Bambini ci guardano” riesce, a mio avviso, a far emergere attraverso la vulnerabilità dell’infanzia, tutta l’ipocrisia degli adulti. Per “Sciuscià” e “Ladri di Biciclette” è il più schietto e autentico neorealismo, la società è spogliata dai suoi orpelli ipocriti, il re è nudo.
In “Sciuscià”, tratto da un soggetto di Giulio Cesare Viola (premio Oscar), De Sica immette nella fragilità del bambino la reattività alla sopravvivenza ingegnata con gli espedienti più impensati, anche nella illegalità. Emulazione e competizione col mondo degli adulti, per raggiungere e trasformare un sogno, l’aspirazione del cavallo bianco quale affermazione della propria forza, esserci ed esistere. Si associa nella storia l’elemento complementare che consente ai suoi compagni di far emergere le complicità che nascono e che sotto intendono ad un codice di significazione. Si rafforzano le psicologie caratteriali, che da fanciulli di strada soli e abbandonati, piccoli di età ma adulti di esperienza, (fumano una sigaretta), si confronteranno anche con la tragedia della morte di un loro amico. Toccante e ben descritta la casa mandamentale minorile dei discoli di Porta Portese. Ricordo che verso la fine degli anni sessanta, chi si trovava ad aspettare il tram, la circolare rossa che attraversava tutta Roma, poteva ascoltare i discorsi dei genitori che stazionavano sulla pensilina di Porta Portese, coi figli affacciati tra le inferriate delle finestre.
“Sciuscià” è stato un film che fu visto per ben due affollatissime proiezioni, la sera della notte bianca del settembre del 2005, esattamente nell’interno del piccolo carcere. La prima proiezione fu preceduta da una performance di alcuni bambini di circa dieci anni che con i capelli rasati a zero, in calzoncini blu e canottiera bianca correvano nella grande sala centrale, entravano e uscivano velocemente dalle cellette, per ritrovarsi poi insieme, annunciare il film e salutare. Fu grande la sorpresa e grande lo stupore del pubblico.
Nel film “Ladri di biciclette” il bambino acquisisce la disperazione del padre, che avendo subito il furto della sua bicicletta in uno sfondo di una periferia romana del dopoguerra, tenterà di rifarsi nascostamente dal figlio rubandone lui una stessa. Purtroppo verrà fermato, ma poi rilasciato innanzi a una manifestazione di pietismo compassionevole che il bambino suscita al derubato e agli altri presenti. Il bambino, di fronte all’umiliazione subita, associa elegantemente alle lacrime, la sua manina che stringe quella del padre. E mentre si allontanano, restituisce nel breve istante di uno sguardo, in un insito rapporto paritario, il desiderio e la forza del riscatto e il coraggio ad andare avanti.
Nel terzo film, girato in epoca fascista, i termini sono capovolti, la trasparenza e l’innocenza del candore del bambino, vengono violati dal tradimento, l’adulterio della mamma, amante di un altro uomo. Il bambino, assiste a questo drammatico inganno, è minato uno dei riferimenti di affettività, pilastro fondamentale nell’elaborazione del sentimento del vincolo genitoriale. Aspetto frequente nei tradimenti coniugali in cui il bambino non regge più sulle solide sicurezze. Il suicidio del padre sancirà una rapida crescita nel mondo degli adulti e l’odio verso la madre. È perso il valore della fiducia, quindi la sottomissione al dolore e alla diffidenza del tradimento saranno aspetti col quale misurerà, sostituirà e modificherà molti comportamenti di relazione.
Un quarto film di De Sica, “Il Giudizio Universale”, in un episodio dedicato ai fanciulli venduti alle ricche famiglie americane, denuncia nuovamente lo stato di debolezza di diverse famiglie povere e numerose costrette loro malgrado a cedere i bambini in quanto impossibilitati a farli crescere. Intorno agli anni cinquanta e per un decennio circa, in effetti ci fu la compravendita di bambini verso gli Stati Uniti, gestita da un’organizzazione che sotto l’egida del Vaticano garantiva le sistemazioni presso famiglie di buone condizioni economiche. Circa diecimila di loro andarono oltreoceano.
Infine citiamo un altro film, “Le regole della casa del sidro”, di Lasse Haltron, dove la storia riprende la vita in un classico brefotrofio, nel quale si ripete lo schema di solidarietà e complicità che vivono i fanciulli abbandonati, in attesa che qualche famiglia possa adottarli. L’immagine della solidarietà li unisce, ancor più di un vincolo di sangue, tanto che ogni qual volta si presenteranno i futuri genitori, questo momento di distacco sarà vissuto con dolore, sperando che nessuno venga scelto/a, proprio loro che vivono fin da neonati l’abbandono e la sofferenza della loro esistenza. Toccante il piccolo cimitero annesso al brefotrofio.
Prof. Gaspare Baggieri, Conservatore del Museo dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria. Consigliere Scientifico dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria. Già Direttore del Museo dell’Alto Medioevo, Roma
Per la corrispondenza: gasparebaggieri@gmail.com
BIBLIOGRAFIA
AA. VV. Mater: Incanto e disincanto d’amore. Roma: Ministero per i Beni e le attività Culturali, 2000.
Baggieri G. La malattia della vergogna. Una notte da Venere, il resto della vita con Mercurio. Catalogo della Mostra, Museo della Civiltà, Museo dell'Alto Medioevo 'A. Vaccaro', Roma, 19 aprile - 30 giugno 2019. Ragusa: Edizioni di Storia e Studi Sociali, 2019.
Baggieri G. Come eravamo. In: Baggieri G, Di Giacomo M. Il terribile vento dei flagelli epidemici. Roma, Collana Il Setaccio di MeIAMI, 2007.
Lecaldano P. I grandi maestri della pittura italiana dell’ottocento: con gli artisti più rappresentativi di tutte le correnti pittoriche del secolo. Vol. II. Milano: Rizzoli, 1960.
Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per le Marche. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche. Fuori dal guado, molto lavoro nel cuore delle Marche. 24 agosto 2016, 26/30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017. Redazione Scientifica Furst F, Birrozzi C, Confort A, et al. Numero 0. https://www.marche.beniculturali.it/getFile.php?id=486.