Anno Accademico 2024-2025
Vol. 69, n° 1, Gennaio - Marzo 2025
Seduta Commemorativa
12 novembre 2024
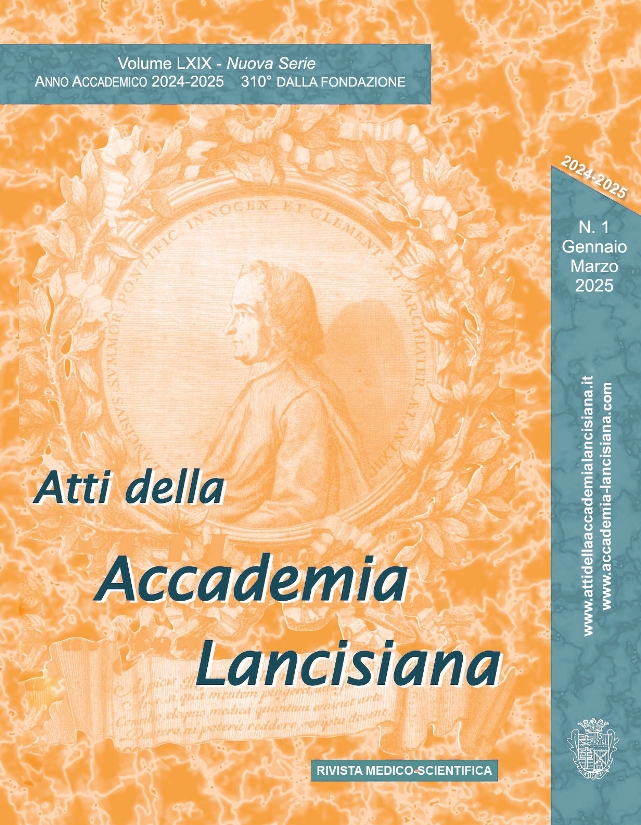
Dirigente Medico U.O.C. Malattie Infettive – Epatologia, INMI “Lazzaro Spallanzani” IRCCS, Roma
Seduta Commemorativa
12 novembre 2024
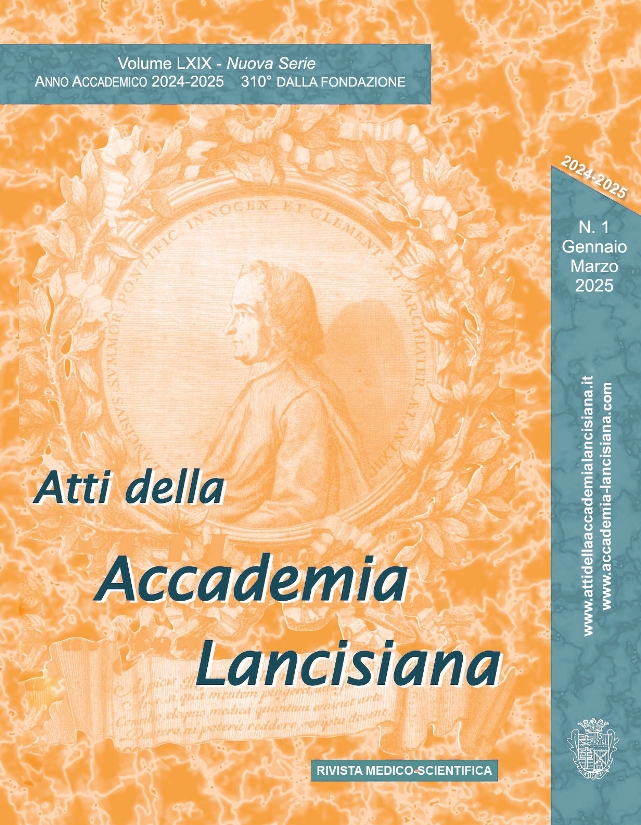
Versione PDF dell'articolo: Download
 |
| Prof. Giuseppe Visco. |
1927 Nasce a Sorrento il 28 ottobre. Gli vengono dati vari nomi, oltre a Giuseppe, eredità del nonno paterno e simbolo della continuità conservatrice della stirpe nonché del bisnonno materno, quello del nonno materno Silvio (in onore dei Gargiulo), Antonino (Santo protettore di Sorrento), Ciro (idem per Vico Equense, luogo di origine dei Visco) e, infine, Quinto, ambiguo richiamo all’anno V dell’era Fascista: un segnale utilizzabile per eventuali benefizi politici ma non compromettente se - come accadde - le cose fossero cambiate.
1929 il padre diviene nominato Commissario Capo e la famiglia si trasferisce a Roma, per rientrare a Sorrento durante i mesi estivi.
1936-1939 Al ginnasio nell’Istituto Massimo (Gesuiti). Forte influenza della SJ e delle letture Missionarie, Comunione quotidiana ma anche - durante l’estate - raccolta di stampe di nudi d’arte, presi dalle riviste del nonno giornalista e artista ebanista Saltovar. Fa il suo primo viaggio, con il padre Questore a Trieste, Venezia e Bellagio. In quei giorni è invasa la Polonia e scoppia la II Guerra Mondiale.
1939 Frequenta il Liceo Giulio Cesare, per la prima volta in classe mista. Ascolta per la prima volta i dischi di Jazz a casa di un compagno di classe.
1940 L’Italia entra in guerra, diviene Balilla moschettiere, va alle adunate a Piazza Venezia.
1943 La guerra va male. Durante un’adunata in divisa a Piazza Venezia con il discorso del “bagnasciuga”; nell’attesa sotto il sole, volano preservativi gonfiati e lanciati in aria (segno di intolleranza). A giugno Sbarco Alleato in Sicilia e la famiglia (a Sorrento, con la madre e le 4 sorelle più piccole) resta separata dal padre che è a Roma. A luglio cade il fascismo. Si ascolta radio Londra con apparecchi a galena e si va a fare ogni giorno la prima colazione da una zia, unica a possedere viveri sufficienti. Sbarco a Salerno. Puntate alternate di truppe USA e di panzer tedeschi a Sorrento. Questi ultimi fanno retate e fucilano, nel ritirarsi distruggono i ponti sui “valloni”. Siamo del tutto isolati. Si fa la fame, non c’è luce e quindi non si fa il pane, che è sostituito dalla polenta a fette ed arrostita ai ferri. “Lo nasconderò in un pozzo, ma i tedeschi non lo prenderanno” scrive la madre. A settembre gli Alleati liberano Sorrento; andiamo in bici con alcuni amici a Castellammare per rifornirci di viveri. Frequenta militari USA inglesi e francesi, impara la lingua inglese ed apprende i principi della democrazia.
1944 Legge libri di letteratura USA. Ultima eruzione del Vesuvio: la penisola è coperta di cenere e il fumo giunge fino a Bari. La Mamma parte da sola (a 36aa), su di una camionetta alleata, in cerca del padre di cui non si avevano più notizie e che pensava fosse stato portato in Germania. Lo ritrova invece sano e salvo a casa, si era fatto crescere la barba, aveva fatto il doppio gioco: Commissario di PS nella RSI e “patriota” nella resistenza badogliana. La famiglia si trasferisce nuovamente a Roma e lui si iscrive al primo anno di Medicina.
1946 Referendum Monarchia/Repubblica: fa propaganda per quest’ultima. A novembre concorso per internato a Patologia Generale, dove conosce mia madre Ubalda Comandini ed inizia a frequentare la casa del padre Federico Comandini, nominato Deputato all’Assemblea Costituente per il Partito d’Azione. Si fidanza con lei andando in treno a Bari a vedere la prima partita internazionale di calcio del dopoguerra: l’amichevole Italia-Cecoslovacchia.
1947 Quarto anno di Medicina. Insieme a Ubalda Comandini vincono il concorso per internato in Clinica Medica di Cesare Frugoni (raccomandati da entrambe le famiglie). In corsia: Aiuto è il Prof. Ferdinando Corelli, Assistenti Giuseppe Giunchi, Sergio Vulterini, Pasquale Ruggieri, Ignazio Liotta, Luciano Lucentini, Giuseppe Pericle Cenci. Studenti Vito Cagli, Anna M. Mangione, Marco Servi. In Laboratorio di Batteriologia: Giuseppe Giunchi.
1948 Alle elezioni vince la DC. Attentato a Togliatti. Il padre Questore, viene trasferito a Treviso.
1949 Iniziano le ricerche di laboratorio con Giunchi sulle colture del virus influenzale e su Coxiella burneti. In Clinica Medica Corelli fa esperimenti anti-cancro nell’uomo di piretoterapia con pirogeni o con infezione aerosol da C. burneti.
1950 Laurea con 110 e Lode.
1951 Vince il concorso di specializzazione in Clinica Medica (mia mamma in Cardiologia), dove quell’anno va via Frugoni ed arriva Di Guglielmo. In Clinica Medica si lavora soprattutto nell’Ematologia.
1954 Monsignor Serafini (amico di famiglia dei Comandini e futura eminenza grigia di Giovanni XXIII) celebra il matrimonio in Vaticano con Ubalda: testimoni i Proff. Moschini e Giunchi.
1955 Si specializza in Clinica Medica
1956 Inizia la Specializzazione in Ematologia. Lavora alla Casa Editrice Luigi Pozzi.
1957 Va via Di Guglielmo ed inizia la dittatura dei calabro-siculi condorelliani in Clinica Medica.
“Gli Invasori” Roma 25.1.57Una viva animazione regnava in quella storica mattina della Festa d’Ognissanti nel salone della Direzione della Clinica Medica Universitaria di Roma. Stava per iniziare la cerimonia dell’insediamento del nuovo Direttore. Aiuti, assistenti, infermieri e studenti ne spiavano l’arrivo con malcelata apprensione.
La venuta del Prof. Condorelli, l’illustre Clinico - che, con corso rapido e brillante, era asceso dalla sua piccola sede meridionale alle più alte vette della carriera accademica - era attesa con sgomento e timore dal personale della Clinica.
Negli anni che avevano preceduto la nomina dell’insigne Studioso non erano mancate le notizie sulle peculiari usanze, sui drastici regolamenti in auge nella Scuola Condorelliana e sulle omeriche sfuriate del Maestro.
Quegli aiuti, assistenti e giovani medici in febbrile attesa erano i figli orfani di un illustre ceppo. La Clinica Medica di Roma aveva conosciuto la sua età d’oro nei 20 anni nei quali era stata diretta dal Prof. Frugoni.
L’attesa nell’atrio della Direzione:
• presentazione al lettore del Prof. Condorelli
• presentazione della Clinica Medica.
L’arrivo:
Condorelli fa il suo ingresso nella Direzione: capannelli, strette di mano, i vecchi tirano un sospiro.
Ma alle 15 arriva una telefonata: tutti accorrano nei Reparti, dove si sono insediati i nuovi arrivati.
La manovra di occupazione è stata perfetta. Viene immediatamente sospesa qualsiasi cura precedente ai malati ricoverati.
1958 Si specializza in Ematologia. Amicizie tra gli intellettuali e i medici del Partito Comunista Italiano in cui non si è mai però riconosciuto.
1959 Si prepara alla docenza. Lavori firmati dopo attese notturne da Condorelli.
1960 Libera Docenza in Malattie Infettive. Ottiene una convenzione con la Cassa Mutua Artigiani ed apre l’ambulatorio a Testaccio, iniziando una interessante esperienza medica, umana e sociale, che durerà oltre dieci anni. Inizia Studio privato alla Clinica Paideia, buona attività privata, anche grazie ai pazienti inviati da Giunchi.
1961 Inizia la carriera di Assistente Medico negli Ospedali Riuniti presso l’Ospedale San Giovanni, Servizio di Cardiologia del Dott. Pala.
1962 Presenta domanda al Concorso di Aiuto Infettivologo a Brescia e si Specializza in Igiene. Missione in Spagna inviato da Berlinguer appena insediato alla Sezione Esteri del PCI, per visitare Grimau, il segretario del PCE, catturato e “defenestrato” dai Falangisti. Hotel Phoenix a Madrid, fughe, depistaggi, incontri-cene notturni. Non riuscirà però a visitare Grimau, ma l’esperienza gli lascerà tracce indelebili.
“La missione segreta a Madrid” nel febbraio 1962Tutto era cominciato un mese prima, quando ero stato contattato, attraverso un’amica, funzionaria della segreteria del PCI, da Giorgio Napolitano, all’epoca responsabile della sezione esteri del Partito.
Mi si chiedeva di partecipare ad una delegazione internazionale di medici ed avvocati - simpatizzanti ma non comunisti - che doveva recarsi a Madrid, in veste ufficiosa.
L’obiettivo era di verificare che a Grimau, (il Segretario del PCE clandestino di recente catturato dalla polizia di Franco) fossero garantiti i diritti civili: quelli legali e quelli sanitari.
Poche settimane prima, durante un interrogatorio della Falange negli uffici alla Puerta del Sol, il compagno Grimau (anticipando di qualche decina d’anni il fattaccio nostrano Pinelli - Calabresi), “in un tentativo di suicidio” (era la versione ufficiale) era stato infatti “defenestrato” dal secondo piano, riportando lesioni e fratture.
Nel 1962 si era all’inizio della fase discendente del regime di Franco, travagliato dai contrasti tra l’ala oltranzista, dominante, e quella “filo-europea”, alla quale si diceva essersi segretamente avvicinato il ministro degli interni Carrero Blanco, e che spingeva per il passaggio del paese alla democrazia.
In questo spazio si inseriva l’iniziativa dei Partiti Comunisti europei (in prima linea di quello italiano, dell’inglese e del francese) a favore di Grimau, per mettere alla prova il regime dominante e dimostrare, se possibile, che la Spagna - dove tuttora vigeva un sistema dittatoriale - non fosse affatto pronta al passaggio.
Come spesso succede quando cose simili sono organizzate in fretta, la delegazione di cui facevo parte, giunta senza intoppi all’aeroporto madrileno, si era poi trovata dispersa e confusa, con i propri componenti non in grado di riconoscersi. Per di più, i delegati erano stati tutti indirizzati all’Hotel Phoenix di Madrid, ben noto ritrovo dello spionaggio internazionale.
Il primo contatto locale fu in un caffè del centro, verso le 23 - l’ora in cui i Madrileni vanno a cena - dopo una serie di procedimenti di identificazione.
Mi venni così a trovare in mezzo ad un allegro gruppo di giovani, simpatici ed entusiasti ma anche molto “professionali”, con i quali solidarizzai, comunicando in uno spagnolo maccheronico.
Quando, più tardi, fummo raggiunti dal delegato francese e da quello tedesco, vennero fatti i piani per l’indomani e spiegate alcune semplici tecniche di sicurezza.
Che, ad esempio, le telefonate dovevano esser fatte solo da posti pubblici e che, quando si voleva raggiungere un obiettivo “riservato”, essendo in pratica disponibili soltanto i taxi (peraltro inaffidabili), se ne dovevano, ogni volta, utilizzare almeno tre in successione, tenendo distanti i luoghi di discesa da quelli di entrata.
A questo punto, il gruppo era pronto all’azione.
L’indomani si verificò un episodio che avrei ricordato a lungo.
Mentre ci si attardava nella hall dell’albergo, in attesa del previsto contatto con Pachito (uno dei ragazzi della sera prima), mi si avvicinò uno spilungone sconosciuto che, chiamandomi per nome, mi bisbigliò “di fare molta attenzione perché circolavano nella hall alcuni importanti agenti dei servizi di sicurezza della Falange”.
Non se ne conosceva il motivo essendo, la loro presenza, sproporzionata all’importanza della nostra delegazione. Dovevano essere, in ogni caso, “seminati” e sarebbe stato lui la mia guida, al posto di Pachito: ero invitato a seguirlo in tutti i modi.
Uscendo, mi chiedevo cosa avesse voluto intendere lo spilungone con quell’ “in tutti i modi”, ma la spiegazione arrivò ben presto.
Era una rigida mattinata di primavera, con una pioggerella gelida che mi sferzava il volto; lo spilungone, uscito dall’albergo, si avviò a destra, a piccola corsa e con lunghe falcate. Facevo fatica a seguirlo, in salita e contro vento: non ero un atleta e maledicevo i miei chili di soprappeso.
Una nuova emozione si aggiunse poi quando mi resi conto che due sconosciuti, che già aveva notato nella hall dell’albergo, ci stavano seguendo.
Lo sforzo era notevole (e altrettanta la paura) ma lo spilungone - che, evidentemente, conosceva bene la sua strada - si esibì in una serie di tecniche di sicurezza, entrando avanti e indietro in alcuni cortili a più uscite, salendo e scendendo balconate, con io che a fatica riuscivo a stargli dietro.
Alla fine, però, il successo coronò le loro fatiche: gli inseguitori erano scomparsi e avrei finalmente potuto incontrare, secondo i piani, il nuovo Segretario del PCE clandestino.
Dopo aver preso un paio di taxi, fui allora condotto in un appartamento di una casa popolare, dove conobbi una giovane avvocatessa, dalla personalità molto spiccata, che mi intrattenne a lungo sulla situazione politica in Spagna e sugli scopi della missione.
Nel pomeriggio giunsero due informazioni: il “Giudice n. 6”, che risultava avere in carico l’imputato Grimau, aveva accettato di ricevere la delegazione, il giorno successivo.
Inoltre, era stato chiarito il motivo dello spiegamento in forze, al Phoenix, dei Servizi della Falange: quella mattina era giunto in albergo da Londra il delegato britannico che, non trovando nessuno ad accoglierlo, si era messo a chiedere, in inglese e ad alta voce nella hall, notizie “sulla delegazione che doveva incontrare Grimau”.
In pochi minuti i Servizi erano stati avvertiti e si erano precipitati all’albergo.
La mia serata si concluse, in maniera turistica convenzionale, con uno spettacolo di flamenco, insieme ad alcuni giovani compagni.
L’indomani i quattro delegati e le loro guide si ritrovarono al Tribunale dove furono subito ricevuti dal famoso Giudice n. 6, il quale apparve soprattutto ansioso di comunicare alla delegazione e, attraverso questa al mondo intero, di non avere più alcuna competenza sul detenuto Grimau, essendo stata, questa, avocata dalla Falange che aveva prelevato il detenuto dall’infermeria carceraria e portato al proprio Ospedale Militare, dove sembrava essere tuttora degente.
Forti di questa dichiarazione, la delegazione si rivolse allora al Comando Generale della Falange, dove però fu risposto che non era possibile - al momento - avere alcuna informazione - e tanto meno visitare - il detenuto, che era “sotto interrogatorio”.
Conclusa così la nostra missione, ci trasferimmo a Parigi dove, in una conferenza stampa internazionale, riferimmo sui risultati del nostro viaggio, giungendo alla conclusione che si trattava di una ennesima prova che la situazione politica in Spagna non era affatto stabilizzata e che i diritti civili dei suoi cittadini non erano minimamente salvaguardati.
E questo era l’obiettivo che i vari PC interessati si erano dati per quella missione.
Parecchi anni sarebbero passati prima che quel Paese diventasse una democrazia e nel frattempo il povero Grimau fu condannato a morte e “garrotato”.
“Allacciate le cinture” ordinava il messaggio registrato del comandante del Caravelle, nell’annunciare l’imminente atterraggio all’Aeroporto di Fiumicino.
Sospirai con soddisfazione: anche la mia splendida avventura madrilena si concludeva. Trassi di tasca il mio portafortuna, la medaglia regalatami 25 anni prima dallo zio Salvatore, che anche questa volta mi aveva aiutato e che aveva incise le due parole: curioso ed entusiasta. Gli aggettivi che, da allora, hanno improntato il mio stile di vita.
1963 Ad aprile vince il concorso per Aiuto di Malattie Infettive a Brescia: la famiglia è contraria al trasferimento, ma il prof. Giunchi telefona che deve accettare il posto a Brescia a nome “della più alta autorità del mondo” [sottointende Montini, prossimo Papa e fratello del Presidente degli Ospedali Civili di Brescia]. Si trasferisce a Brescia da solo ma rientra a Roma tutti i fine settimana. Ha come primario Francesco Colonnello (che lo ama e lo apprezza per la sua preparazione universitaria, ma ne è anche un po’ geloso). In pochi mesi si conquista la stima e l’amicizia degli assistenti, lavorando con entusiasmo ed insegnando loro a produrre scientificamente; fa una grande esperienza di meningiti, salmonellosi, tetano e relative terapie intensive. Si specializza in Igiene e Tecniche Ospedaliere.
1964 Si presenta a Giunchi e gli comunica la sua intenzione di rinunciare all’incarico a Brescia e rientrare a Roma: ne riceve una risposta gelida di presa d’atto e da allora non lo chiamerà più per i successivi otto anni, fino al giorno della sua vittoria al concorso di Primario.
Tornato a Roma, riprende servizio, al San Camillo, presso la Direzione Sanitaria con il Prof. Massani.
Inizia la docenza all’ONARMO per Assistenti Sociali e Sanitari. Conosce Sheila Sherlock ed il marito con i quali stringerà rapporti di amicizia e professionali per oltre 30 anni. Inizia ad eseguire biopsie epatiche con ago di Menghini. [Sosterrà, da anziano, di averne eseguite oltre 4000. Non certezze su questo dato, ma di sicuro ha avuto il merito di aver portato in Italia lo studio del fegato all’interno delle Malattie Infettive. Per molti anni faceva lui la valutazione istologica dei vetrini, inviandoli a volte a Londra per una seconda opinione, ma delegò poi lo studio dell’istologia epatica al suo allievo Paolo Guarascio, inviato a Londra per alcuni anni a studiarla].
1965 Inizia il lavoro da Tossicologo, ispirato da un soggiorno all’Ospedale di Malattie Infettive di Parigi ed alla sua Terapia Intensiva, e dall’esempio francese. Si iscrive e frequenta la Specializzazione in Tossicologia Medica a Firenze (Jannaioni). Riceve l’incarico di Aiuto Tossicologo presso il San Camillo ed istituisce il Servizio di Tossicologia di cui diviene Responsabile fino al 1971. Si iscrive al Partito Socialista ed all’ANAAO dove diviene rappresentante del San Camillo ed entra nel Comitato Nazionale.
Tra il 1966 ed il 1970 partecipa a diversi concorsi per primario di Malattie Infettive. Entra nella Commissione Nazionale Sanità del PSI, diretta allora da Claudio Signorile.
1968 Si specializza in Tossicologia.
1970 Partecipa al Concorso del Comune di Roma per un posto di Primario dell’Ospedale Lazzaro Spallanzani, dove Francesco Di Raimondo era incaricato e vince. Arriva secondo, precedendo Carlo De Bac.
HLS era stato il Lazzaretto del Comune: per la spagnola, poi per le malattie da importazione coloniale. Grazie alla pervicacia di Di Raimondo (DC) ed al suo appoggio esterno con il PSI, riescono a distaccare l’Ospedale dal Comune di Roma.
L’appoggio di Signorile fu essenziale per accelerare la trasformazione dello Spallanzani in un vero ospedale e lo sdoppiamento del posto di primario: Gianni de Cesare (allora Commissario Straordinario) lo realizzò, con l’aiuto del Direttore Amministrativo Bruno Primicerio. Ambedue sono stati tra i suoi amici più stretti per i decenni successivi.
1970 Viaggio a SOFIA al Congresso della Confederazione dei Sindacati Medici in una delegazione CGIL, si visitano fabbriche di farmaceutici, dove gli italiani inorridiscono per l’arretratezza delle protezioni e sicurezze dei lavoratori. Sofia è moderno - sovietica e di scarso interesse.
1971 Viene creato l’Ente Ospedaliero Lazzaro Spallanzani e gli viene conferito l’incarico di Primario della II Divisione, nel Padiglione al quale fece dare il nome di “Pontano” (l’altro “Del Vecchio” a Di Raimondo ed il Laboratorio “Fleming”, che sarà diretto da Vittorio Ortali proveniente dall’ISS; a lui seguiranno Fantoli e Paola De Felice).
1973 Epidemia di Colera a Napoli, 5 malati vengono trasferiti allo Spallanzani.
1974 Nominato Responsabile del Servizio di Igiene della ASL RM10.
La II Divisione inizia ad occuparsi in modo dedicato alle epatiti virali.
1980 Viaggio in Palestina, per verificare le condizioni sanitarie nei Campi Profughi Palestinesi. Incontra Arafat.
1988-1990 Nominato Membro della Commissione Nazionale AIDS.
1989 Inizia collaborazione tra Spallanzani e Villa Maraini. È tra i soci fondatori dell’ANLAIDS. Diviene consulente del Ministro della Salute.
1990-1995 Professore a contratto di Malattie Infettive nella Cattedra di Cardiochirurgia dell’Università Tor Vergata.
1993 Organizza con lo Spallanzani e ANLAIDS l’“International Workshop on Positive Spin-offs of HIV epidemics on the progress of Science”.
1994 Professore a contratto di Malattie Infettive presso Università La Sapienza.
1995 La Guardia di Finanza perquisisce la casa cercando cartelle cliniche dell’ospedale. Al fatto viene dato risalto mediatico ed il Direttore Generale rigetta la domanda di restare in servizio fino a 70aa.
Lascia quindi la Direzione della II Divisione dello Spallanzani, nella quale hanno lavorato a vario titolo: Giulio Cesare Leoni, Franco Zechini, Guido Tocci, Valerio Tozzi, Pippo Noto, Paolo Guarascio, Carlo Struglia, Evangelo Boumis, Pietro Sette, Lino Narciso, Riccardo Giannuzzi, Fabrizio Ferri, Pietro Balestra, Sergio D’Amato, Susanna Grisetti, Lucia Alba, Elide Tornese, Severini, Chiara Carvelli.
1996 Istituisce l’ambulatorio di Epatologia presso la Clinica Santa Famiglia.
2000-2002 Inizia l’ambulatorio alla Casa di Cura San Feliciano, a Villa Carla e diviene poi Direttore Sanitario per oltre un decennio della Clinica Parioli.
Diviene Presidente del VII Distretto del Rotary Club.
2001-2008 Consulente epatologo del Centro Trapianti di Fegato del Regina Elena.
Fino al 2019 continua a lavorare come medico privato.
Nel corso della sua carriera ha prodotto alcune centinaia di pubblicazioni scientifiche o divulgative, in tutti gli ambiti medici di cui si è occupato. In Pubmed risultano 112 pubblicazioni come primo o ultimo nome.
2018 Dal suo “Testamento Spirituale”:
Terminerò i miei giorniLa vita è il dono privilegiato
Ho auto una vita felice e molto fortunata: mi rendo conto di questo enorme privilegio.
Da mio padre ho appreso il senso del dovere e il rispetto per le Istituzioni; da mia madre quello dell’avventura: curioso e avventuroso è il motto che ho scelto per definirmi.
Vengo da una bella famiglia, con i miei 4 fratelli che mi sono stati sempre vicini e con i quali posso dire di non aver mai avuto una lite.
Attraverso mia moglie - unica, meravigliosa, insostituibile - e la Sua Famiglia mi sono accostato ai principi della vita civile, della tolleranza, della laicità, dell’etica al di fuori della fede (superando le Loro stesse posizioni, sul piano della ragion pura).
Purtroppo da Ubalda non ho saputo apprendere anche la virtù di dire la verità a qualsiasi costo: un principio che, però, per fortuna mio figlio Ubaldo ha ereditato. Insieme a Lei ho imparato a godere dei viaggi e soprattutto dell’arte, in tutte le sue forme, accostandoci con umiltà e interesse alle cose nuove: anche a quelle che, di primo impatto, ci sembrava di non capire.
Ho amato intensamente mia moglie, nonostante le tante trasgressioni: questo - anche e soprattutto - grazie alla sua immensa comprensione e tolleranza (guidata, magari, anche dalla sua filosofia: aspetterò sulla riva del fiume e vedrò passare i cadaveri dei miei nemici).
La Sua perdita è stata immensa e mai colmata: da allora la mia vita ha perso interesse e sono caduto in una grande solitudine: un fatto nuovo per me, che non avevo conosciuto la depressione.
I miei figli ed i miei fratelli mi hanno aiutato, con successo, a riempire questo vuoto.
Debbo anche ricordare la parte importante della vita dedicata alla mia professione. Penso che sia una grande fortuna quella di svolgere un lavoro gradito: per me è stato entusiasmante. Mi sono dedicato alla Medicina con passione ed in modo globale: nell’apprenderla, nel ricercare, nell’applicarla curando gli altri e nell’insegnarla ai più giovani. Ne ho tratto grandi soddisfazioni ma, soprattutto, ho avuto la sensazione di aver fatto qualcosa di utile per gli altri.
Insomma, voglio ringraziare tutti per quello che mi hanno voluto e saputo dare - ciascuno a suo modo - in questa fase triste della mia vita.
Quando mi leggerete, sarò tornato ad essere polvere nel Cosmo ed anche il ricordo del mio passaggio - come per tutti - presto svanirà. Resta per me la coscienza di un’esistenza che davvero valeva la pena di vivere.
Dott. Ubaldo Visco Comandini, Dirigente Medico U.O.C. Malattie Infettive – Epatologia, INMI “Lazzaro Spallanzani” IRCCS, Roma
Per la corrispondenza: ubaldo.viscocomandini@inmi.it