Anno Accademico 2024-2025
Vol. 69, n° 1, Gennaio - Marzo 2025
Simposio: Rischi dell’uso e dell’abuso della cannabis
26 novembre 2024
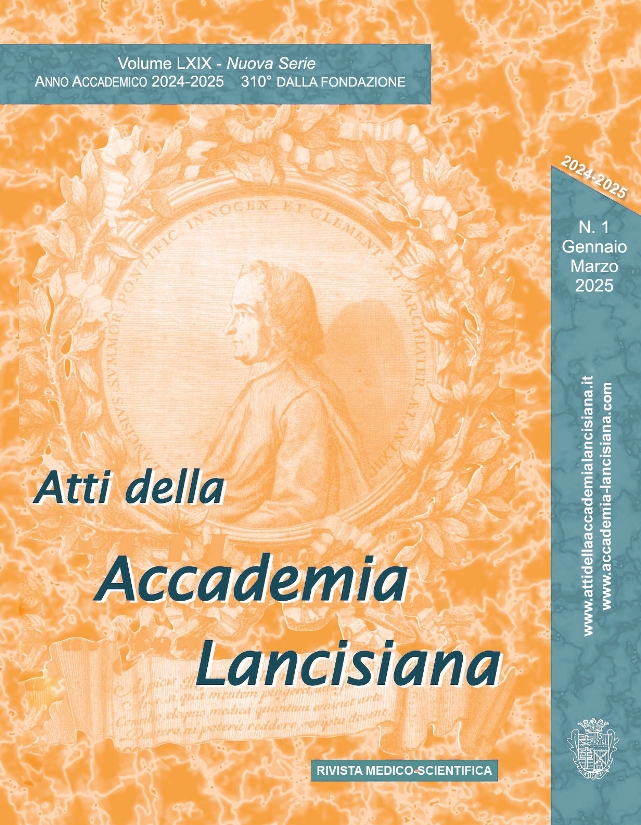
Professore Ordinario di Neurofarmacologia, Sapienza Università di Roma
Simposio: Rischi dell’uso e dell’abuso della cannabis
26 novembre 2024
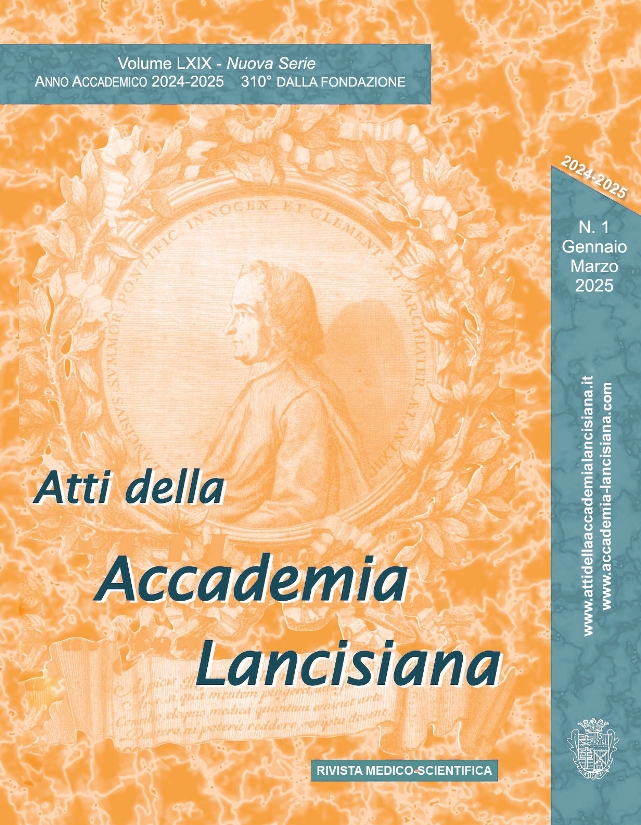
Versione PDF dell'articolo: Download
L’Ordine dei Medici di Roma da circa 3 anni ha istituito una Commissione presieduta dal Prof. Antonio Bolognese per studiare e far conoscere i pericolosi effetti delle Dipendenze, con particolare riferimento ai danni dovuti all’assunzione di cannabis.
La Commissione ha molteplici scopi.
Innanzitutto quello di dare una corretta informazione scientifica nei media, nei social e, più in generale, nei mezzi di comunicazione, al fine di cercare di evitare la disinformazione e la banalizzazione del tema nella nostra società.
Secondariamente, si vuole formare tutti gli operatori sanitari, iniziando ovviamente dai medici, sugli aspetti clinici legati al mondo delle droghe con particolare riferimento alle novità dei prodotti di sintesi che il “mercato della morte” produce con sempre più rapidità.
Il Convegno di oggi, si inserisce in pieno in questo progetto.
I dati dell’ultima relazione parlamentare sulle droghe e sulle tossicodipendenze sono preoccupanti.
Nel biennio 2022-2023 è stato registrato un aumento dei consumi di sostanze stupefacenti, che sono tornati ai livelli prepandemici: 4 giovani su 10 tra i 15 e i 19 anni hanno assunto una sostanza stupefacente almeno una volta nella vita.
Nel 2023 ben 516mila studenti, il 34% di tutti quelli tra i 15 e i 17 anni, ha detto di aver consumato almeno una volta una sostanza illegale, mentre il 4,5% ne fa un uso frequente.
La cannabis è la sostanza illegale più usata dai giovaniTra le sostanze illegali, la più usata è la cannabis, seguita dalle nuove sostanze psicoattive e poi cannabinoidi, stimolanti, anabolizzanti, oppiacei. Per quanto riguarda la cannabis, 265mila ragazzi tra 15 e 17 anni, il 17% del totale, hanno riferito di averne fatto uso nel corso del 2023, con valori tornati a prima della pandemia. Un dato su cui richiamo l'attenzione è l'aumento della percentuale media di principio attivo. Negli anni 70 il THC (la sostanza psicoattiva della cannabis) viaggiava tra l'1 e il 2%. La concentrazione media nei sequestri di hashish è passata dal 17% nel 2018 al 25% nel 2023. Anche l'1% in età evolutiva può avere effetti gravi, invito quindi ad estrema cautela nel definire leggera una sostanza che ha il 25% di principio attivo. Anche il GHB, la cosiddetta droga dello stupro, è considerata leggera: si tratta di una sostanza che, se somministrata in maniera controllata, ha effetti positivi sui disturbi del sonno e sul trattamento dell'alcolismo, mentre è fonte di pericolo l'uso non sotto controllo medico.
Cannabis: fatti e misfatti
La cannabis ha effetti negativi sui giovani e non può essere considerata una droga innocua. Da molto tempo si discute sulle conseguenze dell’utilizzo di cannabis in età giovanile, soprattutto da quando il suo consumo per uso ricreativo è stato liberalizzato in diversi Paesi del mondo e anche europei, tra i quali Danimarca, Malta, Lussemburgo e Germania.
La cannabis, dopo l’alcool e il tabacco, è la sostanza psicoattiva più diffusa in Italia, in Europa e nel mondo. Numerose sono le fonti di rilevazione che hanno chiarito e ripetutamente confermato come il consumo di questa sostanza nella popolazione scolare sia un fatto consolidato e paragonabile a quello degli adulti.
Da quanto si evince dall’ultima relazione annuale sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia, sono poco meno di 600.000 gli studenti italiani tra i 15 e i 19 anni che ne fanno uso; l’impiego è più frequente, anche in senso quantitativo, tra i maschi rispetto alle femmine.
Le implicazioni legali, sociali ed economiche del consumo e della diffusione della cannabis variano a seconda dei Paesi e dei contesti culturali. Le evidenze scientifiche riguardo alla sua pericolosità e al suo abuso sono invece concordi e indipendenti dagli ambiti di rilevazione.
I componenti della cannabis che hanno un effetto sul corpo umano sono due: il THC (delta-9-tetraidrocannabinolo) e il CBD (cannabidiolo). Questi due cannabinoidi presentano medesima formula chimica, ma diversa struttura molecolare. In modo semplicistico si può affermare che il THC, il principale composto psicoattivo nella cannabis, è responsabile della sensazione di "sballo", mentre il CBD non ha conseguenze sulle funzioni psichiche, ma ha effetti antalgici e ansiolitici, utili in situazioni specifiche ai fini terapeutici.
Il THC si lega facilmente a un recettore, chiamato CB1, e conseguentemente esercita effetti psicotropi alterando e influenzando emozioni, attenzione, ricordi, umore, comportamenti e capacità intellettive. Il recettore CB1 è presente in misura maggiore nel cervello dei giovani rispetto a quello degli adulti, specie nelle aree associate alla memoria e ai processi decisionali. Legandosi al recettore CB1, il THC modifica il rilascio dei neurotrasmettitori e, a seconda delle aree cerebrali coinvolte, esercita effetti sfavorevoli anche sull’apprendimento, sulla memoria, sulla coordinazione motoria e sull’equilibrio.
Negli ultimi decenni, il contenuto di THC nella cannabis è cresciuto considerevolmente, passando dal 3% al 25/40%. Ciò è da mettere in relazione all’odierna disponibilità di coltivazioni di cannabis dalle quali si ottengono varietà sempre più potenti in virtù di sofisticate tecniche di coltivazione selettiva.
Il legame tra cannabis e disturbi mentali è stato oggetto di numerosi studi che hanno evidenziato come alcune variabili sono da considerarsi fattori condizionanti e determinanti la gravità degli effetti. Le variabili principali sono la frequenza d’uso (occasionale o continuativo), l’età di inizio di utilizzo e la concentrazione della sostanza che viene consumata.
I disturbi psicotici da cannabis sono molto frequenti e comprendono forme gravi, come la schizofrenia, e forme meno gravi, come la perdita di contatto con la realtà, la distorsione delle percezioni, allucinazioni e deliri. Quando tali disturbi insorgono in età adolescenziale o giovanile compromettono lo sviluppo emotivo-cognitivo e la qualità della vita. Numerosi studi, inoltre, danno prove convincenti dell’esistenza di una correlazione tra uso precoce e aumento del rischio di depressione.
È stato anche dimostrato come l'uso ripetuto e cronico di cannabis provoca la sindrome amotivazionale che induce, tra l’altro, ad abbandonare le pratiche sportive abituali, a perdere interesse per tutte le attività ludico-sociali e a compromettere il rendimento scolastico. Gli adolescenti che fanno uso regolare di cannabis hanno il 37% in più di probabilità di andare incontro a depressione in età adulta rispetto a chi non ne fa uso, un incremento significativo del rischio di ideazione suicidaria e un aumento dei tentativi di suicidio.
Numerosi studi hanno evidenziato come il consumo di cannabis, in particolar modo in età giovanile, predisponga all'uso e all’abuso di sostanze illecite più pericolose e ad alto potenziale di abuso. È la cosiddetta gateway hypothesis, peraltro molto controversa e dibattuta, secondo la quale esiste una relazione di natura causale tra l’uso di cannabis e il successivo impiego di droghe più potenti. Alternativamente, può essere considerata la possibilità che la cannabis possa determinare una maggiore vulnerabilità individuale e predisporre all’impiego di sostanze più potenti e pericolose. Un’altra possibilità, infine, è che i soggetti che utilizzano la cannabis abbiano una maggiore opportunità di essere esposti al mercato illegale di altre droghe.
L’ipotesi di una relazione causale tra uso di cannabis e uso di droghe pesanti non è stata finora dimostrata con metodi epidemiologici; studi sperimentali preclinici nell’animale hanno però accertato che un’esposizione ripetuta al THC è associata a un aumento delle proprietà gratificanti e di rinforzo dell’eroina in ratti geneticamente vulnerabili dalle droghe. È però importante sottolineare come altri fattori, come l’ambiente sociale e l’ambito famigliare, influiscano sull’aumento del rischio di consumo post-cannabis di droghe pesanti, in un contesto più generale che deve considerare anche una componente genetica nella propensione alle dipendenze.
In conclusione si può affermare che dai dati attualmente disponibili emerge un’immagine della cannabis meno innocua e tranquillizzante di quella spesso proposta da alcuni organi di informazione e che il suo consumo durante l'adolescenza può avere effetti negativi sullo sviluppo cerebrale, sulla salute mentale, sul rendimento scolastico e sul comportamento sociale. La cannabis, inoltre, può favorire l’insorgenza di disturbi mentali anche gravi nei giovani e negli adolescenti e può, comunque e facilmente, provocare forme di abitudine e fenomeni di astinenza che si manifestano con ansia, irritabilità, angoscia e perdita del sonno. La crescente diffusione della cannabis rende sempre più urgente la necessità di continuare a studiarne gli effetti e di informare e di sensibilizzare il pubblico sui rischi legati al suo uso ricreativo, al fine di proteggere la salute e il benessere degli adolescenti, dei giovani e di quanti ne fanno uso e abuso.
Benefici e rischi della cannabis terapeutica
Una recente rassegna della NIDA (National Institute of Drug Abuse, USA; Volkow ND, Blanco C. World Psychiatry, 2023) presenta dati allarmanti sul consumo di cannabis in termini di prevalenza (200 milioni di consumatori nel mondo) e sui rischi che tale consumo comporta (35% di aumento del rischio di sviluppare schizofrenia nei consumatori settimanali e 75% di aumento nei consumatori giornalieri).
Purtroppo l’evidenza clinica della tossicità del THC e di altre sostanze psicoattive presenti nella cannabis è contrastata dai continui messaggi a favore del consumo di cannabis da parte dei social e dalla presenza di prodotti a base di cannabis utilizzati in terapia. Questo genera il percepito popolare che la cannabis non è nociva e può far bene alla salute anche quando utilizzata al di fuori dei regimi di prescrizione terapeutica.
È dunque utile discutere in quest’ottica l’uso terapeutico dei prodotti a base di cannabis. Esistono farmaci a base di THC e/o cannabidiolo (CBD), quali Sativex ed Epidyolex. Sativex è una combinazione 1:1 di THC e CBD utilizzata per il trattamento della spasticità nella sclerosi multipla. I pazienti elegibili sono per larga parte affetti da forme progressive di sclerosi multipla, in cui la spasticità compromette la qualità di vita. In questo caso il rapporto rischio/beneficio si considera favorevole anche perché si tratta di pazienti di età avanzata al di fuori delle finestre temporali di rischio per lo sviluppo della schizofrenia. Epidyolex è invece un farmaco che contiene quasi esclusivamente CBD, con percentuali di THC estremamente basse (<0,1%). Il rischio di intossicazione da THC (il principale costituente nocivo della cannabis) è basso anche se il CBD può favorire l’accumulo di THC nell’organismo. Epidyolex ha mostrato efficacia terapeutica in forme gravi di epilessia encefalopatica, quali la sindrome di Dravet (epilessia mioclonica severa dell’infanzia), la sindrome di LennoxGastaut e la sclerosi tuberosa.
La cannabis terapeutica viene anche prodotta in farmacia (preparazioni magistrali con ricette mediche non ripetibili) utilizzando cannabis fornita esclusivamente dallo Stabilimento Chimico Militare di Firenze. I preparati FM1 e FM2 (in particolare FM1) contengono quantità potenzialmente intossicanti di THC. Sarebbe dunque importante regolamentare l’uso di cannabis terapeutica e destinarlo solo ai casi in cui le terapie di prima linea falliscono. Ad esempio, non esistono evidenze cliniche che la cannabis terapeutica sia utile in patologie psichiatriche, mentre potrebbe apportare benefici clinici in pazienti con dolore severo resistenti al trattamento o in pazienti con gravi disturbi del comportamento alimentare. Grande prudenza deve essere applicata all’uso di prodotti a base di cannabis (ad eccezione di Epidyolex) nei minori in considerazione degli effetti devastanti che il THC può avere nelle traiettorie di sviluppo del Sistema Nervoso Centrale.
La prevenzione primaria precoce nelle scuole e circoli sportivi
Il progetto viene attuato presso le scuole secondarie di primo e secondo grado e i circoli sportivi di Roma, utilizzando come linea di intervento la PEER EDUCATION, un metodo educativo volto a favorire l'apprendimento tramite coetanei, la comunicazione e la condivisione di esperienze, conoscenze e informazioni tra pari, in un ambiente informale.
Il programma prevede:
Per quanto riguarda i laboratori si prevede un incontro mensile di un'ora ciascuno, distribuiti durante l'arco di tutto l'anno, a partire dalla sessione plenaria iniziale fino alla sessione plenaria finale (maggio/giugno). Durante tali laboratori vengono portate avanti le seguenti attività: ripasso delle informazioni fornite durante le sessioni plenarie e commento sulla disinformazione e controinformazione che si trova, purtroppo molto spesso, su internet (analisi dei testi delle canzoni, dei film, delle testate giornalistiche, delle informazioni sui social riguardo le sostanze), attività con la realtà virtuale, approfondimento sulle sostanze o il comportamento patologico (in base all'argomento scelto dai peer educator), creazione di un prodotto finale (un powerpoint ad esempio). I laboratori implicano anche un'interazione da remoto con i responsabili del progetto in orario extra scolastico (tramite la piattaforma telematica fornita dalla scuola o gruppi Whatsapp), per l'invio di materiali di approfondimento e per un confronto sull'andamento della creazione dei lavori finali.
5. Da ultimo è fondamentale organizzare una sessione plenaria finale con tutti i partecipanti: studenti, allievi, insegnanti e allenatori programmabile verso la fine dell'anno scolastico o della pratica sportiva (maggio/giugno) che si svolgerà con le stesse modalità della sessione plenaria iniziale; i peer educator presenteranno i loro lavori finali e verranno consegnati gli attestati di partecipazione.Il progetto è completamente gratuito per la scuola, i circoli sportivi e per studenti e allievi partecipanti, grazie al contributo offerto da Fondazione Roma.
Conseguenze neuroevolutive e psichiatriche dell’assunzione di cannabis in età giovanile
Il crescente incremento a livello mondiale dell’uso di cannabis, anche sostenuto dalla sua legalizzazione in numerosi paesi del mondo occidentale, è associato ad almeno due principali fenomeni di comune osservazione, quali l’anticipazione progressiva dell’età media di inizio dell’assunzione, che spesso in Italia si colloca nella fascia di età della scuola media, cioè tra gli 11 ed i 14 anni, e la sempre più frequente osservazione clinica della comorbidità tra uso cronico di cannabis e disturbi psicotici di tipo schizofrenico, in cui nella grande maggioranza dei casi l’assunzione precede l’esordio dei sintomi psicopatologici.
A questo si aggiunge la comunissima osservazione, ancora peraltro oggetto non definitivo di indagini epidemiologiche controllate, della graduale insorgenza negli assuntori cronici di cannabis di un quadro di appiattimento affettivo e di perdita di interessi ed attività, associato a cronico orientamento depressivo dell’umore, noto come sindrome amotivazionale, sempre concomitante, in maggiore o minore misura, con un declino di capacità cognitive, con particolare riguardo ad attenzione e memoria, con le evidenti conseguenze negative, in età scolare, su continuità e rendimento nello studio.
Per quanto riguarda il rapporto tra uso di cannabis ed insorgenza di disturbi psicotici, esistono studi multicentrici recenti, condotti a livello europeo, che indicano in 3-5 volte l’aumento di rischio di nuovi esordi di schizofrenia in cui la cannabis svolge un ruolo eziologico centrale. È stato indicato da tali studi come in Europa, ma prevedibilmente anche nelle altre aree del mondo occidentale, il livello attuale di diffusione dell’uso di cannabis sia responsabile di una percentuale rilevante dei nuovi casi di psicosi schizofrenica, intorno al 12% nel caso dell’uso di sostanza di più elevata potenza, con tutte le comprensibili implicazioni di sofferenza individuale e familiare, costi sanitari, costi sociali, etc.
A tale effetto deve aggiungersi quello, più silente ma di estrema diffusione, dell’insorgenza della sindrome amotivazionale e del declino cognitivo, anche questo dotato di conseguenze estremamente negative su capacità di studio, di programmazione, di rendimento intellettuale, di inserimento e mantenimento lavorativo, di organizzazione familiare, etc.
Anche se i dati statistici a riguardo non sono concordi, si reputa che tra i consumatori abituali di cannabinoidi possa essere stimata una percentuale tra il 5 e l’8% di soggetti che sviluppano un disturbo psicotico clinicamente diagnosticabile, con ruolo di aggravamento del rischio relativo a durata continuativa e dosaggio dell’assunzione, e di oltre il 60% per quanto riguarda la sindrome amotivazionale ed il deficit cognitivo, anche questi modulati da durata e dosaggio del consumo. In entrambi i casi sono note influenze genetiche a loro volta modulanti il rischio di espressione clinica degli sviluppi psicopatologici.
Nonostante manchino anche in questo caso dati statistici obiettivi, è di comune riconoscimento il fatto che l’uso di cannabis, anche spesso associato a quello di alcool od altre sostanze psicoattive, sia alla base dei frequentissimi fenomeni di disregolazione affettiva, adattativa e comportamentale che caratterizzano un numero crescente di condotte giovanili.
Tutte le conoscenze attuali convergono nell’indicare nella deviazione dai normali tempi e dalle normali modalità dello sviluppo cerebrale il modello più esaustivo per interpretare i dati clinici, neurologici e neurocognitivi che caratterizzano questa area di psicopatologia.
Il modello neuroevolutivo delle psicosi postula quindi che qualunque fattore, endogeno od esogeno, in grado di indurre tali deviazioni possa svolgere un ruolo eziologico, isolato o, più spesso, sommatorio, nell’origine e nel potenziamento delle alterazioni evolutive.
L’età media attuale di inizio di assunzione di cannabis, anticipata fino a circa 12-13 anni, si colloca in una finestra temporale di estrema vulnerabilità, in quanto l’effetto della sostanza interferisce in modo diretto con l’azione di sostegno dello sviluppo e dell’organizzazione cerebrale esercitata dal sistema endocannabinoide, i cui fisiologici recettori neuronali possono essere abnormemente stimolati od inibiti dall’assunzione dei cannabinoidi esogeni. L’agonismo dei recettori CB1 esercitato dal D9-THC sembra rappresentare il principale fattore attivo in questo senso, tanto che tale sostanza viene ad oggi unanimemente considerata la reale responsabile dell’effetto psicoticizzante della cannabis.
La stimolazione del sistema dopaminergico, in particolare nel compartimento meso-limbico, viene interpretata come il meccanismo neurotrasmettitoriale più direttamente implicato in tale processo, con la sua diretta potenzialità di induzione e mantenimento di sintomi psicotici. Ma è importante ricordare che anche il quadro deficitario affettivo e cognitivo della sindrome amotivazionale può essere interpretato come la conseguenza a lungo termine dell’assunzione, per la progressiva riduzione del tono dopaminergico in peculiari aree cerebrali, in particolare la corteccia dorso-latero-prefrontale. Si tratta di un modello patogenetico per molti versi analogo a quello che viene comunemente applicato all’interpretazione dei sintomi rispettivamente positivi e negativi della schizofrenia.
È evidente che i quadri psicopatologici potenziali sono estremamente variabili e che esiste una percentuale di assuntori che non sviluppa chiari sintomi psichiatrici o comportamentali. Ma è altrettanto evidente, documentato da studi epidemiologici rigorosi e consistenti, che il rischio di malattia è esponenzialmente associato a età, durata e dosaggio dell’assunzione e che, al di là di una variabilità anche genetica di sensibilità, il ruolo della cannabis come agente in grado di indurre disturbi mentali gravi è dimostrato in modo inoppugnabile.
Nuove sostanze psicoattive (nps): peer education e psicoeducazione come strumenti di prevenzione
Con la definizione di Nuove Sostanze Psicoattive (NPS) si fa riferimento ad un’ampia lista di molecole, eterogenee tra loro per quanto riguarda la struttura chimica, le quali condividono la caratteristica di determinare potenti effetti psicoattivi di varia natura e in base a questi sono raggruppate in differenti famiglie. La dicitura “nuove” infatti non è riferita necessariamente ad una recente creazione, ma piuttosto vengono considerate tali per via della recente diffusione e popolarità tra gli utilizzatori “di nicchia”, ovvero i così detti “psiconauti”.
Il numero di NPS circolanti ha mostrato, negli ultimi 25 anni, una crescita costante, proprio per l’impatto “incentivante” del web su questo fenomeno: tali sostanze, prevalentemente vendute via internet, sono ad oggi oltre 4200, appartenenti a diverse famiglie, come studiato tramite il Progetto NPS Finder. Il web gioca un ruolo importante nella gestione di questo mercato, ancora poco regolamentato, all’interno del quale gli utenti sono motivati ad assumere NPS anche perché queste molecole non vengono rintracciate con i comuni test tossicologici impiegati e pertanto non veicolano il rischio in sede medico-legale (ad esempio per i controlli legati al possesso della patente di guida o all’idoneità al lavoro, al possesso di porto d’armi ecc.). Sul web la vendita di molecole non ancora “tabellate”, apparentemente vendute per finalità diverse dal consumo umano, risulta legale per molte NPS, aspetto che, inoltre, induce il consumatore all’erronea conclusione “legale significa sicuro”. Molte NPS sono analoghi chimici di sostanze dichiarate illecite, progettati allo scopo di mimare gli effetti di queste ultime e spesso venduti sul web come sali da bagno, fertilizzanti per piante o con altre finalità fittizie, volte ad aggirare il problema della legalità. Per via della commercializzazione sul web vengono altresì denominate “internet drugs”, “research chemicals”, oppure, siccome in grado di aggirare regolamenti e controlli, talvolta anche note come “legal highs”. Ogni giorno nuove molecole vengono immesse sul mercato di internet proprio nel momento in cui altre similari vengono dichiarate illegali; ed è proprio per questo motivo che il compito di monitoraggio del fenomeno, da parte delle istituzioni, risulta assai complicato.
Le seguenti costituiscono le principali famiglie di NPS: i cannabimimetici sintetici (spice drugs), i catinoni sintetici, le fenetilamine, gli oppioidi sintetici, le triptamine, gli agonisti GABA, sostanze fenciclidino-simili (PCP-like), piperazine, numerose molecole di derivazione vegetale, diversi prodotti farmacologici utilizzati ad alto dosaggio e infine le cosiddette Performance and image enhancing drugs (PIEDs). Le conseguenze psichiatriche, comportamentali e internistiche, oltre che criminogeniche dell’uso di NPS, costituiscono oggi una chiara minaccia per la salute pubblica: sebbene siano ancora parziali le conoscenze relative agli specifici effetti farmacologici ed ai rischi a breve e lungo termine correlati al consumo di molte di queste sostanze, dati emergenti suggeriscono che alcune molecole possono risultare più dannose delle molecole da cui hanno avuto origine, in termini di rischio di dipendenza, overdose ed effetti dannosi sulla salute, in particolare quella mentale.
Per la corrispondenza: gminisola@hotmail.com