Anno Accademico 2023-2024
Vol. 68, n° 4, Ottobre - Dicembre 2024
Simposio: Le malattie del peccato
07 maggio 2024
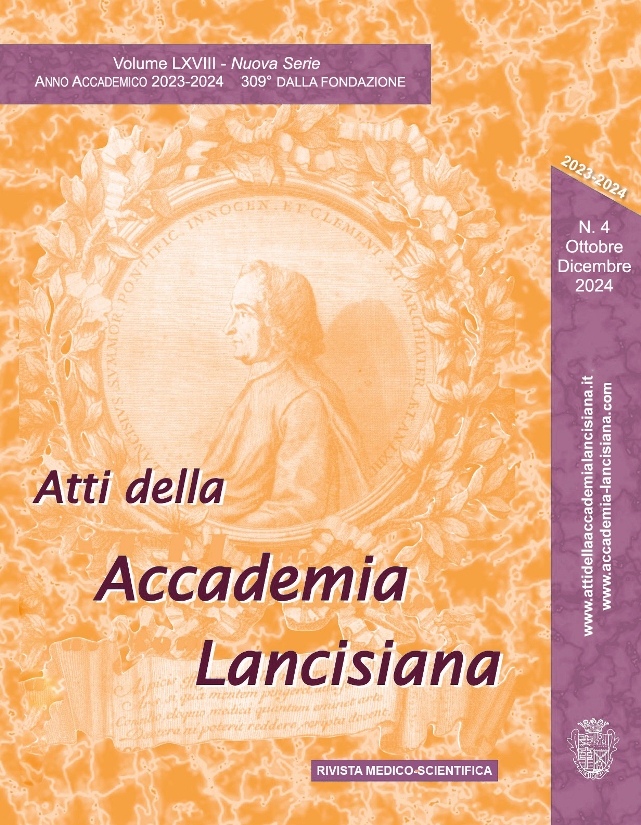
Simposio: Le malattie del peccato
07 maggio 2024
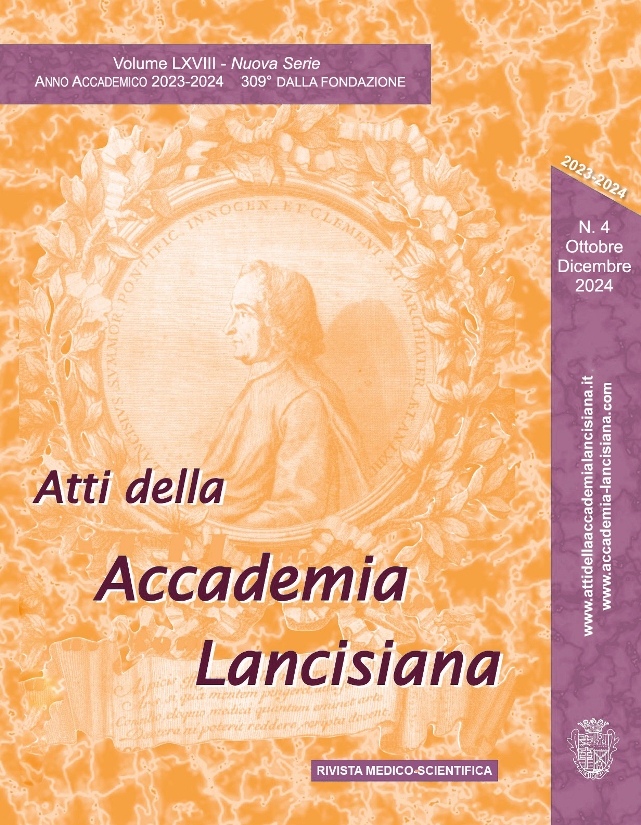
Versione PDF dell'articolo: Download
Prostituzione è il prestarsi abitualmente a rapporti sessuali con chiunque a fine di lucro; sue caratteristiche sono dunque la retribuzione e la mancanza di discriminazione di carattere sentimentale circa le persone ammesse ai rapporti sessuali1.
L’argomento è complesso per i differenti temi da trattare: dalla sfera religiosa a quella giuridica, oscillando tra peccato e reato, senza trascurare l’aspetto sanitario. Un fenomeno presente non in tutte le civiltà e non nella stessa misura, in cui i confini tra morale e diritto sono particolarmente sfumati e sul quale, nei secoli, le concezioni religiose hanno esercitato una forte influenza. Nei diversi Stati Europei, le normative e i bandi, promulgati tra il XIII secolo e la prima metà del XIV, non contenevano sanzioni dirette a combattere il meretricio, tuttavia tentarono di allontanare dai centri cittadini chi l’esercitava2.
A Roma l’immorale commercio ebbe grande diffusione. I Papi, Pio V (1504-1575) e Sisto V (1521-1590), perseguirono inutilmente l’obiettivo di eliminarlo; tuttavia l’impostazione cristiana considerava le donne che lo esercitavano delle peccatrici da redimere e non ree da castigare. Una tale concezione esercitò un’indubbia influenza sugli altri Stati. Al contrario i ruffiani erano perseguiti e severamente puniti. Il lenocinio, definito crimen horribile, pessimum ac crudele3, fu considerato un attentato alla morale e all’ordine pubblico. Il lenone sottraeva alla donna la castità, bene considerato più prezioso di tutte le ricchezze materiali. La sanzione prevista era la morte, non solo per il reo ma anche per i complici, tuttavia l’inflizione della pena massima era da riservare ai casi più abietti e la pena prevalente era quella arbitraria3. Molto più grave era considerato il reato compiuto da mariti, padri o fratelli nei confronti di mogli, figlie e sorelle.
Perché soffermarsi sulla storia della prostituzione in particolare nella Repubblica di Venezia? La ricca Venezia, la Serenissima, porto di snodo per traffici di ogni genere, rappresentò un importante centro commerciale nell’epoca del suo splendore. Fu una città cosmopolita e tollerante, considerata anche gaudente e libertina. Non va dimenticato che qui visse Giacomo Casanova con il quale, fatta la giusta tara alle sue narrazioni, si deve concordare come la licenziosità regnasse tra canali, ponti e calli. Mercanti provenienti da oriente e occidente, marinai, artisti e viaggiatori attratti dalla bellezza e particolarità della città, ma anche avventurieri, truffatori, saltimbanchi e guaritori ne riempirono le strade. È evidente che in tale ambito la prostituzione dilagò e fu anche, in una certa misura, tollerata e disciplinata dalle Autorità forse più che in altre realtà.
Per regolare i costumi e il libertinaggio, Venezia emanava la prima legge il 24 luglio 1232: se alcun desverzenerà per forza alcuna zovene, over haverà violentemente da far con donna maridada, o con Femina corrotta, se’l confesserà il delitto, over sarà per Testimonii convinto tutti doi li occhi perda4.
Secondo Lorenzi le disposizioni promulgate, dirette e indirette, che interessarono il meretricio furono 171. Fino al 1500 gli ordinamenti non tennero conto della possibilità di contrarre malattie a trasmissione sessuale. Le autorità politiche tollerarono che la prostituzione fosse esercitata nel territorio urbano purché questa avvenisse all’interno di postriboli pubblici, istituiti, disciplinati e posti sotto il controllo di appropriate magistrature3. Ci si preoccupò di evitare che sostassero in vicinanza di conventi, monasteri o luoghi sacri2. Furono date disposizioni sul modo di abbigliarsi, sulle diverse magistrature che dovevano controllarle e sulle tasse da pagare. Tuttavia fu sempre difficile la vigilanza sulle più misere che, alla ricerca di clienti, disattesero le limitazioni ed esercitarono liberamente nelle città2.
Ricordiamo le più significative:
1232, 24 luglio - Prima legge sulla prostituzione.
1266, 10 ottobre - Siano cacciate dalle case private le meretrici.
1303, 1 aprile - Non vi sia obbligo di rendere ragione dei denari dati a meretrici.
1358, 29 giugno - Riunione delle meretrici in un dato luogo.
1360, 14 giugno - Locali per le meretrici.
1362, 29 agosto - I capi sestiere invigilino perché le meretrici non escano la notte.
1400, 21 giugno - Carampane; abitazioni per meretrici.
1413, 20 luglio - Meretrici poste a usufrutto.
1417, 9 luglio - Sugli ebrei che hanno commercio con meretrici.
1421, 5 maggio - Proibito alle matrone e meretrici di tenere in affitto case e volte a Rialto.
1421, 6 maggio - Tutte le meretrici si riducano a Rialto (Castelletto).
1421, 23 maggio - Si obbligano le meretrici di portare al collo un fazzoletto giallo.
1423, 15 luglio - Luoghi di ritrovo, fissati nel Castelletto a Rialto, per le meretrici.
1423, 15 luglio - Contro i mezzani che sfruttano le meretrici.
1423, 15 luglio - Proibito alle mamole di dormire nelle osterie.
1429, 19 luglio - Pene alle quali vanno soggette le meretrici.
1429, 19 luglio - Pene agli ebrei che usano con donne cristiane.
1430, 2 marzo - Legge che proibisce l'uso delle pianelle.
1432, 15 luglio - Condanna dei Bravi che si appropriano del guadagno delle mamole.
1432, 28 luglio - Pene inflitte alle matrone che abusano dei denari delle meretrici.
1434, 7 giugno - Legato a una mamola.
1438, 12 dicembre - Giorni solenni nei quali è proibito alle meretrici di fornicare.
1438, 21 dicembre - Le meretrici non possano dar in pegno se stesse.
1439, 18 gennaio - Proibito agli osti di far credito alle meretrici per più di 5 lire.
1442 - Proibizione alle donne di portar certe vesti.
1443, 30 agosto - Norme di vestire per le donne da partito.
1445, 2 marzo - Legge contro i sodomiti con catalogo delle parrocchie di Venezia.
1450 - Obbligo alle meretrici di portar acqua per uso della popolazione.
1460 - Proibizione alle meretrici di far commercio di giorno.
1460 - Le meretrici sono confinate a S. Matteo di Rialto.
1480 - 15 marzo - Si prescrive alle meretrici il modo di portare i capelli.
1498 - Proibizione alle meretrici di abitare tra la calla delle Rasse e il Palazzo ducale.
1514, 25 ottobre - Tassa imposta alle meretrici.
1522, 22 febbraio - I malati di Morbo Gallico siano raccolti agli Incurabili.
1539, 12 settembre - Si licenziano le meretrici forestiere, e altre restrizioni relative a esse.
1543, 21 febbraio - Proibizione alle meretrici di portare oro; e altre leggi relative.
1562, 8 ottobre - Legge suntuaria, per limitare le spese voluttuarie e di lusso alle meretrici.
1571, 10 marzo - Proibizione alle meretrici di frequentare le chiese in certi giorni solenni.
1578, 14 luglio - Divieto alle meretrici di vestirsi da uomo.
1578, 20 dicembre - Proibizione alle meretrici di vestirsi da vedove e maritate.
1598, 23 settembre - Proibito alle meretrici l’uso di accappatoi di seta.
1613, 28 febbraio - Proibizione assoluta alle meretrici di frequentare le chiese.
1615, 30 giugno - Proibito alle meretrici l’uso della barca e della gondola.
1615, 30 giugno - Proibito alle meretrici di tener gioco.
1626, 9 giugno - Proibizione ai barcaiuoli di condur meretrici in gondola.
1627, 23 marzo - Tassa imposta alle meretrici.
1796, 15 settembre - Ultima legge Veneta sulla prostituzione.
La prostituzione fu ammessa nei territori della Serenissima, ma non fu tollerato lo sfruttamento e il lenocinio …Agnese da Padova, madre di Cattaruzza che diede sua figlia fanciulla ancora in braccio al N. U. sier Domenico Polani, fu frustata da S. Marco a Rialto, e la sua colpa fu stridata e condannata a sei mesi nei pozzi; nella strida fu taciuto però il nome del Polani il quale dovette a sua volta pagare 100 ducati d'oro che per due terzi furono consegnati alla fanciulla (1375, 18 aprile).
… Alvise Benedetto popular che stava a S. Zanipolo, che obbligava la sua sposa di far commercio per prezzo alle altrui voglie, et il guadagno teneva scripto in libro et con chi, con sentenza i Signori di Notte decretarono: ch'el detto beccho sia vestito de zalo (la legge “che tutti quelli ruffiani et ruffiane, i quali stanno in questa cità, debino portar habito de color zallo aziochè da tutti possino esser conosciudi”, fu promulgata fino dal 1490) e con una corona con corne in testa, su un aseno, sia menà per la terra a noticia di tutti, e cossi fu fatto.
Particolare severità fu adottata verso gli ebrei. Questi ritenuti rei di abusare delle usure, nel secolo XIV, furono confinati nella terra di Mestre.
In seguito fu loro permesso di rientrare a Venezia ma solo per un certo numero di anni. La concessione fu rinnovata dietro pagamento di una notevole somma in oro. Ad eccezione della Medicina non potevano esercitare alcun'altra arte nobile; non potevano acquistare case o altri possedimenti ed erano obbligati di abitare nel Ghetto le cui porte erano chiuse al tramonto e aperte all’alba. Se un ebreo fosse stato sorpreso a giacere con una cristiana, se era meretrice per gli effetti della legge 19 Luglio 1429, questa era condannata a pagare L. 500 di multa e a 6 mesi di prigione, mentre se non era riconosciuta come tale, la pena detentiva era di un anno… Datalo ebreo, in curia da le Schiavine, ad pontem Fuseorum che contrasse amicizia con Giacometta, moglie di un Tommaso di Giuriano il quale fu con sentenza 13 Giugno 1444 condannato ad un anno di carcere ed a 50 lire di multa. La Giacometta poi per avere ardito, tamquam sus immunda, di mescolarsi con un ebreo, venne pur essa condannata con sentenza 1 Agosto successivo a mesi 4 di carcere ed alla perdita della dote5.
Il censimento del 1509 annoverava 11.664 prostitute presenti nella città lagunare, un numero elevatissimo rispetto alla popolazione tanto che le stesse se ne lamentarono manifestando in piazza San Marco6. Fu deciso quindi di spostarne 1000 a Mestre, questa decisione non fu particolarmente felice perché permise la diffusione della sifilide tra le truppe acquartierate in quella città. Fu anche stabilito d’impedire il meretricio alle non veneziane, che fossero in città da meno di due anni. Le prostitute risiedano soprattutto nel cosiddetto Castelletto. Una legge antica […], 1424, 19 Luglio, ci assicura, che allora eravi luogo pubblico per le Meretrici in Rialto.
La posizione era strategica per il commercio, la presenza di un gran numero di mercanti forniva un continuo ricambio di clienti. Di giorno non potevano uscire ed erano chiuse al suono della Marangona (campana di San Marco) ed era loro proibito frequentare le osterie, infliggendo severissime pene ai tavernieri che somministrassero loro qualsiasi bevanda o le albergassero di notte. Le case erano di proprietà di famiglie nobili quali i Venier e i Morosini, vicino a San Matteo di Rialto, nei pressi della chiesa oggi non più esistente. Sotto il Doge Domenico Morosini, cioè circa 1150, Bernardo Corner fece la Giesia di S. Mattio, appresso la quale al presente si trova esser dov’è il luogo pubblico. La vicinanza di quelle infelici alla Chiesa senza dubbio fu causa, che la Scuola di S. Gottardo, e S. Gio: Battista che erano in S. Matteo prima restassero desolate e poi altrove si stabilissero7… Per giusti motivi si concede loro facoltà di trasferirsi e se vogliamo seguire la tradizione, ciò fu perché le strade erano così sordide e sporche a cagione delle frequenti meretrici che ivi abitavano, che non potevano fare la loro processione7. Anche le case alle Carampane, originariamente di proprietà della famiglia Rampani, furono destinate ad alloggiarle. Questi possedimenti passarono poi di proprietà alla famiglia Trapani. Nel 1421 furono assegnate alle pubbliche meretrici le case di Ca Rampani a S. Cassan. Fu posto a governo di costoro una matrona, che teneva cassa del denaro, e divideva ogni mese a tanto per testa il guadagno7. La loro presenza è testimoniata dal Ponte delle tette, nel sestiere de S. Polo, che ricorda come si mostrassero alle finestre a seno nudo per attirare i clienti.
Nel Seicento alle Carampane rimasero solo le più anziane che si vendevano a poco prezzo. Queste derelitte oltre a prostituirsi si prestavano ad azioni più riprovevoli come irretire le giovanette, divenendone le loro ruffiane, provocare aborti, causando spesso la morte delle sventurate che si affidavano loro. Con il detto, entrato nel linguaggio comune, ti xe una vecia carampana, tuttora s’indica una vecchia che ha perso la piacevolezza della gioventù.
Il controllo dei postriboli era affidato ai Capi di Sestiere, Magistratura istituita fin dal 1320. I Signori di Notte avevano il compito di reprimere i reati più gravi che avvenivano nelle ore notturne.
I Cinque alla Pace dovevano dirimere le risse tra i popolani. Attraverso le sentenze emesse è stato possibile risalire alle generalità e all’attività svolta dai soggetti implicati e alle multe inflitta ai colpevoli. Tra il 1544 e il 1601 i provvedimenti interessarono quasi trecento prostitute. La maggioranza proveniva dall’entroterra veneziano, da Stati vicini o dai Domini del Mare della Serenissima. Molte erano state vittime di aggressioni o erano state coinvolte in liti imputabili al mestiere esercitato8.
Nel 1514, per scavare l'Arsenale, furono tassate quelle che pagavano più di 40 ducati d'affitto all'anno e nel 1627 fu loro imposto un esborso di mille ducati per finanziare le povere monache convertite della Zuecca5.
Il 12 settembre 1539, si ordinò che… nessuna meretrice o cortigiana possa abitare o stare in luogo alcuno che sia nelle vicinanze di chiese e luoghi sacri né possa andare in chiesa nei giorni di festa e nelle principali solennità; che nessuna meretrice o cortigiana possa andare a perdono se non nelle ore tra la nona e il vespero; che siano banditi i luoghi e le pubbliche scuole dove concorrono ogni sorta di meretrici; che sia proibito a ruffiani e ruffiane tenere in casa né a guadagno meretrici, eccettuando quelli che stanno nei luoghi pubblici e nei postriboli.
Fu altresì deciso che... per regolare i disordini delle meretrice pubbliche che stanno per le strade; che si licenziassero tutte le forastiere; che non si lascino habitar appresso le Chiese; che non li sia permesso andar alle Chiese nelle hore che sono quelle frequentate da done de bona et honesta conditione. Che non possino tegnir a sui servitii pute ne servente de anni 30 in zoso (minori di anni 30) ...5.
Dal 21 febbraio 1543 fu loro proibito di portare oro, argento e seta, catenelle, perle, pietre. Altri provvedimenti vietavano loro di abitare sul Canal Grande, di passeggiare per le strade principali o di andare in gondola nei canali centrali. Fu loro destinato il Rio della Sensa a Sant’Alvise per mettersi in mostra ed essere ammirate (Fig. 1).
 |
|
|
El barcaruol o barcaroli che ardissero di vogarle (condur le meretrici in gondola) cadino in irremissibil pena di stare per due hore continue s'un palo eminente, ad hora di Rialto (nell'ora in cui si aprivano le attività a Rialto) per mezo il magistrato di sue Signorie Illustrissime (Provveditori alle Pompe) et poi siano e s'intendino condannati a servire sopra una delle galee de' condannati per homeni da remo, con li ferri alli piedi et con tutti li ordini dell'armamento, mesi 18 continui5.
Il 28 marzo 1572 fu disposto che le meretrici non possan andar vestite da donne maritate, né da vedove. Ma forse perché quelle empie donne dalle parole di quel Decreto attrapparono (presero) occasione di comparir vestite da donzelle, e noi sappiamo che: […] che le donzelle andavano fuori di casa con fasciol bianco di seta, come abito loro particolare, per ciò quel Zendado (scialle) bianco alle meretrici fu interdetto (1598, 23 settembre)7.
La maggioranza delle prostitute erano dette mamole o cortigiane di lume, dalla candela accesa posta alla finestra per farsi riconoscere.
Esercitavano il mestiere in case umili, soddisfacevano le voglie di uomini di basso rango, vestivano modestamente e per attirare i clienti esponevano le loro grazie in pubblico. Poi vi erano le Cortigiane Honeste, dotate di fascino, eleganza e scaltrezza ma anche di cultura e educazione tale da poter frequentare ricchi borghesi e nobili potenti che le colmavano di regali, ma che non erano i soli a godere delle loro grazie. Questa carriera era una possibilità offerta alle donne che non volevano o non potevano sposarsi o entrare in convento. Conducevano una vita sfarzosa, invidiata dalle maritate legate agli obblighi imposti dal vincolo matrimoniale, al contrario delle prime che godevano anche della possibilità di condurre un’intensa vita di società, di possedere case quando non interi palazzi e compiacersi della propria ricchezza senza essere legate indissolubilmente a un solo uomo. Un mestiere redditizio dunque, quello della Cortigiana Honesta, che richiedeva però un conveniente esborso di denaro da parte della famiglia per permetterle di acquisire l’indispensabile istruzione e educazione. Un privilegio, in un’epoca nella quale solo il 10-12% delle donne sapeva leggere e scrivere. Una spesa che rendeva impossibile distinguere una patrizia da una cortigiana, anche se questa era obbligata a indossare un fazzoletto giallo intorno al collo per farsi identificare, come prescritto dal Consiglio dei Dieci, imposizione spesso ignorata anche perché spesso si accompagnava, anche pubblicamente, a personaggi molto noti in citta. Il rovescio della medaglia era di essere soggetta a divieti, non sempre rispettati, sottoposta a violenze vere e a motti offensivi.
Nel Cinquecento furono pubblicati sonetti in cui gli autori ponevano in guardia gli uomini dalle donne di piacere e ne denunciavano le malattie. A Rialto, in Campo San Giacometto, sulla colonna e sul Gobbo, tuttora esistenti, erano esposti versi satirici indirizzati alle meretrici e alle cortigiane. Tra queste ultime che animarono la vita licenziosa nella Venezia del ‘500, la più famosa è Veronica Franco9.
 |
|
|
La possiamo ammirare in un dipinto attribuito a Tintoretto o alla sua bottega, conservato nel Worcester Art Museum (Fig. 2).
La rappresenterebbe anche un altro dipinto del Tintoretto, Dama che scopre il seno, conservato a Madrid nel Museo del Prado. Nacque a Venezia nel 1546 in una famiglia borghese. La situazione economica le permise di avere insegnanti privati. L’intento della madre, Paola Fracassa, fu quello d’impartirle un’educazione che le consentisse di divenire una cortigiana honesta come lo era stata lei stessa prima di sposarsi. La ragazza prese marito appena sedicenne. Il matrimonio, con il medico Paolo Panizza, fallì quando diciottenne, diede alla luce il primo figlio, Achilletto, frutto di una relazione con Iacomo di Baballi, ricco mercante di Ragusa (Dubrovnik). Dopo la separazione, per mantenersi diventò ufficialmente una cortigiana, registrata nel Catalogo de tutte le principali et più honorate cortigiane di Venetia: Veronica Franca, a Santa Maria Formosa, pieza so mare (mezzana sua madre), scudi 2. Per Veronica più che una scelta fu probabilmente una necessità che le consentì di entrare a far parte di un mondo ricco di stimoli culturali, dove ebbe modo di conoscere personaggi influenti, che stimolarono la sua costante volontà di apprendere. Fu una donna di non comune intelligenza e di elevata cultura, apprezzata per le sue doti intellettuali, conosciuta in città non solo per la sua bellezza, ma anche per le sue doti artistiche. Non nascose il suo status, ma rivendicò per le donne una dignità, indipendentemente dal mestiere esercitato. Nel 1574 Veronica vide aumentare la sua fama. Enrico di Valois, il futuro Enrico III, si fermò a Venezia durante il viaggio verso la Francia e il trono che lo aspettava ed ebbe il tempo di gustare i favori della più ricercata cortigiana veneziana, scelta, così si racconta, dopo averla vista in un album di miniature mostratogli dalla Signoria10. Quando Enrico lasciò la città, Veronica gli fece dono di un suo ritratto, forse una miniatura, e di due poesie composte per lui, in cui si riconosce un’estrema raffinatezza:
Come talor dal ciel sotto umil tetto
Giove tra noi qua giù benigno scende,
e perché occhio terren dall’alt’oggetto
non resti vinto, umana forma prende;
così venne al mio povero ricetto,
senza pompa reale ch’abbaglia e splende,
dal fato Enrico a tal dominio eletto,
ch’un sol mondo non cape e non comprende…
------------
Prendi, re per virtù sommo e perfetto,
quel che la mano a porgerti si stende:
questo scolpito e colorato aspetto,
in cui ‘l mio vivo e natural s’intende
E, s’a esempio si basso e si imperfetto
La tua vista beata non s’attende,
risguarda a la cagion, non a l’effetto …11
Nel 1575 pubblicò una raccolta di poesie, Terze Rime, dove, oltre ai suoi versi, sono riuniti sette componimenti di poeti ignoti. Nello stesso anno fece stampare una raccolta di brani in memoria di Estor Martinengo, signore di Malpaga, giovane patrizio di Brescia fedele a Venezia nella lotta contro i Turchi. Nel 1580, presentò le Lettere familiari a diversi, 50 lettere inviate ad alcuni personaggi tra cui Tintoretto e Enrico di Valois. La XXII è indirizzata a una madre cui sconsiglia di fare intraprendere la vita di cortigiana alla figlia avvertendola che la perdizione di questa sarebbe andata di pari passo con la sua, colpevole di averne deciso il destino: la rovina di lei non può essere separata dalla vostra. La lettera denuncia lo squallore del mestiere, ne evidenzia gli aspetti negativi e le disgrazie in cui si può incorrere: darsi in preda di tanti, con rischio d’esser dispogliata, d’esser rubbata, d’esser uccisa. Sono parole in cui si può ravvedere anche un’accusa, non troppo velata per essere stata avviata a una tale professione e quindi mai avrebbe augurato a un’altra giovane la stessa sorte. Il suo giudizio esprime una visione dolorosa di chi è costretta a vivere in funzione di altri e ad assecondare ogni desiderio: mangiare con l’altrui bocca, a dormire con gli occhi altrui, a muoversi secondo l’altrui desiderio, correndo in manifesto naufragio sempre della facoltà e della vita. […] qual maggior miseria?12
Ricca, ammirata, corteggiata e amata non poteva non suscitare anche molte gelosie e maldicenze. Maffio Venier respinto da Veronica, cugino di quel Marco, che la cortigiana preferì a tutti gli altri amanti, per vendicarsi la definì, in un sonetto, Veronica ver unica puttana e ne descrisse le parti del suo corpo in modo offensivo e volgare13. La accusò di essere ammalata di sifilide, ma fu lui a morirne, dopo averla contratta in Turchia. La donna indignata reagì con sarcasmo, componendo una rima, in cui affermava che un vero gentiluomo non si sarebbe mai espresso in tal modo.
Nel 1575, quando Venezia fu colpita dalla peste, lasciò la città, ma al suo ritorno trovò la casa depredata e molti dei suoi beni perduti. Nel 1580 fu accusata di stregoneria dal precettore del figlio Achilletto che affermò di averla vista praticare incantesimi per recuperare i propri averi. Veronica Franca, publica meretrice si difese da sola, davanti al tribunale del Sant’Uffizio e vinse la causa probabilmente grazie all’intervento di qualche nobile protettore. Dopo il processo, quando aveva 34 anni, si ritirò dalle sue frequentazioni. La sua vita terminò nel 1591. Nei Necrologi del Magistrato della sanità si legge: “1591, 22 luglio. La Sig. Veronica Franca d’anni 45 da febre già giorni 20. S. Moisè”.
Nel suo testamento destinò una considerevole somma per aiutare le prostitute che desideravano tornare ad essere putte honorate. Con la sua scomparsa cade nell’oblio anche la sua opera letteraria. Sarà Benedetto Croce, estimatore delle sue Rime, a riscoprirla.
Un'altra cortigiana molto ammirata fu Angela dal Moro detta Zaffetta, contemporanea della Franco. Di lei s’invaghì Lorenzo Venier il quale, una volta respinto, per vendicarsi del suo rifiuto, la fece rapire e violentare e quindi se ne vantò nel poemetto satirico: La Zaffetta14. L’episodio fu rievocato anche da Pietro l’Aretino nella commedia la Cortigiana15. Il poeta in un suo scritto così la lodava: Io vi do la palma, sopra quante godono allegra vita. Nella vostra casa il libertinaggio prende sembianze della decenza. Ma ditemi, qual prestigio è il vostro nel sapervi ognor circondare di nuovi amici, senza perdere gli antichi?16
La tradizione vuole che Tiziano s’ispirasse a lei quale modella dell’Amor Sacro, mentre Violante, figlia di Jacopo Palma il Vecchio, sarebbe stata rappresentata come l’Amor Profano.
Si pubblicò, in epoca rinascimentale, anche un Catalogo de tutte le principali et più honorate Cortigiane di Venezia del secolo XVI, in cui era riportato il nome e la… contrata ove son le loro stantie, et etiam il numero delli danari che hanno da pagar quello gentilhomeni che desiderano entrar ne la sua gratia). Ne segnalava 210, e si avvertiva… chi vol haver amicitia de tutte bisogna pagar scudi d’oro 1200. Vuolsi che detto catalogo fosse ad uso de ' forestieri che venivano a Venezia, ma ci teniamo a dichiarare che ciò è falso, questo catalogo, e fu l'ultimo trovato, non era affatto permesso dal Governo della Repubblica, ma clandestinamente si stampava e vendeva. Nel 23 luglio 1566 fu per stampa consimile processato Hieronimo Calepin stampador5.
Forestieri e veneziani non disdegnarono nemmeno la compagnia dello stesso sesso, ma in questo caso le autorità intervennero con pene severissime:
È evidente a tutti quanto sia diffuso nella nostra città l'abominevole e detestabile vizio della sodomia, quindi per non provocare l’ira del Signore nostro Dio, dobbiamo opporci a questo gravissimo peccato con ogni mezzo… Per cui i Capi di questo Consiglio devono eleggere per sestiere due nobili, maturi per età, in carica per un anno, i quali non possono rifiutarsi, altrimenti pagheranno una ammenda di 100 lire da versare nelle mani dei Capi del Consiglio. E sotto il vincolo del giuramento saranno tenuti a interrogare e indagare diligentemente su chiunque, nel sestiere di loro competenza, frequenti luoghi pubblici o case che vengono chiamate bastie nelle quali solitamente vengono commessi molti atti illeciti e criminali, oppure se vi siano frequentazioni di età non conveniente, cioè adulti che conversano insieme a ragazzi, oppure ancora altre persone sospettate di tale vizio che si incontrano sia di giorno che di notte. E se questi vadano insieme nelle campagne fuori della città, e si metta in atto ogni cura e diligenza perché il fatto sia bene indagato e ne sia data immediata notizia e avviso di ogni cosa che avranno scoperto ai Capi del presente Consiglio. I quali facciano ed eseguano contro costoro, secondo la loro coscienza, quanto disposto dalle leggi e i regolamenti promulgati in questo Consiglio contro predetto abominevole vizio (2 marzo 1455)4.
Il 12 marzo 1496 il Consiglio dei Dieci stabiliva…
Al fine di conservare e accrescere la clemenza e la benevolenza di Dio onnipotente per il nostro Stato, per mezzo della giustizia, e seguendo i santissimi e onestissimi costumi dei nostri antenati, dobbiamo impiegare ogni diligenza e provvedimento possibile per estinguere e cancellare da questa città il nefandissimo ed orrendo vizio e crimine della sodomia, che è contro la riproduzione del genere umano ed è una offesa contro Dio sulla Terra… I barbieri o i medici o altri che curino ragazzi o donne i quali o le quali abbiano subito la sodomia, devono presentarsi il giorno stesso o quello dopo ai Capi del Consiglio dei Dieci e comunicare il nome del ragazzo o della donna il quale o la quale hanno avuto in cura, sotto pena di cinquecento lire di denari piccoli, una detenzione di sei mesi e la proibizione dell’esercizio della medicina a Venezia, e se sono stati denunciati per aver taciuto la verità, il denunciante riceverà trecento lire dal denaro della sanzione imposta al medico condannato4.
Nel ‘500 i rapporti omosessuali a Venezia furono così diffusi da richiedere una dura reprimenda: i colpevoli di sodomia erano impiccati nella piazzetta di San Marco e i loro corpi bruciati.
Bernardino Correr nel 1482 volse forzar ser Hieronimo Foscari per sodomitio e li tajò le stringhe delle calze (calzoni) in calle di ca' Trevisan a S. Bartolamio de sera, fu impiccato fra le due colonne di S. Marco e quindi abbruciato per sentenza del 10 Ottobre 14824.
Le prostitute furono considerate anche una forma di dissuasione dal peccare contro natura, come loro stesse fecero notare al doge in una petizione perché intervenisse contro tale vizio.
Il 27 marzo 1511 il patriarca Antonio Contarini dopo il terribile terremoto avvenuto il giorno precedente, si presentò al Consiglio dei X e affermò come il terremoto fosse signa Dei, et propter peccata veniunt adversa; e questa terra è piena di pechati, primo di Sodomia, che si fa per tutto senza rispeto, e le meretrici li ha mandato dir che non poleno viver, niun va da lhoro, tante è le sodomie; e fino vecchij si fanno lavorar. Item ha'uto da' confessori, che padre se impaza con fiole, fradeli con sorele, et similia. Item, la terra è venuta poco devota…5.
Il recupero delle prostitute
Vendere il proprio corpo per soddisfare i bassi istinti, non poteva essere certo incoraggiato anche se tollerato e disciplinato, per cui il governo sostenne le prostitute che volevano cambiare vita. La condizione di molte era incerta: dovevano vivere dalle mezzane e versare loro un quinto degli incassi, oltre che pagare un affitto e altre spese; poi, quando non potevano più rendere, si ritrovavano in strada a mendicare, altra situazione che si voleva evitare. All'infelice condizione di queste miserabili ha proveduto il M. C. (Maggior Consiglio) con parte del 1438; 25 Decembre: observando, che le meretrici siano impignade per pochi denari, in forma che quando le se pentisse, per lo debito per lo qual prima lo son impignade; e per molte gravezze che li sovraviene, le convien continuar in lo piccado; L'anderà parte, che de cetero alguna femina non se possa impignar, ne ésser impignada da altri per luxuria, per modo che per la pignora la sia obligada: ma in questo de cetero tutte siano libere, e sel fosse fatto al contrario, non li sia fatto raxon a chi le avesse in pegno11.
Per merito della carità privata ebbero origine ospizi o ospedaletti dove ricoverare le donne che rinunciavano al meretricio ed erano senza mezzi di sostentamento onesti.
Quelle che volevano cambiare vita furono ospitate in case di soccorso; una si trovava nei pressi della Chiesa di San Nicolò da Tolentino, un’altra a San Pietro in Castello e un’altra a San Gervasio e Protasio. Nel 1522 fu fondato l’ospedale degli Incurabili e nel 1579 quello delle Convertite alla Giudecca. Cresciuto in brevissimo tempo il numero delle ospiti nei vari ospizi, si provvide con uno nuovo e più grande, il Pio Istituto delle Penitenti, a Cannaregio, nella zona di San Giobbe.
Ospedale degli Incurabili
Il contagio e la diffusione delle malattie veneree, per lungo tempo non fu considerato una priorità dai vari governi, essendo predominanti le preoccupazioni morali e di ordine pubblico. La questione acquisì, però, notevole rilievo quando la propagazione, soprattutto della sifilide, divenne interesse prevalente delle politiche sanitarie2.
La malattia comparve in Occidente alla fine del '400. Scoppiò in modo epidemico, nel 1496, durante l'assedio di Carlo VIII a Napoli. I soldati mercenari del re di Francia, tra i quali vi erano alcuni superstiti delle imprese di Cristoforo Colombo, che probabilmente l’avevano contratta presso le amerindie, ne furono ritenuti responsabili. Il popolo la chiamò subito mal francioso, ma anche mal de Naples. L'agente etiologico è il Treponema pallidum, una spirocheta, isolata solo nel 1905 con una resistenza assai precaria che al di fuori del corpo umano sopravvive difficilmente. L’origine per alcuni era dovuta a una recrudescenza di una patologia che si era modificata nel tempo ma che era già endemica nell'oriente arabo, per altri fu importata dall'America dai marinai di Cristoforo Colombo. Si suppose anche che l’affezione si fosse sviluppata dall'amplesso di una prostituta con un lebbroso.
 |
Fig. 3. Cura di un sifilitico (infranciosato). Biblioteca Augusta, Codice G 61, secolo XVI, Perugia. |
La ricerca storico-paleopatologica, non ne ha evidenziato alcuna traccia negli scheletri preistorici, antichi e medioevali analizzati in Europa e in Asia Minore. Tutto lascerebbe quindi pensare che sia stata realmente importata dal Nuovo Mondo. Nel 1530 il medico veronese Gerolamo Fracastoro (1483? - 1553) ne descrisse gli aspetti nei suoi tre libri Syphilis sive de morbo gallico. Il nome gli fu suggerito dal mito del pastorello Sifilo, che per aver offeso Apollo fu da questi punito con un terribile morbo che ricopriva tutto il corpo di ulcere17 (Fig. 3).
Si contrae, nella maggior parte dei casi, durante il rapporto sessuale con soggetti portatori di manifestazioni luetiche (sifilomi) primarie e secondarie. La madre luetica trasmette l’infezione al feto, attraverso la placenta. La malattia per la mancanza di un’idonea terapia e perché subdola nel suo decorso, era di estrema gravità.
Proprio per tentare di limitarne il diffondersi fu fondato, nel 1522 da Gaetano Thiene (1480-1547), l'Ospedale degli Incurabili, grazie alla munificenza delle nobildonne Maria Malipiero e Marina Grimani che già nel 1517 avevano dato assistenza ed asilo ad alcune prostitute colpite dalla sifilide.
Il religioso ottenne di farlo costruire nel sestiere di Dorsoduro, in un luogo occupato da alcuni cantieri di barche, Fondamenta alle Zattere, dove erano scaricati i barconi che trasportavano il legname giunto in laguna. Inizialmente l’edificio fu realizzato frettolosamente in legno: …Dicono, che l'anno 1522 fosse istituito e fabricato di Legno. Di poi principiato di muro da Pietro Contarini, che fù Vescovo di Baffo (Pafo nell’isola di Cipro). Doppo ancora riatta la Chiesa in forma ovata (ovale) da Antonio Contarini Cavalliere sul modello del Sansovino18.
Era un’ampia costruzione cui, nel 1560, si aggiunse una chiesa eretta all'interno del cortile, che fu quindi diviso in quattro più piccoli di forma triangolare, invece che sulla facciata, perché l’edificio, in forma quadrilatera, era già stato innalzato in muratura e non si volle ridurre lo spazio destinato ai ricoverati (Fig. 4).
 |
Fig. 4. Ospedale degli Incurabili. |
Nel 1565 il Senato contribuì con trecento ducati per la ricostruzione della chiesa in mattoni e pietra. Nel gennaio 1566 il cavaliere Antonio Zantani, deputado sopra la fabricha di la jexia di hospedal di Incurabili annotava che i muri erano stati alzadi fina segnal dil cornizon di sopra della corte di le monache19. Il tetto fu posto in opera nel 1568.
Il numero degli infermi crebbe rapidamente: nel 1565 erano oltre 350 e due anni dopo 450. Proprio per consentirne un ampliamento, nel 1588, il Senato concesse un finanziamento di 1500 ducati. Nel 1604 Lorenzo Zantani destinò un lascito in finir la fabricha di esso Hospedal, et finite le fabriche che non ci fosse più da fabricar vadi spesa in ornamento della Gesia di esso Hospedal19. I fondi necessari al mantenimento provenivano principalmente dalla carità privata e saltuariamente da erogazioni pubbliche. Per aumentare i primi si chiedevano elemosine e lasciti. Ai donatori era assicurata la remissione dei peccati. Gode molti previlegij Spirituali, e temporali concessi da sommi Pontefici18. Il Senato chiese ai Notai di convincere i testatori affinché stabilissero lasciti in favore delle opere pie e tra queste agli Incurabili20.
La raccolta di fondi era incrementata dall'attività di abili predicatori che con i loro sermoni richiamavano grande affluenza di popolo e conseguenti cospicue offerte. Nel 1583 l’Ospedale spese 10.000 ducati, una cifra enorme per i tempi compensata in gran parte dalla beneficienza20. Le ingenti spese di mantenimento non permisero agli Amministratori d’investire in beni immobili e ottenere così delle rendite che permettessero una gestione autonoma, come avveniva per altre istituzioni.
Fu il primo grande ospedale costruito a Venezia. Fino alla sua fondazione l'assistenza era svolta in piccole strutture affidate alla generosità di privati o sostenute dalle diverse confraternite. La direzione fu affidata a un collegio di patrizi, definiti governatori mentre i religiosi curarono la parte spirituale. Fra i primi, troviamo Pietro di Zaccaria Contarini (1491-1563) e Sebastiano Giustinian (1459-1543). Medici e personale erano stipendiati. Nel 1539 il Maggior Consiglio pose gli Incurabili sotto il patronato dogale.
Le cure per gli ammalati di sifilide erano quelle che le conoscenze mediche dell'epoca consentivano. Fino all’introduzione della penicillina le cure furono empiriche e dai risultati discutibili. I malati inizialmente furono trattati secondo i principi ippocratici, per cui bisognava eliminare l'eccesso di flemma con l'uso di sostanze che provocassero la sudorazione, come il legno guaiaco (legno santo), un albero proveniente dalle Antille, arrivato in Italia nel 1517. La famiglia Fugger, che ne ebbe il monopolio, lo vendeva a un prezzo elevato21. L'uso del decotto era somministrato per 30 – 40 giorni.
Altro medicamento molto utilizzato fu il mercurio. Questo determinava una sudorazione abbondante, ma aveva un’elevata tossicità e rendeva i denti neri, costringendo le donne che lo assumevano a limarli per nascondere di essere luetiche. Agli infermi si applicavano sulle piaghe degli unguenti con questo elemento o si eseguivano delle fumigazioni.
 |
| Fig. 5. Cura della sifilide (Xilografia, XVI secolo). |
Il malato era rinchiuso in un camerino buio riscaldato e fatto entrare in una botte da cui usciva la testa attraverso un foro (Fig. 5). Ai suoi piedi era posto un braciere in cui erano inceneriti anche cinabro, grassi, gomme e resine.
Gli infetti lamentavano stomatiti e scialorrea. Le abbondanti sudorazioni, secondo le credenze, avrebbero eliminata la malattia. In realtà spesso il paziente moriva per intossicazione da mercurio.
Il salasso fu un altro procedimento praticato: …all'Amico Anonimo, quale pretende difendere la necessità del Salasso universalmente in tutti gli infetti di Lue Venerea, prima che gli sii premesso l'ingresso nelle Stufe, quali si praticano nel pio Spedale de gl’Incurabili di Venezia: […]. Questa è una erudita sì, mà un poco troppo calda contesa, che nacque tra due doctissimi Medici in Venezia, cioè trà li Signori Dottori Simon Tosi22, e Andrea Fasuol23, de quali l'Ultimo affermava l'altro negava, che si dovesse cavare sangue a tutti gl'Infetti di Lue Gallica prima che si ponessero nella stufa24.
L'ospedale istituito al fine di ricoverare i sifilitici ospitò anche i poveri. I magistrati alla Sanità ordinarono il ricovero di ogni mendicante affetto dalla malattia e dispose anche che fosse tenuto un registro con le date di accettazione e dimissione. Nel tempo vi svolsero la loro opera Angela Merici, Francesco Saverio e Ignazio di Loyola. Vi trovarono alloggio anche diverse meretrici pentite che, come vedremo, saranno trasferite in seguito nell’Istituto delle Convertite alla Giudecca.
Nel 1531 subentrò nella conduzione Girolamo Emiliani con i suoi chierici e questi destinò una parte della struttura ad ospitare gli orfani abbandonati cui dare un’istruzione e insegnare un mestiere. Nel 1588 se ne contavano 200 che nei giorni di festa erano condotti in processione anche per suscitare commozione e invogliare le donazioni. Le giovinette che rivelavano talento musicale furono educate al canto e le loro esecuzioni, il sabato nella chiesa dell’ospedale, consentivano un altro introito nelle casse dell’Istituto. Nel 1755 si ebbe una grave crisi finanziaria e nel 1782 il Senato nominò un nuovo governo.
Il governo Napoleonico, il 18 giugno 1807, emise un Decreto riguardante l’Amministrazione degli Spedali ed altri Stabilimenti di beneficenza pubblica in Venezia. A questo fece seguito un successivo provvedimento, del 5 settembre 1807, con il quale la gestione di tutti gli ospedali, gli orfanotrofi, i luoghi pii, i lasciti e i fondi di pubblica beneficenza furono affidati a una sola istituzione, la Congregazione della Carità. Fu anche disposta la separazione degli orfani che furono affidati a strutture a loro dedicate. Per consentire maggiori economie furono soppressi l'ospedale dei santi Pietro e Paolo di Castello e quello dei Derelitti e i malati trasferiti agli Incurabili. Questo fu chiuso nel 1819, quindi divenne sede dell'Ospedale militare austriaco e poi trasformato in una caserma e la chiesa situata all’interno del cortile fu abbattuta. Nel corso del ‘900 fu adibito a Riformatorio. Oggi ospita l’Accademia di Belle Arti.
Pio Istituto delle Penitenti
Il Pio Istituto delle Penitenti, su progetto di Giorgio Massari, fu edificato nel 1730 con la chiesa, S. Maria delle Penitenti, inserita nelle ali laterali della costruzione (Fig. 6).
 |
Fig. 6. Le Penitenti. |
La facciata rimase incompleta per mancanza di fondi e l’edificio fu aperto al culto nel 1744.
Fu decisivo l’intervento dei parroci che ben conoscevano i problemi igienici, sanitari e sociali della città. Essi si rivolsero al patriarca Giovanni Badoer affinché ne sostenesse la realizzazione. La donazione più importante fu fatta da Marina Priuli da Lezze.
La giovane, per essere ospitata nell’istituto, doveva avere tra i 12 e i 40 anni ed essere senza figli. Il Parroco la presentava e garantiva che non fosse incinta e non fosse ammalata di sifilide. Una volta ammessa, per un anno, non poteva entrare in contatto con le sue compagne e doveva intraprendere un percorso spirituale con l’aiuto di una priora. In seguito imparava un’attività artigianale quale il cucito o il ricamo e qualcuna riusciva anche a sposarsi. Il Pio Istituto delle Penitenti fu amministrato da un cittadino, un patrizio e un religioso che assumeva la carica a vita di Governatore. Il primo fu l’abate Paolo Contarini le cui spoglie sono conservate nella chiesa.
Le Zitelle
Un edificio, conosciuto come le Zitelle fu destinato all’ospitalità e all’assistenza di ragazze belle e di misera condizione, per prevenire che, per le loro scarse risorse economiche, rischiassero di vendere il proprio corpo. L’Istituto si affaccia sul canale che divide l’isola della Giudecca da Venezia e guarda dritto verso Punta della Dogana (Fig. 7). Nel suo interno vi è la Chiesa di Santa Maria della Presentazione. Le giovani a rischio prostituzione erano segnalate dai parroci. Nessuno, meglio di loro conosceva chi, nella sua parrocchia, essendo di bell’aspetto ma indigente rischiava di essere avviata all’immorale carriera.
 |
Fig. 7. Le Zitelle. |
Per essere ammesse si doveva essere belle, povere e di età compresa tra i 12 e i 18 anni. L’Istituzione nacque nel 1561 per volontà del patriarca Giovanni Trevisan e per merito di Adriana Contarini che ne fu la prima governatrice e lasciò i suoi averi in dote alle giovani. A queste era impartita un’educazione che consentisse loro di aspirare a matrimoni convenienti. Fu sicuramente una grande opportunità offerta in quel periodo a delle giovanette che, nel 1583, arrivarono a toccare il numero di duecento.
La regola prevedeva il loro isolamento. Solo un giorno dell’anno, potevano uscire ed era concesso loro di andare in gita in barca ed essere ammirate ed eventualmente scelte come mogli di uomini anche importanti. Nessuna restava in permanenza ospite delle Zitelle. Si può immaginare come la segregazione richiesta a delle adolescenti non ottenesse sempre l’obiettivo di sottrarle al meretricio. Non sempre l’aspirazione di passare da una vita difficile a una possibile sistemazione soddisfacente era sufficiente a fare rispettare le severe regole imposte. Soprattutto l’isolamento obbligato, la gelosia e rivalità tra loro ne spinsero alcune alla fuga e altre ad avere incontri amorosi clandestini.
Le Convertite
Tra il 1530 ed il 1534 le prostitute pentite iniziarono ad insediarsi alla Giudecca in alcuni locali in affitto vicino a Sant'Eufemia, spostandosi quindi nell'Ospedale degli Incurabili, sul lato opposto del canale della Giudecca e qui rimasero fino al 1551, anno in cui il papa Giulio III le autorizzò ad aderire alla regola agostiniana. Il convento fu eretto nel 1543, la chiesa una decina d'anni dopo e consacrata nel 1579 alla Maddalena dal patriarca Trevisan.
Frà tanti Luoghi pij eretti in questa Religiosissima Città a beneficio de Poveri, Pupilli, Infermi, Zitelle e Vergini […] era conveniente, che anco le Donne peccatrici pentite hauessero il loro ricovero, A quell’effetto fu instituìto questo Luogo detto delle CONVERTITE, ove sono riceute le Peccatricj pentite, ma solo quelle dotate di somma beltà, acciò per la loro forma non ricadano nel peccato18. Si ritenne opportuno costruirlo in un luogo defilato rispetto alla città affinché le penitenti potessero vivere isolate per il resto della loro vita. Nel 1553 ne erano presenti 220 e nel 1620 raggiunsero il numero di 400. La grande affluenza rese necessario l’ampliamento della struttura che avvenne tra il 1595 ed il 1698 grazie a donazioni e lasciti da parte di privati che ne permisero anche la sopravvivenza. Le penitenti imparavano a leggere, a tessere e a cucire, ma molto della loro giornata era occupata dalla preghiera. Non tutte si assoggettarono alle regole imposte. Lo scandalo suscitato dal comportamento del primo rettore, padre Pietro Leon da Valcamonica, mise in discussione l’affidabilità dell’Istituzione. Questi fu accusato di avere sedotto venti ospiti e di aver fatto sparire i neonati nel canal della Giudecca. Egli ammise le sue colpe e tentò, inutilmente, di negare la responsabilità della madre superiora quale complice del suo infamante comportamento. Fu decapitato e poi bruciato tra le colonne di san Marco il 10 novembre 1561, mentre la suora morì in carcere due anni dopo. …Del prete Pietro Leon da Valcamonica, rettore e governatore del Convento delle Convertite alla Giudecca, convinto e confesso di avere avuto commercio con venti di quelle recluse non solo, ma di avere anche affogati i frutti dei suoi colpevoli amori, per cui fu decapitato fra le colonne di Piazzetta S. Marco il 10 novembre 15615.
Episodi in parte boccacceschi sono ricordati. Giovanni Bren (o Brin) il gentiluomo inglese addetto all'ambasciata d'Inghilterra che nel 1643 14 luglio, non avendo potuto avere nella gondola da traghetto che aveva preso, una bellissima monachella delle Convertite (convento che era nell’isola della Giudecca), perché accortesene le compagne spinte dall'invidia gli impedirono la fuga, l'impresa andò fallita e colto sul fatto sofferse soli 6 mesi di prigione per la provata sua giovane età et scusato per inesperienza. Egli era stato ingannato da certa Margherita Locarda mezzana del convento, la quale fu pure condannata a 4 anni di carcere5.
Il complesso terminò la sua attività nel 1806. Fu trasformato prima in un carcere militare e poi in carcere femminile nel 1837, diventato ai nostri giorni Casa di reclusione femminile di Venezia-Giudecca.
Nei diversi periodi, l’orientamento fu di accettare la prostituzione come una deplorabile necessità, per soddisfare gli impulsi sessuali maschili ed evitare disordini sociali e familiari. Per Venezia, queste donne sottoposte a severe disposizioni che ne limitarono non solo la vita pubblica, furono una fonte di ricchezza. Il governo regolò la loro attività riscuotendo notevoli profitti. Vi fu ancora una volta una disparità di trattamento tra le più misere e le grandi prostitute che si sottraevano alle discipline imposte grazie alla protezione di personaggi influenti. Le prime erano vittime di violenze e rimanevano vincolate a una vita miserabile, oppresse e ricattate da ruffiani e tenutari di postriboli.
Prof. Pasquale Alessandro Margariti, già Direttore UOC Ginecologia Columbus, Fondazione Policlinico Gemelli, Università Cattolica, Roma
Per la corrispondenza: pamarga@yahoo.it
BIBLIOGRAFIA