Anno Accademico 2023-2024
Vol. 68, n° 4, Ottobre - Dicembre 2024
Simposio: Le malattie del peccato
07 maggio 2024
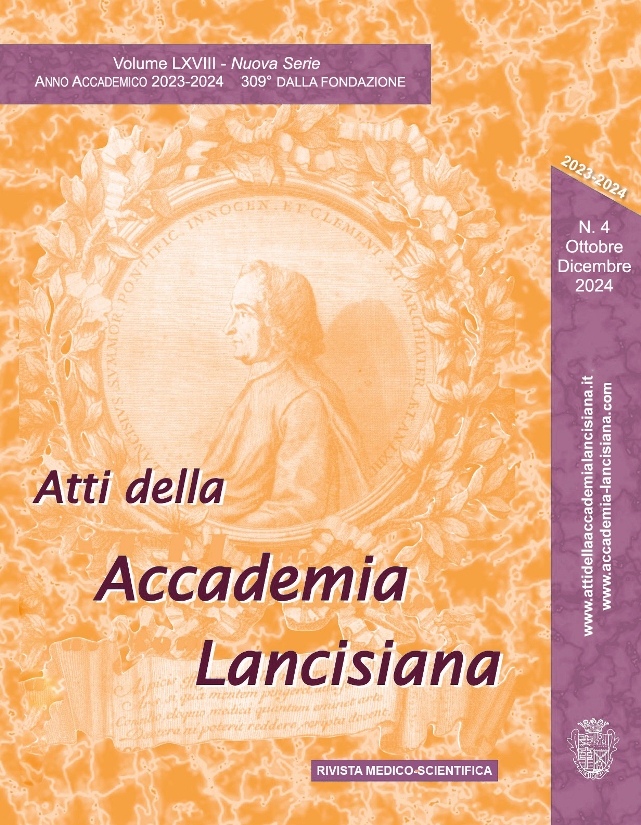
Simposio: Le malattie del peccato
07 maggio 2024
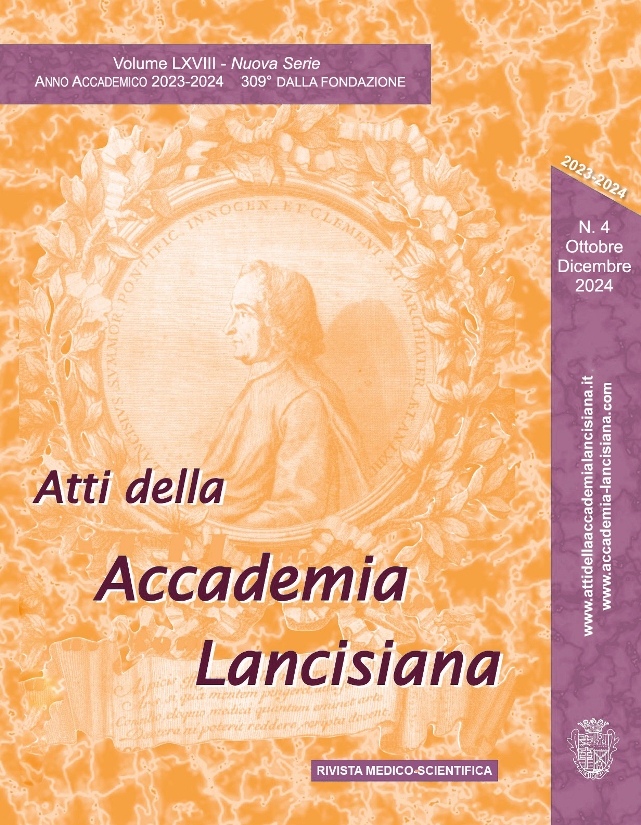
Versione PDF dell'articolo: Download
“Colui che desidera e non agisce nutre la pestilenza”
William Blake “Proverbi dell’Inferno”
Scrivere un articolo sulle malattie del peccato nella storia, rimanda ad innumerevoli suggestioni che si estrinsecano e spaziano anche intorno alla teologia, antropologia, sociologia, psicologia. Diventa riduttivo restringere il campo di indagine ed impossibile sintetizzare questo tema così interessante e pregno di significati. Quello che ci interessa è guardare proprio a questo senso dei significati che cambiano nel corso della storia rispetto a ciò che la malattia ha rappresentato nel corso dei secoli. Di grande aiuto in questo percorso ci è stata la letteratura e alcuni articoli tematici, di autori diversi, come quello di Innocenzo Mazzini1, uno storico che ha descritto questo tema in un bellissimo articolo: “La malattia conseguenza e metafora del peccato nel mondo antico, pagano e cristiano”. Nel mondo antico la malattia è sempre stata associata al peccato, un peccato commesso contro gli dei, contro Dio e contro la natura. [La convinzione che le malattie provengano dalla divinità, come punizione di un peccato, risulta documentata in tutta l’antichità greca e romana fin dai poemi omerici, sia nella letteratura pagana, sia in quella cristiana, (…) sia in quella d’arte, sia nella tradizione mitologica (…). Dal V sec. a.C. in poi circola in tutta l’antichità, soprattutto negli ambienti colti, filosofici e medici, pagani e cristiani, la persuasione che la malattia sia piuttosto, conseguenza automatica di un peccato contro le leggi della natura, contro la “Physis”].
Nelle civiltà semitiche dell’antico oriente il concetto di malattia come punizione per qualche peccato era predominante. “Lì il peccato era definito chiaramente come un’offesa volontaria verso le Leggi morali e religiose. Molte malattie, tra cui quelle mentali e i disturbi dell’affettività, venivano considerate come portate dal peccato. (…) La confessione era il mezzo per ottenere un sollievo mentale e spesso anche (…) per ottenere la guarigione”2. Nell’Iliade, vi è la più antica testimonianza di una malattia epidemica mandata dagli dei, come punizione per la colpa commessa da Agamennone di aver rapito la figlia di Crise, sacerdote del dio Apollo, (Omero, Iliade 1, 10-12).
Mazzini distingue le malattie considerate punizione per un peccato contro la divinità e contro la natura; tra le prime distingue gli dei pagani dal dio cristiano. Storiografi romani riportano epidemie di peste correlate a profanazioni di luoghi di culto, come nel caso della pestilenza scoppiata tra i cartaginesi nel 395 a.C. causata secondo lo storico Diodoro Siculo, dal loro saccheggio del tempio di Demetra e Persefone. La cecità coglie spesso chi disprezza le divinità, come attribuisce Tito Livio ad Appio Claudio, colpevole di disprezzare il dio Ercole. Le ire degli dei che si tramutano in malattie, derivano da atti deliberati, non da intenzioni o da pensieri, che danneggiano il dio come rifiuti di sacrifici, danneggiamenti di templi, spergiuri o non osservanza di promesse.
Nel dio cristiano, ampio è il richiamo all’antico testamento, come la morte dei primogeniti che colpisce l’Egitto che non lascia andare i figli di Israele riportata in Esodo (12,29).
Questo costrutto è messo in realtà in discussione nel Nuovo Testamento: in Giovanni (9,2-3) a proposito del peccato del nato cieco “chi ha peccato, lui o i suoi genitori, per essere nato cieco? Rispose Gesù: non hanno peccato né lui, né i suoi genitori”. Più in generale la malattia è descritta come conseguenza tremenda che incorre nei persecutori e nei traditori della Chiesa.
“Nell’antichità ogni malattia veniva interpretata come un messaggio divino. Le cure erano affidate a sacerdoti e sciamani. La malattia come punizione della natura è presente già nella Repubblica di Platone, ma trova nell’opera di Ippocrate, IV sec. a.C., un importante contributo. Le malattie non sono più figlie degli dèi e iniziano ad essere considerate a partire dall’essere umano e dal suo funzionamento. (…) Si pensa che la salute sia il risultato di un equilibrio dinamico tra gli umori del corpo: bile gialla, bile nera, sangue, flegma. L’equilibrio tra questi liquidi genera benessere, mentre l’eccesso di uno di essi determina un’alterazione del temperamento - collerico, melanconico, sanguigno, flemmatico - e quindi la malattia”3. Nelle Affezioni 47, o in Epidemie 6,6, Ippocrate raccomanda moderazione e sobrietà e con lui i medici come Galeno o Celso, che sottolineano modelli di dieta, sport, lavoro, sonno, attività sessuale, lontane dagli eccessi.
Ippocrate è quindi originale nel portare la malattia all’interno del funzionamento del corpo. A lui e ai romani Galeno e Celso si devono le più convinte asserzioni sulla malattia come peccato contro la natura, ma la cultura della malattia come metafora del peccato insiste nelle civiltà greca e romana e si articola in modo sottile sino ai giorni nostri.
Nel medioevo il concetto di malattia si lega a manifestazione della fragilità umana dovuta al peccato originale. La comprensione della malattia è profondamente intrecciata con le credenze religiose, superstizioni, credenze culturali che oscilla tra punizioni divine, influenze astrologiche, bilanciamento ippocratico di umori, azione di forze demoniache o maligne. L’epidemia di peste Nera del XIV secolo, punizione divina, trova risposte nelle processioni religiose, nelle quarantene ma anche nelle persecuzioni a gruppi ritenuti responsabili della diffusione della malattia come gli ebrei o i lebbrosi.
Un’interpretazione attuale di come si possa essere arrivati ad associare la malattia al peccato ci è data dal biblista frate Alberto Maggi in occasione del Congresso Regionale AIPO Marche 2016. L’uomo si è sempre posto l’interrogativo del perché delle malattie; nell’antichità con il politeismo si potevano distinguere le divinità del male da quelle del bene; con la nascita delle religioni monoteiste l’uomo ha presto cercato di eliminare gli elementi negativi attribuiti a Dio, trasferendoli all’uomo che commette il peccato. Per discolpare Dio dal male si accusava l’uomo: le malattie diventano così il castigo di Dio per i peccati degli uomini, come insegna la Bibbia: “Non giunge al giusto alcun malanno, gli empi invece sono pieni di mali (Prv12:21)”; “Chi pecca contro il proprio creatore cade nelle mani del medico (Sir 38,15)”. L’obbedienza a Dio era pertanto garanzia di vita e salute.
Per René Descartes, la malattia è interpretata principalmente attraverso la sua visione dualistica del corpo come una “macchina” o res extensa, separata ma interagentica con la mente (res cogitans). Cartesio cercava di comprendere il corpo in termini meccanici e fisici, e di spiegare come la malattia potesse essere il risultato di malfunzionamenti o disordini in questa “macchina”, il corpo umano, in termini di una macchina molto sofisticata. Nella sua opera “L'uomo” e nei suoi scritti successivi, spiega come varie funzioni fisiologiche siano paragonabili a meccanismi fisici e idraulici. La salute è mantenuta quando la macchina funziona correttamente, mentre la malattia è concepita come un disfunzionamento di queste parti meccaniche.
Nel mito biblico dell’origine del peccato nella Genesi, Kierkegaard4 vede un uomo innocente che prende conoscenza e diviene quindi un uomo libero, dopo aver commesso il peccato. Il divieto imposto da Dio ad Adamo di non mangiare il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male, angoscia Adamo, in quanto gli conferisce un potere. La vertigine della libertà è anche carica di angoscia per Kierkegaard, perché l’uomo da innocente diviene cosciente e libero di scegliere.
Esiste una corrente minoritaria del cristianesimo […] che trova espressioni diverse tutte accomunate dallo sforzo di sottrarre l’esperienza cristiana dal culto penitenziale del sacrificio. In ordine sparso l’Agostino del Commento al Vangelo secondo Giovanni, il Kierkegaard di Timore e tremore e i più recenti Rudolf Bultmann, Dietrich Bonheffer, Paul Ricoeur, il Jacques Deridda di Donare la morte [..]5.
Nell’opera di Nietzsche, ritroviamo la necessità di svincolare la vita dell’uomo dal bisogno di salvazione dal peccato, dal binomio peccato-pena, sofferenza, costruzione dell’uomo ascetico intrappolato a non godere della pienezza della sua natura umana.
Nietzsche in “Genealogia della morale” e in altri scritti, sostiene: “Ciò che propriamente fa rivoltare contro la sofferenza non è la sofferenza in sé, bensì l’assurdità del soffrire: ma un tale assurdo soffrire non ci fu in generale né per il cristiano, che ha inserito all’interno della sofferenza tutto un segreto macchinario di salvazione, né per l’uomo semplice di più antiche età, che sapeva spiegarsi ogni sofferenza in relazione a spettatori o a provocatori di sofferenza. Affinché il dolore occulto, non scoperto, privo di testimoni potesse essere tolto dal mondo e onestamente negato, si fu allora quasi costretti a inventare gli dèi”6.
Ogni malattia nel corso della storia dell’uomo diviene un luogo altro di significati, proprio perché l’uomo ha bisogno di trovare le ragioni per le quali ci si ammala. In questo modo il significante diviene prevaricante rispetto a quello che intimamente il soggetto vive con la sua malattia.
Per citare Clifford Geertz, antropologo statunitense, “l’uomo è un animale impigliato nelle reti di significati che egli stesso ha tessuto [e] credo che la cultura consista in queste reti”. Il concetto di malattia si situa perfettamente in questo ambito, in quanto al tempo stesso evento privato e sociale. Privato perché ciascuno di noi lo sperimenta, sociale perché se ne fanno carico gli altri intorno a noi. Il modo in cui se ne fanno carico è dato da un etimo che permette di dare a quel fenomeno privato un nome e una cura.
Così, specifica l’antropologo Marc Augé, laddove una società pensi l’uomo come composto di elementi caldi e di elementi freddi in armonia e la malattia si situi nello spazio di squilibrio tra questi due ordini, la cura consisterà nel loro bilanciamento; dove l’uomo è visto come agito dal principio spirituale (anima) la malattia sarà il furto o la compromissione di questa essenza vitale; laddove l’uomo è rappresentato come articolazione di una res extensa e di una separata res cogitans, la malattia sarà affezione di ciascuno di questi domini, malattia del corpo o della psiche7.
Al di là delle interpretazioni e speculazioni filosofiche l’uomo porta con sé un retaggio culturale per il quale il binomio peccato-pena, malattia-peccato è molto radicato: lo ritroviamo nella letteratura, nella esperienza clinica e nella vita quotidiana.
Alla fine degli anni Settanta, Susan Sontag scrive un pamphlet per ribellarsi all’idea della malattia come metafora, affermando che “non c’è niente di più primitivo che attribuire a una malattia un significato, perché tale significato è inevitabilmente moralistico”. Un libro importante, che ha influenzato tutti i successivi studi nel campo della medicina sociale e della psicologia medica. […] “Tubercolosi, cancro e AIDS sono state e in parte continuano ad essere,” dice, “metafore colpevolizzanti di stili di vita sbagliati”3.
Sia il mito della tbc sia quello contemporaneo del cancro suggeriscono che i malati siano responsabili della propria malattia. Ma il repertorio delle immagini connesse al cancro è molto più punitivo […] L’idea che il cancro sia una malattia derivante dal fallimento espressivo condanna il malato; suscita compassione, ma trasmette anche disprezzo8.
Nel romanzo La Chiesa della solitudine, Grazia Deledda descrive la sofferenza di una donna che si ammala di cancro al seno e non riesce neanche a dirlo, mantiene il suo segreto. La protagonista, Concezione, che vive in un senso di colpa per un rapporto d’amore avuto in gioventù e finito in tragedia, nelle sue preghiere dice: “Io non devo avere bambini: non devo averne, ed è giusto, è giusto. Tutto è giusto, nella tua volontà, o Signore. Ho peccato contro l’amore, ho seminato il dolore e distrutto la vita di un uomo; e nella mia vita tu Signore, spargi adesso il sale della sterilità. Sia fatto il tuo volere. E tu Vergine Madre, aiutami adesso ad attraversare questa mia vita desolata; guardami dall’alto della tua misericordia”. Come sottolineato dalla Sontag il silenzio è la più frequente metafora del cancro ed è la malattia delle sconfitte dei segreti e dei silenzi.
Scrive Susan Sontag: “la malattia è il lato oscuro della vita, una cittadinanza più gravosa. Ogni nuovo nato detiene una duplice cittadinanza, nel regno dei sani e nel regno degli infermi”8. Questa prima affermazione non vuole essere una metafora, ma una descrizione di due posizioni che l’uomo attraversa. Intorno alle malattie, si sono creati significati e metafore che hanno condizionato l’uomo: la tbc e il cancro sono state considerate forme di autopunizione e di tradimento di sé, come sosteneva Kafka, il fallimento generale dell’esistenza, perché è la malattia a parlare al posto del malato. Alcune malattie più di altre hanno comportato non solo un giudizio psicologico ma anche morale. La sifilide era il flagello dei trasgressori sessuali e delle prostitute, e lo stesso giudizio morale sarà applicato all’AIDS. La sifilide che si fa risalire al 1494 con l’arrivo di Carlo VIII che giunge a Napoli con il suo esercito e le prostitute che lo accompagnano, viene descritta dal protestante Josefh Grünpeck (storico dell’imperatore Federico III d’Asburgo) in questi termini: “Quando percepite la miserevole corruzione di tutta la cristianità, di tutte le abitudini encomiabili, delle regole e delle leggi, lo squallore di tutte le classi, le molte pestilenze, i cambiamenti in quest’epoca e tutti gli sconosciuti strani e avvenimenti, sapete che la fine del mondo è vicina e le acque dell’afflizione scorreranno sull’intera cristianità”9. La sifilide era ritenuta una malattia degradante e volgare e in Europa i francesi la chiamavano il male napoletano e gli italiani e gli spagnoli il male francese. La sifilide era considerata terribile, non misteriosa, le sue cause sono ben presto divenute chiare e le responsabilità erano individuali. La sifilide, così come la tbc e il cancro, è stata utilizzata per esprimere rozze fantasie sulla contaminazione, ma anche sentimenti molto complessi sulla forza, la debolezza, l’energia8.
La metafora assume una doppia valenza, quella delle rappresentazioni sociali che costringe l’uomo all’interno di significati precostituiti che paralizzano il malato all’interno di una cornice e la metafora che il malato può usare per raccontare la sua malattia. In questa ultima accezione la metafora può divenire una risorsa importante che permette di “dire qualcosa in luogo di qualcos’altro”. In questo senso partendo dall’esperienza personale si possono ricavare importanti riflessioni utili come risorsa sociale. Oggi molte biografie e narrazioni di persone che si sono ammalate hanno permesso una riflessione su come ognuno di noi vive la propria storia di malattia e in quali aspetti ci si può in parte rispecchiare. Vedi l’opera di Terzani, Pietro Calabrese, dei colleghi medici Bartoccioni, Bonadonna e Sartori: il racconto di una esperienza di malattia, vissuta come elemento di risorsa e di riscatto.
La Medicina narrativa oggi rappresenta una delle modalità di cura che permette di prendere coscienza e dare significato all’esperienza di malattia: “le narrazioni sono parte del processo di cura, sia che si tratti di racconti che la persona fa a sé stessa, nella forma di autonarrazione, sia che si tratti di racconti fatti ad altri. [..] Le narrazioni personali, osserva la Bülow, sono di genere diverso e ricomprendono le storie di vita, gli aneddoti, le storie di casi e i miti: attraverso esse si possono fondere in un medesimo processo terapeutico le esperienze individuali e collettive10.
Il lavoro dello psicologo è quello di ricondurre al soggetto esperiente il senso e il significato della sua malattia. Una nuova soggettività si affaccia nel mondo del “senso delle malattie”, ma lo stigma è sempre qualcosa difficile da gestire. Inoltre gli aspetti culturali generano pensieri che sono connaturati al nostro modo di vedere il mondo e le cose. Da quando nasciamo costruiamo il nostro modo di leggere il mondo e questo si basa su costruzioni che partono dai nostri modelli operativi interni, da come viene rappresentato il senso di responsabilità, se autodiretto o eterodiretto, il cosiddetto “locus of control” (Rotter, J. 1954) e dalla cultura in cui nasciamo.
In ambito clinico, con le pazienti oncologiche, la Dottoressa Riccardi ha potuto osservare come la soggettività dell’esperienza di malattia sia unica e irripetibile e che questo viaggio attraversi varie fasi, tra le quali si affaccia la domanda: perché a me? Cosa ho fatto di male? Queste domande rimandano ad un senso di responsabilità individuale, ad un peccato commesso. Altre persone le hanno riferito: io ho sempre condotto una vita sana e rispettato gli altri perché mi è venuta questa malattia? Questa cultura è quella cristiana della legge della retribuzione, dove l’idea della malattia è legata ad un peccato commesso. Come Giobbe (libro 14,23) rivolgendosi a Dio domanda: “Quante sono le mie colpe e i miei peccati? Fammi conoscere il mio misfatto e il mio peccato”, sono parole che reclamano una risposta alla sofferenza senza motivo. La vita di Giobbe è quella di un uomo vissuto nella fedeltà a Dio e che comunque viene colpito dalla sofferenza estrema perdendo i suoi figli, le sue proprietà ed infine anche la salute.
Scrive Pietro Calabrese in “L’albero dei mille anni”: “se penso a tutto il tempo passato nelle redazioni a parlare di niente e a scrivere sul nulla, a tutte quelle stagioni marginali del mio destino, mi viene in mente un pensiero agghiacciante: è giusto che alla fine io sia stato punito e sia caduto in questa trappola mortale del cancro”11.
Tiziano Terzani che ha raccontato il suo percorso di malattia e i suoi viaggi alla ricerca del suo senso, scrive in “Un altro giro di giostra” […] “Arrivai a pensare che quel cancro, inconsciamente, l’avevo voluto io. Da anni avevo cercato di uscire dalla routine, di rallentare il ritmo delle mie giornate, di scoprire un altro modo di guardare le cose: di fare un’altra vita. Ora tutto quadrava. Anche fisicamente ero diventato un altro”12.
Se l’interpretazione della malattia nel corso della storia rimanda sempre a qualcosa di altro, l’opera di Susan Sontag è quella di restituire la malattia al malato. Un’opera grandiosa, quella di svincolare la malattia dalla metafora e di ritrovare la soggettività dell’esperienza.
Nel corso dei secoli i significati delle malattie cambiano e si evolvono anche grazie alla ricerca che rende meno misteriose e più curabili le malattie. Sylvie Ménard, nel suo libro “Si può curare”, scrive: “fino agli anni Settanta il nome ‘cancro’ era impronunciabile. Solo il parlarne sembrava essere capace di evocarlo come per effetto di un sortilegio malefico. [..] Il tabù comincia a cadere grazie all’emergere di cure più efficaci e dalla capacità comunicativa di grandi medici” [..]13.
Che la malattia sia una costruzione sociale mutevole nel tempo risulta particolarmente evidente quando si prendono in considerazione i tumori, dal momento che le metafore e i significati ad essi associati hanno subito dei cambiamenti […] negli ultimi trenta anni. Negli anni ottanta negli Stati Uniti si assiste ad un cambiamento dei significati e delle metafore relative al cancro […] da vittima condannata, il malato passò ad essere considerato come un eroico sopravvissuto […] e la malattia rappresentata come una sfida. Questi cambiamenti hanno visto la patologia oncologica uscire sempre più dal silenzio […] ma l’immaginario è sempre coinvolto sia che si tratti di immagini e metafore di granchi o di killer, sia che si parli di un codice genetico. La differenza sta nel fatto che oggi c’è meno distanza tra l’approccio dei medici e degli scienziati e la gente comune, frutto di un aumento della informazione medica e scientifica nei mass media14.
Le diverse culture e tradizioni possono avere visioni molto diverse sulle tematiche delle malattie e del peccato. Sarebbe interessante approfondire aspetti di etnopsichiatria delle malattie. Così come ci ricorda il DSM (Manuale Diagnostico e statistico dei disturbi mentali), dove è dedicato un capitolo sull’inquadramento culturale nella esperienza di malattia.
Alcuni casi clinici in psiconcologia della Dott.ssa Riccardi
Nella mia esperienza clinica ho potuto osservare diversi modi di interpretare la malattia: una mia paziente non riusciva a dire la parola cancro; non lo aveva comunicato alla madre che vive in Romania.
Chiedo alla paziente di pronunciare in rumeno la parola cancro e quali immagini associa alla malattia. Una giovane coppia, arriva in consultazione oncologica e alla donna viene data la diagnosi di cancro, il marito le dice: “No! Se lo avessi saputo prima non avrei comprato la casa”. In queste esperienze cliniche, la parola cancro evoca immediatamente la morte, senza nessuna mediazione, l’informazione arriva diritta a quella parte del cervello che è associata alle emozioni. Subito si attiva l’amigdala e il paziente avverte uno stato di ansia, di angoscia. Una mia paziente italiana, molto religiosa, in fase terminale di malattia, soffriva perché sentiva di vivere nel peccato, dopo aver iniziato una relazione con un uomo divorziato. Il parroco del suo paese non aveva più voluto comunicarla per questa ragione. Dopo il colloquio psicologico, chiedo alla paziente il permesso di parlarne con un frate. La possibilità di poter essere comunicata con Dio di nuovo, ha reso felice la paziente nei suoi ultimi giorni di vita. In Italia è molto presente il fenomeno psicologico della rimozione o della Medicina onnipotente, dove la morte non esiste e l’idea del peccato è ancora molto presente. Questo per ricordare che i significati delle malattie e le loro metafore sono anche legate alla cultura di appartenenza.
Conclusioni
Finché la malattia sarà vista nella sua veste ontologica come significante e la sua ermeneutica attribuita alla società, l’uomo sarà costretto a difendersi dal pregiudizio oltre che dalla malattia stessa. L’unico significato metaforico possibile è quello individuale, quello che racconta il paziente stesso. Il significato che un paziente porta allo psicologo è quello che nasce nella sua storia di significati e che può essere utile esplorare ed attraversare per arrivare ad una guarigione psicologica che accompagna il percorso di malattia.
Un aspetto psicologico importante che va sottolineato è il senso di peccato verso sé stessi che la malattia può ingenerare, per non aver compreso la bellezza della vita, per averla sprecata. La malattia diviene una comunicazione, una reazione o semplicemente un risvolto all’indolenza.
Queste reazioni possono arrivare a portare chi si ammala alla depressione ma, spesso la consapevolezza trasforma il senso di peccato verso sé stessi in una crescita post traumatica, che svela la metafora e riconduce il soggetto alla sua biografia.
La malattia diviene risorsa e non peccato, luogo di riflessione sui significati più pregni dell’esistenza che solo il senso di finitudine può evocare.
Dott.ssa Silvia Riccardi, Dirigente Psicologo DSM, ASL Roma 1
Dott. Andrea Giambartolomei, Dirigente Psichiatra DSM, ASL Roma 1
Per la corrispondenza:
silvia.riccardi@aslroma1.it
andrea.giambartolomei@aslroma1.it
BIBLIOGRAFIA