Anno Accademico 2023-2024
Vol. 68, n° 4, Ottobre - Dicembre 2024
ECM: Le arteriopatie del tratto femoro-popliteo: tradizione ed innovazione
21 maggio 2024
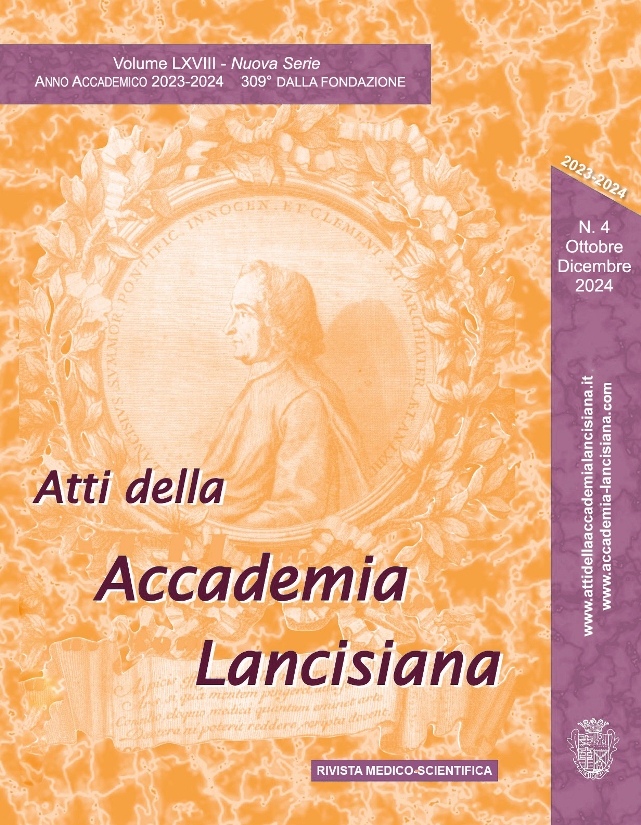
ECM: Le arteriopatie del tratto femoro-popliteo: tradizione ed innovazione
21 maggio 2024
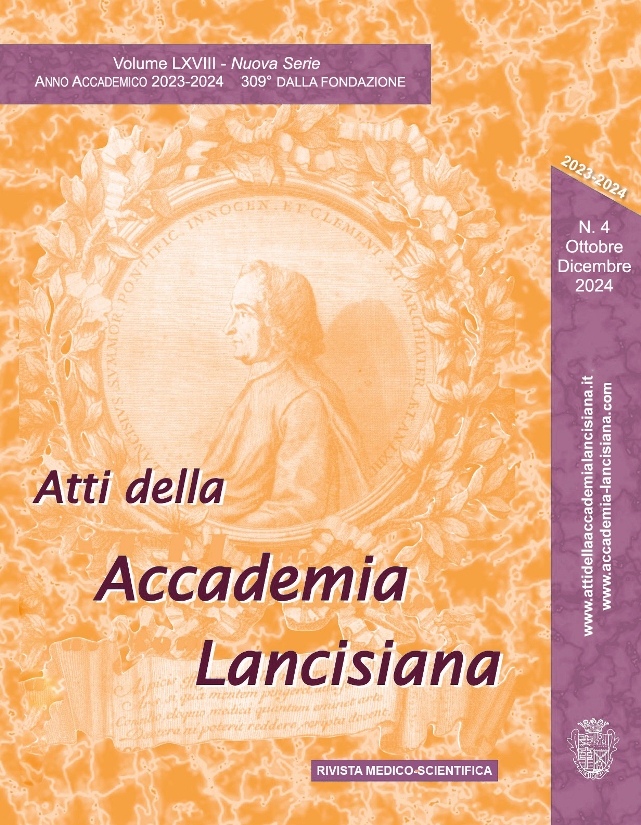
Versione PDF dell'articolo: Download
Secondo le stime più recenti, la prevalenza della malattia delle arterie periferiche (PAD) ha raggiunto proporzioni pandemiche, con oltre 236 milioni di persone affette da PAD in tutto il mondo1.
Circa la metà dei pazienti con PAD sintomatica necessita di rivascolarizzazione degli arti inferiori nel corso della vita, elettivamente per trattare una grave claudicatio o per salvare gli arti in pazienti che presentano ischemia acuta o critica degli arti. Pertanto, la PAD rappresenta un grave problema di sanità pubblica con importanti implicazioni per l’economia e l’assistenza sanitaria.
I pazienti con PAD sintomatica generalmente hanno un'aterosclerosi più severa e più frequentemente poli-distrettuale rispetto a quelli con malattia coronarica (CAD) e malattia cerebrovascolare (CBVD)2. Secondo quanto riportato da Jansen e coll, il 61% dei pazienti affetti da PAD sono affetti anche da CAD e/o da CBVD3.
Questo rende ragione del fatto che, nonostante il miglioramento delle opzioni terapeutiche, il tasso di mortalità nei pazienti affetti da PAD è sostanzialmente maggiore rispetto alla popolazione generale.
Attualmente l’incidenza annuale degli interventi di rivascolarizzazione degli arti inferiori per arteriopatia ostruttiva cronica periferica è pari a 41,2 per 1.000 anni-persona con circa il doppio delle procedure endovascolari rispetto a quelli di chirurgia a cielo aperto4.
Questo ha importanti implicazioni cliniche legate al fatto che la mortalità è ancora maggiore dopo una rivascolarizzazione endovascolare o chirurgica per PAD, come dimostrato da Heikkila e coll. in ampio studio retrospettivo di popolazione che ha incluso 164.845 pazienti sottoposti ad intervento per PAD5.
Nell’ambito del follow-up dopo interventi di rivascolarizzazione arteriosa periferica, gli eventi correlati alla procedura sono più frequenti subito dopo la rivascolarizzazione e successivamente diminuiscono gradualmente mentre aumenta nel tempo il rischio di morte e di eventi cardiovascolari maggiori.
Il follow-up dei pazienti sottoposti a rivascolarizzazione arteriosa periferica dovrebbe, pertanto, essere mirato a diagnosticare e trattare le recidive di lesioni target e non target prima della perdita di pervietà ma anche ad attuare ed implementare strategie terapeutiche per ridurre la progressione delle malattie cardiovascolari e la mortalità ad esse correlata.
Per quanto attiene il mantenimento a lungo termine della pervietà dell’asse arterioso trattato, l’insorgenza di stenosi di vasi target e non target andrebbe prevenuta con rigoroso controllo dei fattori di rischio e con terapie farmacologiche ottimali per l’aterosclerosi anche se può, comunque, configurarsi la necessità di un reintervento per correggere le eventuali nuove stenosi evidenziate con una accurata sorveglianza clinica e strumentale.
Secondo le attuali linee guida internazionali, i protocolli per il follow-up dopo interventi per PAD dovrebbero variare in base all’indicazione alla rivascolarizzazione, al tipo di rivascolarizzazione effettuata ed alle condizioni cliniche del paziente6.
La sorveglianza clinica e strumentale dovrebbe prolungarsi per tutta la vita dei pazienti operati per PAD, soprattutto, in quelli trattati per ischemia critica degli arti inferiori (CLI).
Il timing e le modalità di tale sorveglianza differiscono in relazione al tipo di rivascolarizzazione eseguita, chirurgica o endovascolare, essendo la valutazione clinica, la misurazione dell’ABI ed i controlli ecocolorDoppler più frequenti nei pazienti trattati chirurgicamente ed in tutti quelli operati per CLI, indipendentemente dalla tecnica chirurgica o endovascolare utilizzata. L’impiego dell’angioTc nel corso del follow-up è indicato per la conferma diagnostica di complicanze evidenziate con le metodiche ultrasonografiche.
È ampiamente dimostrato che la diagnosi precoce ed il trattamento tempestivo delle lesioni steno-ostruttive ricorrenti o di nuova insorgenza del distretto trattato può garantire buoni risultati a lungo termine e il salvataggio dell'arto7.
Nel lungo termine, il fallimento della rivascolarizzazione periferica è dovuto principalmente alla progressione della malattia a livello di arterie a monte o a valle del bypass o del sito di angioplastica/stent. Ne consegue che nel contesto del follow-up a lungo termine, particolare attenzione deve essere prestata ai diabetici, ai pazienti con malattie renali croniche e ai soggetti malattia aterosclerotica polidistrettuale.
A tal fine, tutti i pazienti sottoposti a rivascolarizzazione per arteriopatia ostruttiva cronica periferica dovrebbero continuare con le terapie mediche ottimali per rallentare la progressione dell'aterosclerosi e mitigare l'impatto negativo dei fattori di rischio. In particolare, l’inibizione di PCSK9 con evolocumab, abbassando l’LDL, riduce significativamente il rischio di eventi cardiovascolari e di eventi avversi ricorrenti agli arti dopo rivascolarizzazione periferica.
Sebbene la scelta del trattamento farmacologico migliore dopo rivascolarizzazione periferica sia ancora oggi oggetto di numerosi studi, la terapia a lungo termine con antiaggreganti piastrinici (ASA, clopidogrel, ticagrelor, and vorapaxar) rimane una pietra miliare per ridurre gli eventi aterotrombotici e migliorare la pervietà e il salvataggio d’arto8.
Le maggiori controversie relativa alla terapia farmacologica riguardano l’impiego della doppia antiaggregazione piastrinica (DAPT) e la durata di quest’ultima.
Le attuali linee guida raccomandano la DAPT con aspirina e clopidogrel per almeno 1 mese dopo la rivascolarizzazione endovascolare9. Tuttavia, non ci sono prove sufficienti per determinare per quanto tempo dovrebbe essere mantenuta la DAPT.
In una recente meta-analisi, rispetto alla monoterapia con aspirina, la DAPT ha ridotto gli eventi avversi cardiaci e cerebrovascolari maggiori e la mortalità ed ha ridotto le complicanze della rivascolarizzazione della lesione target10. In un altro studio Cho e coll. hanno dimostrato che la DAPT è indicata dopo rivascolarizzazione endoluminale e quando prolungata per più di 6 mesi si associa ad una riduzione di complicanze a carico dell’arto trattato e di eventi cardiovascolari maggiori, senza una significativa maggiore incidenza di emorragie gravi o fatali11. Due studi randomizzati in corso, ASPIRE-PAD12 e LONGDAPTPAD13, stanno valutando se un trattamento DAPT prolungato, vale a dire più di 12 mesi, potrebbe portare a risultati migliori senza aumentare il rischio di sanguinamento. Sono necessari studi futuri per identificare la durata ottimale della DAPT nel trattamento dei pazienti con PAD dopo un intervento sugli arti inferiori.
Recenti studi hanno dimostrato che un nuovo regime a doppio percorso (anticoagulante più aspirina) è più vantaggioso della terapia antipiastrinica dopo rivascolarizzazione della PAD. Seguendo le fasi delle evidenze dello studio COMPASS14, lo studio randomizzato VOYAGER PAD ha valutato l'efficacia di rivaroxaban aggiunto alla terapia antipiastrinica per ridurre il rischio ischemico nei pazienti sottoposti a rivascolarizzazione chirurgica o endovascolare per PAD.
Dai dati Voyager PAD, rivaroxaban più aspirina è stato associato a un’incidenza significativamente inferiore di morte, complicazioni legate agli arti e cardiovascolari. Sebbene i sanguinamenti maggiori siano risultati aumentati nel gruppo rivaroxaban, i sanguinamenti fatali o critici non sono aumentati. Dai dati Voyager PAD, rivaroxaban più aspirina è stato associato a un’incidenza a 3 anni significativamente inferiore di morte, eventi cardiovascolari maggiori, ischemia acuta, amputazione e complicazioni legate agli arti rispetto ai pazienti trattati con ASA a fronte di un aumento di sanguinamenti non fatali o critici verificatisi nel gruppo rivaroxaban15. Altre possibili strategie terapeutiche per migliorare i risultati a lungo termine della rivascolarizzazione periferica includono l’impiego di cilostazolo che ha un possibile effetto sulla ri-endotelizzazione mediata dal fattore di crescita degli epatociti e dalle cellule precursori endoteliali, oltre a inibire la proliferazione delle cellule muscolari lisce e l'adesione dei leucociti all'endotelio, esercitando così un effetto antinfiammatorio. Questi effetti possono suggerire una potenziale efficacia del cilostazolo nel prevenire la restenosi e nel promuovere l’esito a lungo termine degli interventi di rivascolarizzazione.
L’aumento dello stress ossidativo e la compromissione dell’autofagia inducono disfunzione endoteliale e promuovono le complicanze aterosclerotiche della PAD, sia prima che dopo la rivascolarizzazione; in questo ambito l’impiego di una miscela di trealosio, spermidina, nicotinamide e polifenoli in aggiunta alla restante terapia medica, può indurre una down-regulation dello stress ossidativo mediato da NOX2 e il miglioramento dell’autofagia e della funzione endoteliale dei pazienti trattati per PAD16. I dati di letteratura più recenti inducono a considerate le potenzialità della Medicina rigenerativa, della terapia cellulare, della terapia mirata, della terapia genica, della nanoterapia nell’ambito delle terapie farmacologiche combinate nella gestione della PAD e dei pazienti operati per questa patologia. In particolare, la terapia genica impiegando materiale genetico come ribosomi del fattore di crescita endoteliale vascolare, del fattore di crescita dei fibroblasti e del fattore di crescita degli epatociti determina un’angiogenesi terapeutica17.
Analogamente, la somministrazione di cellule mesenchimali o cellule di derivazione midollare è in grado di attivare meccanismi citoprotettivi e rigenerativi inducendo una neoangiogenesi per migliorare l’accoglimento arterioso distale e la perfusione dell’arto dopo rivascolarizzazione18.
Per la terapia PAD, i fattori di crescita in combinazione con nanoparticelle e le nanosfere legate con eparina potranno in futuro essere impiegati nel trattamento come modalità di somministrazione e per il trattamento costante dei pazienti affetti da PAD prima e dopo rivascolarizzazione19.
L’intelligenza artificiale, utilizzando reti neurali per l’analisi integrata di dati clinici, demografici e strumentali in particolare dei rilievi ultrasonografici, può migliorare il valore predittivo delle attuali metodiche diagnostiche impiegate nel follow-up dei pazienti trattati per PAD implementando l’outcome a breve e lungo termine delle procedure di rivascolarizzazione effettuate20.
Conclusioni
Non esistono ancora strategie univocamente concordate per migliorare i risultati a lungo termine della rivascolarizzazione degli arti inferiori.
In relazione alla complessità della PAD che si presenta sempre in pazienti con diverse comorbidità, è necessario un approccio multidisciplinare per l’ottimizzazione della terapia medica ed un accurato controllo dei fattori di rischio per l’aterosclerosi.
La perdita al follow-up dopo procedure vascolari è associata ad esiti complessivi peggiori e ad un significativo aumento del rischio di mortalità, è pertanto indispensabile un’attenta sorveglianza clinico-strumentale dei pazienti operati per PAD per garantire la pervietà del distretto arterioso rivascolarizzato e minimizzare i rischi di eventi cardiovascolari maggiori.
Le nuove strategie terapeutiche emergenti, in alternativa o in combinazione con le attuali terapie per la PAD, potrebbero rappresentare una prospettiva promettente per un trattamento più efficace dei pazienti operati.
Prof.ssa Ombretta Martinelli, Prof. Simone Cuozzo, Prof. Enrico Sbarigia, Prof. Roberto Gattuso, Prof. Luca Di Marzo, Prof. Wassim Mansour, “Sapienza” Università di Roma
Per la corrispondenza: ombretta.martinelli@uniroma1.it
BIBLIOGRAFIA