Anno Accademico 2023-2024
Vol. 68, n° 4, Ottobre - Dicembre 2024
Simposio: La tutela della madre e del fanciullo nell'800 e nel '900
04 giugno 2024
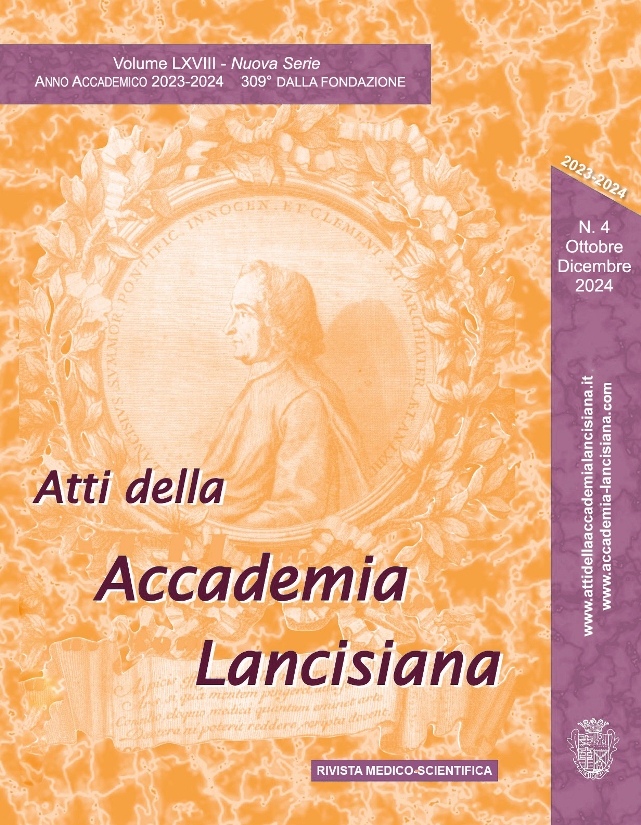
già Ricercatrice Istituto Clinica Pediatrica Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
Simposio: La tutela della madre e del fanciullo nell'800 e nel '900
04 giugno 2024
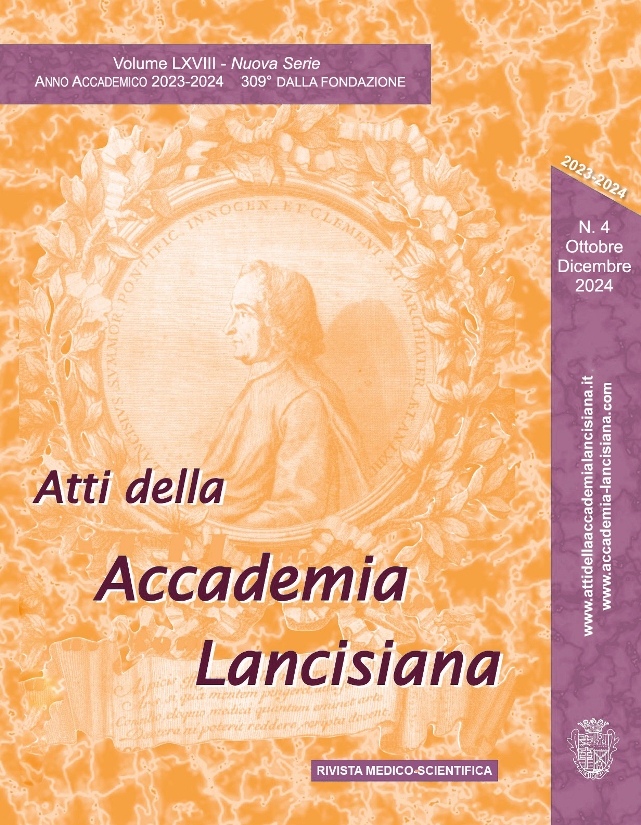
Versione PDF dell'articolo: Download
Assicurare la salute e le cure alle madri, prima e durante il parto, nel puerperio e ai neonati fu una delle maggiori difficoltà che i medici furono costretti ad affrontare fino alla metà del XX secolo. La visita del dottore e il costo delle cure erano insostenibili per le fasce sociali più deboli. Solo quando s’intervenne politicamente e furono istituite strutture adeguate e soprattutto gratuite, si poterono ottenere i primi risultati positivi. Istituzioni per i bambini abbandonati erano sorte e gestite grazie alla generosità privata, ma erano insufficienti e anche prive di assistenza sanitaria. Le condizioni dei brefotrofi erano pessime, lo dimostra l’elevata mortalità infantile che raggiunse cifre impressionanti. Negli ultimi anni dell’Ottocento, in quello dell’Annunziata a Napoli, arrivò al 95%, in particolare nel 1895 su 856 lattanti ammessi, solo 3 superarono l’anno di vita. Jessie Jane White (1832-1906), giornalista inglese, fervente sostenitrice del Risorgimento, sposata con il patriota italiano Alberto Mario e autrice di numerose pubblicazioni li aveva definiti “il luogo destinato all’infanticidio legale” e si disse convinta che, se l’amministrazione delle opere pie fosse stata affidata alle donne, in dieci anni, sarebbero scomparsi l’infanticidio e l’abbandono infantile1. Ci fu anche chi propose di incidere sul loro ingresso il sarcastico motto: “Qui si uccidono bambini a spese dello stato”2.
 |
| Tab. 1. Mortalità infantile in Italia negli anni 1890, 1900, 1937 su 1000 nati vivi4. |
Soltanto alla fine dell’Ottocento, nei brefotrofi, entrarono i medici. Nei primi anni del Novecento le condizioni non erano particolarmente mutate. Al termine della prima guerra mondiale molti istituti furono costretti a respingere un gran numero di bambini che avevano la necessità di essere assistiti. I lattanti morivano soprattutto durante il primo anno di vita, prevalentemente per malattie dell’apparato respiratorio o per gastroenteriti dovute a un’alimentazione non idonea nel periodo in cui avrebbero avuto bisogno di un adeguato allattamento al seno (Tab. 1). Nei brefotrofi, nel 1880, la sifilide fu la causa del 6,15% dei decessi e questi erano cinque volte più frequenti rispetto a quelli dei bambini allevati in famiglia3. La trasmissione della malattia avveniva soprattutto nei figli abbandonati delle prostitute, i quali infettavano le balie che spesso ne allattavano più di uno nello stesso periodo.
Nel 1917 su 691.207 bambini nati vivi ne morirono 109.307 nel primo anno di vita. La mortalità fu più alta negli illegittimi 304/1000, rispetto ai legittimi 151/10005. Altre cause di mortalità, sia materna sia neonatale, furono i traumi ostetrici, dovuti spesso all'impreparazione delle levatrici che assistevano i parti tra le mura domestiche e richiedevano l’assistenza medica spesso tardivamente. Nelle partorienti, tra il 1922 e 1935 si registrò una mortalità pari a 280 morti su 100.000 parti. Il 93% delle nascite, alla metà degli anni trenta, avveniva in casa e in 900 parti su 1000 era presente la sola levatrice. “Per un milione di nuovi nati ogni anno muoiono 3.000 e più madri proprio per dare nascimento al figlio, nel momento del nascimento del figlio, nella stessa ora: capite, nasce il figlio muore la madre. Doloroso invero! … circa 2.000 muoiono ancora ogni anno per infezione puerperale su 10.000 che ogni anno ne ammalano. Così son circa 5.000 madri che muoiono ogni anno per la loro maternità od in conseguenza di essa”6.
La malnutrizione e soprattutto le condizioni di vita furono causa di patologie invalidanti. Il rachitismo e l’osteomalacia furono responsabili delle più frequenti alterazioni ossee soprattutto nelle aree più depresse e povere del Paese. Il primo, patologia dell’infanzia sconosciuta nei paesi tropicali, imputabile al deficit della vitamina D nella dieta e alla scarsa esposizione ai raggi solari, insorgeva nei primi sei mesi di vita fino alla caduta dei denti decidui ed era molto diffuso in Italia. La malattia cagionava alterazioni di forma, alterato sviluppo delle ossa e conseguente deformità del bacino. Furono soprattutto gli studi biochimici che permisero di comprendere le alterazioni dei minerali inorganici e portarono alla scoperta nel 1919, da parte di Huldchindsky, del potere antirachitico delle radiazioni ultraviolette dovute alla luce solare, mentre la vitamina D - antirachitica - fu isolata nel 1925, da Windaus. L’incidenza di tale patologia in passato era molto elevata: per Kassowitz nell’Ottocento era colpito il 90% dei bambini delle classi povere. Concetti osservò come 1/3 dei piccoli visitati negli ambulatori della Clinica per Malattie Infettive di Roma nel 1898, ne fosse affetto. Marfan, nel 1923, lo riscontrò nel 40% di quelli tra i tre mesi e i tre anni giunti all’osservazione negli ambulatori ospedalieri7.
L’osteomalacia con il miglioramento delle condizioni igieniche e sociali è una patologia in pratica estinta nei paesi occidentali. Fino alla prima metà del Novecento non se ne conosceva chiaramente l’eziopatogenesi e si riteneva che fosse dovuta a una grave alterazione del ricambio del calcio su base endocrina. La sintomatologia era caratterizzata da forti dolori esacerbati dalla pressione e diffusi al bacino che frenavano i movimenti e la stazione eretta e si aggravava a ogni successiva gravidanza. La malattia si manifestava dopo la pubertà, la decalcificazione interessava il rachide, il bacino e gli arti e questi, sottoposti al normale carico, tendevano a incurvarsi e deformarsi. Le alterazioni conseguenti ostacolavano o impedivano la nascita. Poteva insorgere dopo il parto o nel corso della gestazione e per evitarne l’aggravarsi si giunse alla castrazione chirurgica o radiologica per impedire nuovi concepimenti. L’ostetrico Gaetano Casati (1838-1897) ne identificò la causa nelle condizioni miserrime della popolazione. “Tutte le nostre donne provengono da comuni miserabili, dove è scarso l’alimento, costituito per la massima parte da minestre di riso e più di spesso di pane fatto di zea mais ammuffito e alterato, quasi tutte sono addette ad opifici e specialmente alla lavoratura e tessitura dei filati di cotone, di cui sono frequenti ed estesissime fabbriche in quei circondari, alloggiano assai malamente, raccolte in molte stanze male aerate, mal riparate, cui il vetro delle finestre è quasi sempre rimpiazzato da un sottile foglio di carta, che alla più piccola causa si lacera e non viene né subito né convenientemente riparato e, particolarmente nel circondario di Gallarate, pregne di umidità, sia che questa provenga dal sorgere le case sopra un terreno argilloso, sia dall’essere parecchie di esse inferiori d’assai al livello dei cortili e delle strade, cioè quasi cantine, costruite così a bella posta, onde col loro umidore mantenessero una certa morbidezza dei fili di cotone e ne impedissero il facile spezzarsi… Quasi tutte hanno figliato molte volte, sempre allattato la loro immensa prole e per molti mesi e non contente di ciò porsero il seno ad altro bambino col secondo latte (come dicono comunemente) dopo divezzato il proprio, sono male riparate nell’inverno con abiti logori ed insufficienti, tormentate quasi sempre dal bisogno, dall’inopia (mancanza totale dei mezzi di sussistenza), e dal terribile fantasma della miseria e del non poter sopperire ai bisogni propri e della famiglia, non vedono mai o raramente carne o vino durante tutto l’anno, sicché anche queste donne che non ammalano di osteomalacia invecchiano innanzi tempo, e smagriscono e si deformano così da non riconoscere a 35 anni quelle donne, che già balde e belle e rubiconde ti apparivano a venti. Se noi ora confrontiamo queste cause con quelle notissime già indicate dagli autori troviamo più che sufficientemente spiegato il perché il prodursi dell’osteomalacia nelle nostre donne, segnatamente nei siti più manifatturieri e dove il grosso guadagno dei proprietari contrasta colla miseria dell’operajo, e la splendida villa coll’insalubre e meschino abituro”8.
La Pediatria si costituirà come specialità medica tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento in Europa e in America. In Italia nel 1890 si tenne il primo Congresso Pediatrico Nazionale che si concluse con un ordine del giorno che auspicava l’istituzione di una Società Pediatrica Italiana che sorse solo nel 1898. I pediatri erano sempre più convinti che le malattie fossero spesso la diretta conseguenze delle carenze igienico e nutrizionali e sostennero come il bambino dovesse essere curato nella sua specificità. L’osservazione diretta e una peculiare preparazione erano indispensabili per visitare il neonato e il lattante; per curarlo non era sufficiente ridurre la dose dei farmaci destinati agli adulti. L’attenzione si concentrò soprattutto sui piccoli da 0 a 7 anni quando i bisogni di cura sono maggiori e addirittura indispensabili.
 |
| Fig. 1. Cartolina del 1901 in favore della Società Protezione dei Fanciulli di Milano. |
Durante il II Congresso Nazionale, svolto a Napoli nel 1892, fu evidenziato come fossero necessari provvedimenti per porre rimedio alla triste situazione dei bambini abbandonati, dei figli delle madri costrette a lavorare fuori di casa, dei disastri dell’alimentazione artificiale, dell’elevata mortalità infantile. Nel 1893 fu istituita, per iniziativa di privati cittadini, la Società Nazionale di Protezione dell'Infanzia (Fig. 1) con lo scopo di favorire l'allattamento materno e vigilare su quello mercenario, proteggere i bambini dai maltrattamenti e dall'abuso dei mezzi di correzione e diffondere l'igiene infantile.
 |
| Fig. 2. Cartolina per il XXV anniversario dell’Istituzione pro Infanzia. |
La Società era articolata in Comitati Provinciali, di almeno 50 membri ciascuno, con i loro Consigli Direttivi e da un Consiglio Centrale di 60 soci. Fu favorita l’istituzione di strutture per il ricovero e la cura dei neonati, dove era auspicata la presenza del medico che li visitava periodicamente e suggeriva alle madri provvedimenti igienico-sanitari che tuttavia non potevano risolvere le scadenti situazioni familiari. Si dovevano predisporre anche di spazi per l’allattamento mercenario con nutrici sane, adeguatamente preparate e ben retribuite. Accanto agli istituti per lattanti e slattati furono promosse altre strutture per assistere le madri povere in difficoltà, seguendo l’esempio di analoghe istituzioni estere (Fig. 2).
A Firenze entrò in funzione uno dei primi ospedali in Europa dedicato esclusivamente alla cura dei bambini. Prese il nome dal russo Giovanni Meyer che lo fece costruire nel 1891, in ricordo della moglie morta. Il direttore Giuseppe Mya, nel 1905, rilevò come mortalità e morbilità infantile fossero correlabili alle condizioni di vita: lo spazio pro-capite negli alloggi, l’igiene e la disponibilità di acqua potabile e la mancanza o insufficienza dell’allattamento al seno.
 |
| Fig. 3. Balia. |
La corretta alimentazione, soprattutto nel primo e nel secondo anno di vita, fu uno dei maggiori problemi, nel XIX secolo e nella prima metà del XX, la cui soluzione non fu facile. Una delle difficoltà per allevare i figli che le madri povere dovevano affrontare era la scarsità del latte, dovuta a un’alimentazione insufficiente. La lavoratrice che non aveva la possibilità di allattare spesso non aveva neanche la possibilità di comprare latte vaccino fresco e conservarlo in modo igienicamente sicuro per evitare le gastroenteriti, spesso fatali. L’alternativa era l’affidamento a balia (Fig. 3), largamente praticato in ogni classe sociale, ma con costi e risultati assai diversi. Tra perdere il lavoro per allattare l’ultimo nato o tornare in manifattura, subito dopo il parto, per guadagnare quel poco che serviva per vivere, la scelta era obbligata. Una ricerca condotta nel 1903, dimostrò che il 68% dei lattanti moriva se la madre lavorava in fabbrica e non poteva garantire al figlio l'allattamento al seno9. Molte affidavano il neonato al brefotrofio. Sarebbero tornate a prenderlo dopo che era stato svezzato. In molti casi però non lo avrebbero ritrovato vivo: la mortalità era assai elevata proprio per la mancanza delle cure materne e per l’altissima esposizione a gravi patologie. Per una donna povera il baliatico rappresentava un’opportunità lavorativa, anche se saltuaria. Meno denaro si aveva per pagarla, peggiore era il trattamento. Una nutrice indigente e malnutrita che viveva in pessime condizioni igieniche e spesso allattava più di un bimbo non ne garantiva certo il benessere. Quando non era assunta da una famiglia, offriva i suoi servizi al brefotrofio, ma percepiva un salario inferiore e inoltre era ospitata nell’istituto e obbligata a rispettarne le disposizioni. Tra queste vi era il divieto di allattare il proprio figlio per evitare che questo fosse favorito9.
In seguito alle segnalazioni, da parte della Società Italiana d’Igiene, del rischio che le balie potessero essere contagiate dai neonati affetti da sifilide, il ministro dell’Interno Giovanni Nicotera (1831-1894) disponeva nel 1887 che gli esposti fossero accolti negli istituti solo dopo che un medico avesse escluso l’infezione luetica materna10.
Il Regolamento Sanitario del 1901 prescrisse, per escludere la possibilità che la nutrice l’avesse contratta allattando infanti affetti, che questa fosse munita di certificazione attestante la sua buona salute, ma l’attestazione si basava solo sull’osservazione clinica. Solo dopo che il biologo Friz Schaudinn (1871-1906) e il dermatologo Erich Hoffmann (1868-1959) isolarono nel 1905 il Treponema pallidum e grazie soprattutto agli studi di August von Wassermann (1866-1925) che un anno più tardi mise a punto l’esame sierologico fu possibile ottenere una diagnosi di certezza.
Per salvare i più piccoli era necessario convincere la madre ad allattare. L’alimento materno era allora, come oggi, il migliore nutrimento e la migliore difesa dalle malattie. Dalla metà dell’Ottocento vi fu l’impegno soprattutto da parte dei medici, per istituire strutture finalizzate a tal fine.
 |
| Fig. 4. Cartolina inizi '900 in favore dei ricoveri dei lattanti e slattati, Milano. |
Per favorire l’allattamento materno o in alternativa il baliatico o la distribuzione di latte, nacquero i primi centri di assistenza e di aiuto. Essi avevano il fine di fornire il nutrimento ai neonati, le cui madri per indisposizione o in mancanza di mezzi non potevano alimentarli. In Lombardia il primo “Istituto per lattanti e slattati” sorse a Milano nel 1850 (Fig. 4), grazie all’impegno del filantropo Giuseppe Sacchi (1804-1891), seguace e amico del sacerdote e pedagogista Ferrante Aporti (1791-1858), già fondatore dei primi asili per l’infanzia.
Egli s’ispirò alla “Maison de crêches” (Casa della culla) fondata a Parigi nel 1844 da Jean-Baptiste Firmin Marbeau (1798-1875). Questa aveva messo a disposizione, al piano terra di un edificio con un piccolo cortile, tre sale. In una vi erano dodici culle donate da alcune benefattrici, nella seconda una cucina per prepararvi i conforti destinati ai lattanti e asciugarvi la biancheria, la terza era destinata ai bambini slattati, che non avevano ancora l’età per essere ammessi agli asili. Sacchi dopo aver incontrato madame Villarmè, ispettrice delle crêches parigine, in visita a Milano propose, “Colla scorta dei lumi pratici da questa profferitici e col concorso dei medici…”, di istituire “Case di Custodia” per lattanti e slattati, inferiori a due anni e mezzo, “figli di madri povere e oneste”, che lavorassero fuori di casa. La necessità di diffondere questi istituti di assistenza, era improrogabile, bastava osservare la differente morbilità e mortalità tra bambini poveri e quelli appartenenti alle classi agiate. Sacchi, diede alcuni consigli suggeritegli dagli studi e da una lunga pratica nell'amministrazione degli ospizi milanesi:
1. “si procuri di sollevare da ogni fatica e di circondare delle maggiori cure la donna indigente quando assume la maestà di madre e mette in luce il portato delle sue viscere, ed è meritevole d'imitazione l'esempio riportato nella Memoria dei soccorsi alle puerpere fra le operaje di Mulhouse;
2. si aprano piccoli asili di lattanti presso o possibilmente negli opifici dove lavorano madri operaje, il che rende più facile, più comodo, meno dispendioso il beneficio;
3. destinare altri locali separati pei bambini divezzati, ai quali basta un minor numero di custodi, e dove le madri non sono obbligate a recarvisi nella giornata;
4. sia avviato un sistema educativo di allevamento dei bambini per opera dei medici e delle visitatrici di questi asili, onde distruggere tanti pregiudizi e dannose abitudini”11.
In Italia erano state adottate altre iniziative, precedenti alle istituzioni francesi, a favore dei lattanti da parte d’imprenditori illuminati, come quella voluta “dal signor Cairati in Lomellina a sussidio delle povere contadine, quello istituito nel 1840 dal negoziante Michele Bravo nel suo filatoio di seta di Pinerolo per i lattanti delle sue trecento operaie e quello per i figli degli operai delle cartiere Cini a San Marcello in Toscana nel 1842”12.
Ernesto Pestalozza, professore di ostetricia, istituì un “centro di Aiuto Materno” a Firenze nel 1901. Il pediatra Gaetano Finizio aprì a Bologna, nel 1907, un “lactarium per …l’assistenza ai lattanti poveri legittimi…” dove erano forniti biberon di latte già pronti e indicazioni per l’allevamento del bambino13. I risultati ottenuti produssero una prima significativa riduzione della morbilità e della mortalità infantile. Le richieste di assistenza andarono aumentando tanto che fu proposta la creazione di centri simili in altre città.
Dalla metà del XIX secolo iniziarono gli studi per ottenere sostituti al latte materno, attraverso la modifica di quelli animali (vacca, capra, asina) che se non modificati erano assai squilibrati nell’apporto dei vari elementi (grassi, zuccheri, proteine). Ricerche sui primi “latti umanizzati”, furono svolte da Cumming14, da Chalvet15 e da Marchand16. Klemm sostenne che il latte d’asina fosse il più idoneo sostituto di quello materno perché la sua composizione vi si avvicinava molto, inoltre quest’animale si ammalava raramente di tubercolosi. Purtroppo la quantità prodotta nei diversi Paesi era insufficiente alle necessità per cui suggerì di aumentare gli allevamenti. Un’altra difficoltà da dover risolvere fu la conservazione del latte vaccino che, privo della necessaria attenzione igienica, provocava severe gastroenteriti. Il metodo della pastorizzazione per sterilizzarlo diluito e darlo ai lattanti in aggiunta o in sostituzione al latte materno grazie al dispositivo ideato nel 1889 da Franz von Soxhlet (1848-1926) sembrò risolvere il problema. L’apparecchio permetteva la chiusura automatica delle bottiglie dopo la sterilizzazione del prodotto che in tal modo poteva essere conservato per lunghi periodi senza presentare tracce di coaguli, né modificazioni nell'aspetto17.
Sempre a metà dell’Ottocento, furono sperimentati i latti artificiali. Le prime farine lattee furono introdotte da Justus von Liebig (1803-1873), Henri Nestlè (1814-1890) e Carl Heinrich Theodor Knorr (1800-1875). I primi alimenti per lo svezzamento, che fecero la loro comparsa sul mercato, furono proprio la zuppa di malto del chimico tedesco Justus von Liebig nel 1865 e la farina lattea dell'industriale svizzero Henri Nestlé nel 1867. Anche questo tipo di alimentazione inizialmente causò gravi disturbi gastrointestinali.
L’ostetrico cremonese Pericle Sacchi (1854-1918) e il Capo-chimico dell’Ospedale Maggiore Alessandro Baroschi, dopo aver studiato le caratteristiche e la composizione del latte materno modificarono quello vaccino, in modo tale da conferirgli caratteristiche simili a quello della donna, conservando intera la componente lipidica, diminuendo la caseina e aggiungendo il lattosio. I risultati ottenuti furono soddisfacenti18.
Per lo svezzamento non tutte le madri avevano la possibilità di acquistare alimenti idonei. “L'alimentazione del bambino non era nel periodo attuale sempre facile, poiché gli alimenti specializzati erano cari, e perciò bisognava ricorrere alle sostanze alimentari più correnti e di uso più comune. L'alimento meno costoso, di cui si disponeva, era il pane, ed il cosiddetto pancotto era alimento preferito delle classi povere all'epoca del divezzamento”19.
Dott.ssa Raffaella Malandrino, già Ricercatrice Istituto Clinica Pediatrica Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
Per la corrispondenza: raffaelmat@libero.it
BIBLIOGRAFIA