Anno Accademico 2023-2024
Vol. 68, n° 4, Ottobre - Dicembre 2024
Simposio: La tutela della madre e del fanciullo nell'800 e nel '900
04 giugno 2024
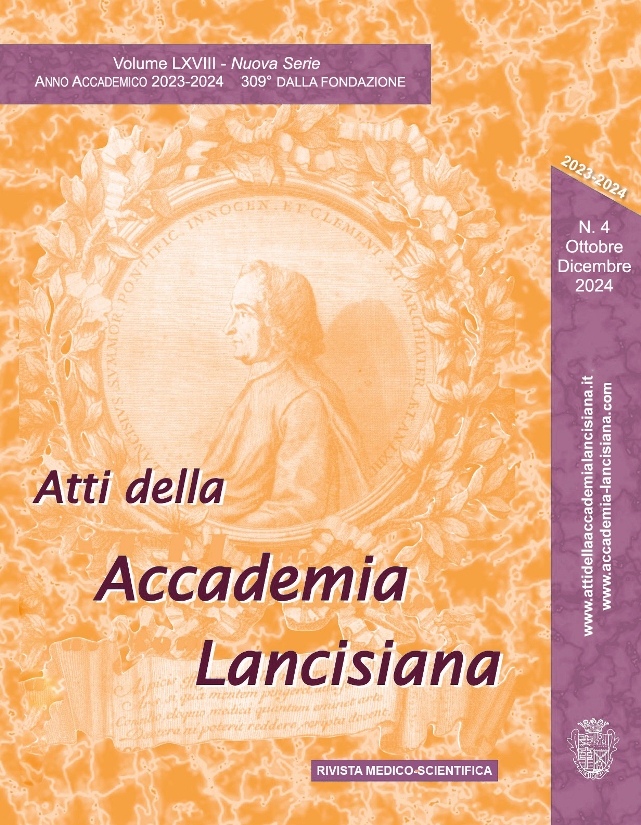
Simposio: La tutela della madre e del fanciullo nell'800 e nel '900
04 giugno 2024
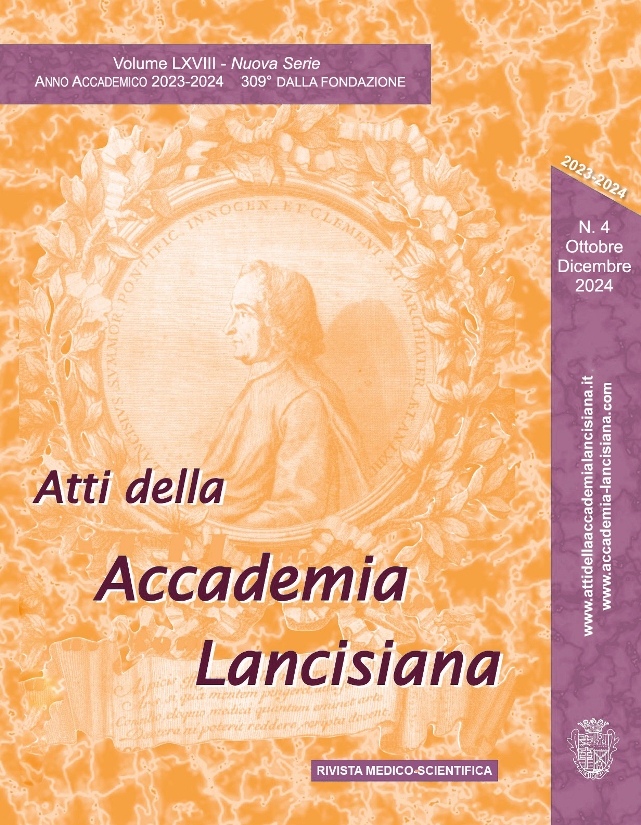
Versione PDF dell'articolo: Download
Le difficoltà sociali relative all’assistenza dell’infanzia e delle donne in gravidanza si sono aggravate negli ultimi anni. Le cause sono molteplici: l’impoverimento della popolazione, la difficoltà ad accedere a servizi pubblici dedicati, la mancanza di una capillare prevenzione delle malattie, l’immigrazione, soprattutto delle popolazioni prive di una cultura sanitaria, per non sottovalutare i cambiamenti avvenuti nelle società occidentali. Per molti secoli la prole fu considerata come un bene privato della famiglia e questa la considerava, secondo lo stato sociale, un bene affettivo, a volte economico e in alcune situazioni anche un peso. Le madri si preoccupavano della salute del figlio, la sua morte era un dramma privato dei genitori, una fatalità cui ci si doveva rassegnare. Nei ceti sociali più bassi, i bambini iniziavano presto a lavorare sia fuori sia dentro casa e, in alcuni casi assumevano molto presto responsabilità e ruoli da adulti. Nel XVI e nel XVII secolo le guerre che sconvolsero l’Europa causarono miseria e decadenza dei costumi e questo contribuì a far aumentare gli infanticidi e soprattutto i casi di abbandono cui ricorrevano le famiglie più povere. Molti neonati erano lasciati agli angoli delle strade, dove morivano di fame o divorati dagli animali, oppure erano raccolti da accattoni che li allevavano per avviarli alla mendicità, al furto e alla prostituzione. Chi non moriva nei primi giorni di vita accresceva la corte dei miracoli1. Solo grazie all’intervento di privati benefattori sorsero istituzioni per assicurare loro assistenza, come a Firenze lo Spedale degli Innocenti in Piazza SS. Annunziata eretto nel XV secolo o quella fondata a Parigi da San Vincenzo de’ Paoli (1581-1660), in cui operarono le Figlie della Carità. Passerà ancora del tempo prima che gli Stati promulghino leggi e si creino organizzazioni e figure professionali con il compito di tutelare l’infanzia, di garantirne la salute e una crescita sana. L’importanza di ottenere l’aumento demografico, avere una gioventù sana e forte e di conseguenza un popolo, che lavorasse, producesse e, nel caso di un conflitto, combattesse non fu compresa in tutti i governi e non nello stesso tempo. Nell’antica Roma la volontà di aumentare il numero dei cittadini, spinse l’imperatore Ottaviano Augusto ad emanare due leggi, la Lex Julia de maritandis ordinibus (18 a. C.) e la Lex Papia Poppaea nuptialis (9 d. C.), al fine di incrementare la popolazione dopo che il censimento del 28 a. C. aveva valutato che questa era solamente di quattro milioni2. A seguito della Rivoluzione francese (1789) fu sancito che l’assistenza degli esposti e dei fanciulli abbandonati non potesse essere affidata alla carità privata ma fosse un vero e proprio obbligo di solidarietà sociale. I cittadini in stato di bisogno e specialmente i giovani abbandonati dovevano essere considerati figli della Patria e quindi essere protetti e assistiti. Un decreto del 1793 pose a carico della nazione l’educazione fisica e morale dell’infanzia emarginata e stabilì come ogni gravida dovesse essere ricoverata in qualsiasi periodo della gestazione in una casa di maternità1. Il benessere della madre e del figlio fu quindi considerato un bene per la collettività. Nell’interesse nazionale, non più soltanto familiare e privato, i bambini furono considerati, in funzione del loro diventare adulti-soldati e lavoratori, non ancora per sé stessi. La tutela dei minori e delle donne, con le prime apposite leggi di protezione del lavoro minorile e di quello femminile specie durante la gravidanza e l’allattamento, s’imposero alla fine dell’ottocento.
Le disposizioni legislative all’estero
Numerosi furono i paesi europei, ed anche d’oltreoceano che, prevalentemente nel corso del primo ventennio del Novecento, inserirono nel proprio corpo legislativo norme a tutela dell’infanzia e, in alcuni casi, anche della maternità (Tab. 1).
 |
| Tab. 1. Legislazione straniera |
In Francia la legge del 23 dicembre 1874 intervenne sulla protezione della prima infanzia, quella del 19 aprile 1898 reprimeva le violenze e gli atti di crudeltà contro i fanciulli. La legge del 27 giugno 1904 sul servizio dei fanciulli assistiti stabiliva che, in determinate condizioni, era concesso un sussidio al fine di consentire alla madre indigente di allattare il proprio bambino o collocarlo a balia. La legge Engerand del 1909 prevedeva che il riposo fosse pagato nelle 8 settimane che precedevano e nelle 8 successive al parto. La legge Strauss del 1913, obbligava i datori di lavoro al mantenimento della mansione alle donne che si assentavano per maternità. Altre disposizioni legislative si ebbero il 24 luglio 1889 e il 5 agosto 1916 sulla protezione dell’infanzia maltrattata o moralmente abbandonata, mentre la legge del 22 luglio 1912 e quella del 22 febbraio 1921 stabilivano le norme per i fanciulli tradotti in giudizio.
In Inghilterra il Children Act del 1908 costituì un vero e proprio codice dell’infanzia, l’assistenza fu garantita dal Maternity and Child Welfare Act del 1918 e con l’Education Act del 1921.
La Spagna provvide alla protezione dell’infanzia il 12 agosto 1904.
La Germania riorganizzò il 9 giugno 1922 l’assicurazione della maternità prevedendo che le lavoratrici, che nell’anno precedente al parto fossero state assicurate per almeno sei mesi, avevano diritto alle cure mediche, a una somma di 250 marchi per le spese relative alla nascita e un assegno giornaliero nelle quattro settimane che la precedevano e nelle sei che la seguivano. Era previsto che se la gravida non fosse stata protetta dall’assicurazione riceveva dal governo, una tantum, 250 marchi e un sussidio giornaliero per 10 settimane. Altri interventi si ebbero per la protezione degli illegittimi e di quelli collocati a baliatico. Il Belgio tutelò, con la legge 15 maggio 1912, i minori delinquenti mentre quella del 5 settembre 1919 istituiva l’Opera Nazionale dell’Infanzia.
La Danimarca, con la disposizione del 1° marzo 1895, vigilò sui fanciulli moralmente abbandonati e nel 1915 gli assegni di maternità furono inclusi in un piano di assicurazione volontaria. La Svezia disciplinò, il 13 giugno 1902, l’educazione dei fanciulli viziosi o moralmente abbandonati, mentre in Norvegia, nel 1909 e nel 1915, furono concesse indennità di puerperio per le donne salariate e con la legge 10 aprile 1915 fu regolata la protezione dell’infanzia.
Negli Stati Uniti la Federale Sheppard Towner del 23 novembre 1921 normò la protezione dell’igiene della maternità e della prima infanzia (Maternity and Infancy Act), mentre altre disposizioni in merito vigevano nei singoli Stati, così anche nel vicino Canada e nelle Repubbliche dell’America Meridionale3.
La tutela della maternità, in alcune nazioni, era stata disciplinata e coordinata separatamente rispetto a quella dell’infanzia, come negli Stati Uniti in cui, accanto al Children’s Bureau, fu istituito durante gli anni della prima guerra mondiale il Women’s Bureau, oppure in Inghilterra dove si ebbe il Children’s Act del 1921, il Maternity and Children’s welfare Act del 1918 e l’Educational Act del 19214. Le strutture erano autonome, come l’Opera Nazionale Belga, oppure dipendente dall’Amministrazione Centrale, come il Consiglio Superiore della Natalità e della Protezione dell’Infanzia in Francia, il Consiglio Superiore di Protezione dell’Infanzia in Spagna, il Consiglio di Difesa dell’Infanzia in Perù o, infine, in un vero e proprio Ministero o ufficio ministeriale, come il Children’s Federal Bureau negli USA, l’Ufficio d’Igiene nel Brasile, la Sezione per la Protezione della Maternità in Nuova Zelanda.
La Convenzione Internazionale di Washington del 1919 stabilì norme per la tutela delle madri lavoratrici dell’industria e del commercio (la terza Conferenza di Ginevra nel 1921, estese tali diritti anche alle lavoratrici dell’agricoltura):
• la donna non era autorizzata a lavorare per un periodo di sei settime dopo il parto;
• aveva diritto a lasciare il lavoro, su presentazione di un certificato medico che attestava la probabilità del parto entro sei settimane;
• aveva diritto a ricevere durante l’assenza dal lavoro un’indennità sufficiente per il sostentamento suo e del figlio;
• nel caso la donna allattasse, aveva diritto a due riposi di mezz’ora per l’allattamento5.
Queste disposizioni entrarono in vigore il 13 luglio 1921 - ratificate in Italia il 6 aprile 1922 - e furono adottate dall’Ufficio Internazionale del Lavoro.
La legislazione italiana
La tutela del lavoro femminile e più nello specifico della maternità, è importante non solo per la salute della donna e del nascituro, ma anche per gli effetti negativi che la mancata protezione causa al Paese. Si pensi ad esempio che in passato il rachitismo era causa di riforma per il servizio di leva6. I governi italiani che si erano succeduti, dalla nascita dello stato unitario nel 1860, erano intervenuti con provvedimenti legislativi frammentari e non sempre risolutivi.
La legge Berti, n. 3657 del 1886 stabiliva che i bambini non potessero andare a lavorare nelle cave, nelle miniere e negli opifici prima dei 9 anni di età e proibiva i turni notturni ai minori di 12.
La tutela delle gestanti, delle puerpere e dei fanciulli in stato di bisogno o abbandonati era stata affidata, dai governi liberali agli istituti pubblici e privati di beneficenza il cui ordinamento risaliva alla legge sulle Opere Pie del 17 luglio 1890 n. 6972 (legge Crispi). La norma aveva imposto una nazionalizzazione delle opere pie e degli enti morali che avevano, in tutto o in parte, il fine di migliorare la condizione morale o economica della popolazione più povera e provvedere all’educazione, istruzione e avviamento al lavoro dei più giovani. Il Governo aveva posto sotto il suo controllo le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), con il fine di creare un sistema di sicurezza sociale. In realtà la legge ebbe un effetto limitato perché disciplinava solo la disciplina amministrativa e lasciava la gestione dell’attività assistenziale ai singoli istituti7.
La legge n. 242 approvata nel 1902 presentata da Paolo Carcano, ministro delle Finanze del governo Zanardelli, elevò a 12 anni l’età per l’ammissione al lavoro dei fanciulli. Una Commissione aveva il compito di stabilire quali lavori sarebbero stati impediti ai minori di 15 anni. Per le donne vietava, a qualsiasi età, i lavori sotterranei, alle minori quelli notturni e limitava a 12 ore l’attività lavorativa giornaliera per tutte. Era prescritta l’astensione dal lavoro nei trenta giorni successivi al parto, ma nessuna sospensione era prevista in quelli precedenti; era permesso l’allattamento in “camere di allattamento”, obbligatorie negli stabilimenti con almeno 50 operaie o con l’uscita dall’opificio nei modi e nelle ore secondo regole interne. La legge n. 416 del 7 luglio 1907 impediva alle lavoratrici i lavori notturni, faticosi e nocivi. Il Regio decreto 10 novembre 1907, n. 818 e il relativo regolamento n. 442 del 14 giugno 1909 prescrivevano limitazioni al lavoro delle donne e dei fanciulli. La legge n. 520 del 17 luglio 1910, istituiva la Cassa di Maternità che prevedeva il pagamento di un sussidio, inferiore al salario, alle donne lavoratrici in congedo obbligatorio. Per la protezione fisica dell’infanzia e dell’adolescenza vi erano alcune norme nella legge n. 632 del 19 giugno 1913 contro l’alcolismo. La legge n. 1176 del 17 luglio 1919, alla base dell’emancipazione delle donne, abrogava l’articolo n. 134 del Codice civile (Codice Pisanelli) del Regno d’Italia in vigore dal 1865 che aveva sancito il principio dell’autorizzazione maritale per cui le donne non erano legittimate a donare, alienare, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, compiere atti o decisioni di carattere contrattuale senza l’autorizzazione del coniuge e sanciva l’ammissione delle donne “a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni e a ricoprire tutti i pubblici impieghi esclusi quelli che implicavano poteri pubblici giurisdizionali, o l’esercizio di diritti o potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato, secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento”8.
La legge 24 luglio 1919, n. 1382 autorizzava la Cassa Depositi e Prestiti a concedere ai Comuni e alle Provincie mutui senza interesse per provvedere alla costruzione o adattamento di luoghi di cura per gli affetti da tubercolosi polmonare. Altri provvedimenti per l’assistenza furono inseriti nel Testo unico sulle leggi sanitarie del 1° agosto 1907, n. 636, nel regolamento legislativo 4 agosto 1918, n. 1395, nell’ordinanza ministeriale 6 gennaio 1919 sulla tutela igienica del baliatico e ancora nel regolamento 9 ottobre 1921, n. 1981, per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole. Alla protezione sociale del fanciullo non solo nell’ambito della famiglia e alla repressione degli abusi e dei delitti contro l’infanzia miravano alcune norme contenute nel codice civile, in quello penale e nel codice di procedura penale, nella legge di pubblica sicurezza e in quella sull’emigrazione. Il periodo giolittiano fu caratterizzato da una maggiore attenzione dell’intervento pubblico a fini civili e sociali. Nel primo dopoguerra, furono approvati due importanti provvedimenti: la legge n. 603 del 21 aprile 1919 stabiliva l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia per i lavoratori dipendenti privati, al personale pubblico fu applicata diversa disciplina e la legge n. 2214 del 19 ottobre 1919 che istituiva l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione per i salariati dell’industria. L’ultimo governo liberale tentò di porre una maggiore attenzione all’insufficiente assistenza della maternità e dell’infanzia e di passare da un’accoglienza caritatevole a un’assistenza organizzata9. Il ritardo in questa materia non era più prorogabile in un paese civile. I dati erano preoccupanti. Tra il 1865 e il 1879 in Italia erano stati dichiarati illegittimi 509.840 nati, mentre gli esposti alla ruota furono 536.217; complessivamente 1.046.057 bambini (il 6,47% di tutti i nati nel periodo)10.
Il Parlamento recepì la necessità di provvedere alla tutela dell’infanzia attraverso un organo nazionale. Un intervento legislativo era stato predisposto dall’agonizzante stato liberale. Il senatore Salvia, durante la Discussione, avvenuta in Senato, del disegno di legge Stato di previsione della spesa del Ministero dell’Interno, per l’esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, rilevò come il rappresentante italiano alla Conferenza Internazionale sull’infanzia, tenutasi nel 1922 a Bruxelles, aveva dovuto riconoscere che l’assistenza in Italia: “non è regolata da leggi speciali e le disposizioni relative sono contenute in numerosi codici e diverse leggi”. Sostenne quindi la necessità di imporre una soluzione: “Onorevoli colleghi, indotto dall’importanza demografica e sociale della questione della protezione dell’infanzia, ho presentato un ordine del giorno, col quale il Senato invita il Governo a preparare una riforma dell’ordinamento della pubblica assistenza, ispirandola a meno augusta convenzione dell’obbligo dello Stato di integrare l’azione degli enti minori e dei privati e organizzando in maniera completa, sulla scorta delle altre legislazioni, tutte le forme di protezione dell’infanzia abbandonata e debole”11.
Il Senato nominò una Commissione, composta di 32 membri, ritenuta troppo numerosa e tecnicamente inadatta che ebbe l’incarico di formulare una proposta di legge relativa alla protezione e all’assistenza dell’infanzia12. Furono esaminati i provvedimenti adottati negli altri Paesi e la situazione delle istituzioni italiane. In Italia, al 31 dicembre 1921, erano presenti circa 5700 organizzazioni per la protezione dell’assistenza della maternità e dell’infanzia, con un patrimonio complessivo di £ 730.658.40413. La metà di questi enti erano orfanotrofi o asili infantili, mentre mancavano o erano rari i centri di assistenza per le madri gestanti e le puerpere. Le aree urbane del centro e del nord del paese erano previlegiate rispetto al meridione: ve n’erano 1645 in Piemonte contro le 19 in Basilicata14. Gli istituti privati avevano un’analoga distribuzione territoriale15.
La Commissione presentò una relazione. Pochi mesi dopo, il 31 ottobre 1922, il Re affidò a Mussolini l’incarico di formare il governo. Con il Regio decreto 22 dicembre 1922 la Commissione fu sciolta e ne fu nominata una nuova, con le stesse finalità. Questa era composta di due senatori, due deputati e dal Direttore Generale dell’Amministrazione Civile Alberto Pirronti, sotto la presidenza del Sottosegretario di Stato per l’Interno Aldo Finzi. La precedente Commissione aveva predisposto un disegno di legge che fu illustrato alla nuova, da Pirronti: “quest’opera di amore e di fede deve mirare ad assicurare alla madre, durante la gestazione un minimo di benessere morale e materiale, allo scopo di evitare le nascite premature e la mortalità infantile per debolezza congenita: a diffondere e rendere praticabili, mediante appositi organi di propaganda ed aiuto materno, le norme d’igiene sociale dell’infanzia: a provocare un vero focolare domestico e un’educazione familiare, ad un fanciullo privo di famiglia, o abbandonato dai parenti; ad accrescere le responsabilità dei genitori e dei tutori, nei riguardi dell’educazione dei figli o dei pupilli; ad allontanare dall’ambiente malsano i fanciulli moralmente minacciati, ad organizzare uno speciale trattamento per i fanciulli responsabili di fatti lesivi dell’ordine giuridico e sociale, considerandoli non come delinquenti, ma come deboli creature, bisognose di protezione e di una notevole opera di rieducazione morale”12.
I parlamentari, sia in Senato sia alla Camera, sottolinearono le misere condizioni di vita della gran parte della popolazione e soprattutto la fatiscenza e l’insalubrità delle abitazioni. Il Senatore Loira evidenziò come la legge si occupasse di curare gli effetti ma non le cause dei disagi della maternità e dell’infanzia; difficoltà che derivavano in gran parte proprio dal fatto che una larga parte della popolazione era costretta a vivere miseramente. La necessità di intervenire urgentemente sulle condizioni delle dimore popolari fu sottolineata anche dal senatore Rava16 e, alla Camera, dai deputati Maccotta17, Messedaglia, Martire e Guaccero18. Le pessime condizioni delle abitazioni specie nel Mezzogiorno erano note a tutti. Eugenio Faina (1846-1926), tra il 1907 e il 1911 aveva presieduto la Commissione Parlamentare d’inchiesta sulle condizioni dei contadini nelle province meridionali e in Sicilia e aveva esaminato le condizioni delle classi agricole. Il suo nome è legato alle prime leggi speciali per il meridione. Egli aveva già illustrato le condizioni di vita dei lavoratori della terra. Aveva rilevato come i disagi delle case contadine erano frutto della generale arretratezza dell’ambiente agrario e della prevalenza degli insediamenti agglomerati, in cui alle deficienze igieniche della casa rurale si aggiungevano quelle tipiche delle società urbane, che fornivano terreno fertile al proliferare di malattie sociali che falcidiavano annualmente migliaia di bambini. “L’insufficiente rifornimento idrico e la cattiva qualità dell’acqua costituivano uno dei più gravi problemi igienico-sanitari dei centri rurali del Mezzogiorno. Dall’uso alimentare di acque non potabili, i contadini contraevano febbri tifoidee e infezioni gastro-enteriche; mentre dalla mancanza d’acqua dipendeva, in gran parte, la poca igiene personale dei contadini e la scarsa pulizia delle abitazioni, come pure il difficile smaltimento dei rifiuti attraverso la rete fognaria, quando questa esisteva”19. Il deputato Eugenio Morelli ipotizzò che la nuova legge se applicata in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, non avrebbe tenuto conto delle differenze tra nord nord-sud e tra città e campagna: “La legge così come esposta risponde più certamente ai bisogni delle città che ai bisogni delle campagne. E quando, specialmente nelle campagne, si trovano le condizioni dolorose, per cui talvolta la madre è nelle condizioni di depauperamento organico tale da non poter assolutamente procreare individui forti, c’è da domandarsi a quanto valore possa assurgere una legge che non tenga conto delle condizioni della madre prima ancora dello stato gravido…Ho questa impressione: che la legge, ottima ad applicarsi in città, nelle campagne diventa difficilmente applicabile, è nelle campagne che i provvedimenti devono essere considerati con occhio diversi”20.
Altre questioni dibattute in sede parlamentare furono la limitazione della patria potestà in determinati contesti, la somministrazione delle sostanze alcoliche e l’uso del tabacco da parte dei più giovani. Alla discussione parteciparono attivamente il medico cremonese Umberto Gabbi (1860-1933), Direttore della Clinica Medica dell’Università di Parma e il medico Luigi Messedaglia (1874-1956) entrambi deputati. Quest’ultimo espresse molte perplessità sugli effetti di certa cinematografia che a suo giudizio era ispiratrice della delinquenza minorile e interferiva sullo sviluppo psichico degli adolescenti. Il sen. Marchiafava sottolineò come …“L’indice di civiltà di una nazione è dato dall’interesse che si rivolge alla protezione del fanciullo, il cittadino futuro, il quale con il suo lavoro nelle varie direzioni dovrà farla prosperare e […] la nazione che se ne disinteressa, è destinata presto o tardi alla decadenza e alla dissoluzione”21.
La tutela della maternità e dell’infanzia fu riunita in un unico testo di legge e sottoposto all’approvazione del Senato nel dicembre 19243. Esso fu emendato esclusivamente dall’Ufficio Centrale del Senato mentre alla Camera il Ministro degli Interni, Federzoni, chiese ai parlamentari di astenersi dal presentare emendamenti: agli interventi di modifica si sarebbe provveduto con l’emanazione del regolamento di attuazione, infatti, appena fu approvata in Senato, si nominò una Commissione di sei membri incaricata di redigerlo.
A conclusione della discussione alla Camera, il ministro affermò: …“il problema dell’infanzia, posto nei suoi veri e precisi termini dalle nuove dottrine biologiche, antropologiche, economiche e sociologiche, si presenta oggi come un problema squisitamente politico, di eugenia, demografia, igiene e difesa sociale, di progresso morale, economico e colturale” ed era un’urgenza del nascente stato nazionale. Tuttavia riconobbe che: …“Naturalmente il progetto che si sottopone a quest’Assemblea non può essere perfetto, né pretende di essere tale. Alcune deficienze sono state rilevate; ma io non ho difficoltà a dichiarare che ve ne sono altre ancora, …, onorevoli colleghi, accettate la legge com’è, con le sue deficienze inevitabili, che si riferiscono a condizioni oggettive che per ora non è poter nostro di mutare. I perfezionamenti verranno in seguito. L’importante è di cominciare ad agire”22.
La legge n. 2277 del 10 dicembre 1925, composta di ventisette articoli, e il relativo Regolamento di attuazione approvato con Regio Decreto 15 aprile 1926 n. 718, istituiva l’Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell’Infanzia (O.N.M.I.), Ente parastatale presente su tutto il territorio nazionale, con il fine di tutelare la donna e il figlio sia prima sia dopo il concepimento. La necessità di colmare la differenza esistente tra la legislazione italiana e quella di altre Nazioni, l’esigenza di provvedere ai bisogni della popolazione più svantaggiata e il progetto di aumentare il numero degli italiani permisero la rapida approvazione, anche se molti parlamentari ne avevano sottolineato le criticità. Nessun precedente governo aveva affrontato con metodo un problema sociale di tale rilevanza23. Il governo fascista, il primo a istituire un’organizzazione che assistesse capillarmente la maternità e l’infanzia, diffuse tra gli italiani il convincimento che il regime si sarebbe concretamente interessato del benessere della popolazione italiana.
Nei precedenti sessanta anni di unità nazionale erano state promulgate soltanto poche e non organiche norme. La nuova legge suscitò l’interesse di molti Stati che ne ripresero i punti salienti nelle rispettive legislazioni24. Gli scopi principali erano la protezione igienica della maternità, il controllo della gravidanza, la difesa morale e materiale di bambini e ragazzi; l'educazione alla maternità. Gli assistiti appartenevano a particolari situazione familiari o si trovavano in gravi situazioni economiche, madri nubili, vedove e sposate, le cui condizioni modeste non permettevano l’allevamento della prole. Furono assistiti i bambini fino a 5 anni di età, provenienti da famiglie povere; quelli esposti all'abbandono quali i figli illegittimi In molti casi, l'assistenza si prolungava ben oltre il quinto anno d'età in caso di genitori irreperibili, di orfani di guerra, di ragazzi dimessi da istituti o ritenuti anormali, maltrattati dalle famiglie o quando queste non potevano garantire i moderni principi di igiene, sanità e alimentazione. L’Opera ebbe un potere di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private con l’autorità di chiederne la chiusura in caso di inadempienze gravi. Ebbe la facoltà di fondare o promuovere nuove strutture dove mancanti e sovvenzionare istituzioni private meritevoli. Le fu affidato il compito morale di rafforzare i vincoli familiari, di dare impulso alla natalità e ridurre la mortalità materna e infantile25. Il miglioramento delle condizioni di vita delle madri e dei bambini era essenziale per il raggiungimento di uno sviluppo qualitativo e quantitativo della popolazione.
 |
| Fig. 1. La sede centrale dell’O.M.N.I. |
L'Opera era amministrata da un Consiglio Centrale composto di 27 membri, con sede a Roma (Fig. 1), che dirigeva e coordinava le Federazioni provinciali, ognuna di 8 membri.
Queste operavano nei capoluoghi, nelle sedi messe a disposizione dalle provincie, con la funzione e di controllo sull'operato dei singoli comuni. In questi ultimi erano istituiti i Comitati di patronato formati da patroni sia di diritto sia scelti in base alla loro esperienza nel campo dell'assistenza a fasce di popolazione in difficoltà, cui era demandato il compito di provvedere oltre che all’assistenza materiale anche a un’attività di protezione morale e legale. Dovevano anche inserire nel mondo del lavoro le madri nutrici disoccupate e bisognose, controllare che alle gestanti e alle puerpere fossero concessi i prescritti periodi di riposo e fosse conservato l’impiego, cercare di mettere in regola le unioni tra i genitori dei figli illegittimi, assicurare alla madre nubile e al figlio il patrocinio legale per ottenere il riconoscimento di paternità e la conseguente assegnazione degli alimenti14.
I patroni si avvalevano della collaborazione di personale ausiliario quali le levatrici (nel 1937 il termine ostetrica sostituì quello di levatrice) e le assistenti sanitarie vigilatrici. Queste erano volontarie ma anche dipendenti dall'Opera con il compito di svolgere assistenza domiciliare alle gestanti e alle madri impossibilitate a recarsi in ambulatorio. Dovevano anche verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Se la malnutrizione della madre avesse reso impossibile l'allattamento, le visitatrici le indirizzavano al refettorio materno.
Inizialmente le attività furono svolte in ospedali, cliniche pediatriche o istituti di ricovero per lattanti. Il personale medico era costituito da specialisti in pediatria, ostetricia otorinolaringoiatria, dermosifilopatia, odontoiatria, oculistica.
Furono resi obbligatori corsi di formazione per i laureati in Medicina, da tenersi presso istituti che disponevano dell'attrezzatura per le esercitazioni pratiche3. Questi gli obiettivi fondamentali:
• provvede attraverso le sue Federazioni Provinciali alla protezione delle gestanti e delle madri bisognose, o abbandonate, dei bambini lattanti e divezzi fino al quinto anno appartenenti a famiglie che non possono prestar loro tutte le necessarie cure per un razionale allevamento;
• favorisce la diffusione delle norme e dei metodi scientifici d’igiene prenatale e infantile nelle famiglie, negli istituti, anche mediante l’istituzione di ambulatori per la sorveglianza e la cura delle gestanti, di scuole teorico-pratiche di puericultura e corsi popolari di igiene materno-infantile;
• organizza i Consorzi antitubercolari in accordo con le Amministrazioni provinciali, con gli ufficiali sanitari dei singoli comuni e con le autorità scolastiche;
• vigila sulle applicazioni delle disposizioni di legge e dei regolamenti in tema di protezione della maternità e dell’infanzia;
• istituisce consultori gratuiti per le madri, i bambini e gli adolescenti ed organizza servizi domiciliari di igiene e profilassi medico-sociale; istituisce asili nido, refettori materni, pensionati per lattanti e divezzi, sale da parto, istituti assistenziali ed educativi per l’infanzia e la gioventù;
• assiste i minorati fisici e psichici, i bambini e gli adolescenti in stato di abbandono e quelli che presentano deviazioni della condotta e del carattere26.
Il Prof. Francesco Valagussa (1862-1950), docente universitario e primario dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, socio fondatore della Società Italiana di Pediatria fu responsabile scientifico dell’attività pediatrica tra il 1925 e il 1943.
Il Ministero dell'Interno stanziò inizialmente un contributo di 8 milioni di lire l’anno; tuttavia è stato calcolato che, per dare copertura a tutte le attività O.N.M.I. (profilassi antitubercolare, propaganda igienico-educativa, corsi di formazione per il personale, spese di amministrazione), fossero necessari 67 milioni di lire. Oltre ai fondi statali, ne ottenne anche da donazioni e lasciti, tuttavia tali risorse non furono mai del tutto sufficienti. Il governo accentuò le caratteristiche pubbliche degli enti per l’assistenza cercando di non perdere il sostegno finanziario privato. Un aiuto fondamentale fu dato dal lavoro di volontari, sempre costante nel tempo: molte iscritte alla Federazione dei fasci femminili prestarono spontaneamente la propria opera nelle strutture assicurando una presenza femminile importante.
All’O.N.M.I. si affiancarono l’Opera Nazionale Dopolavoro, istituita con legge n. 582 del 1° maggio 1925 e l’Opera Nazionale Balilla, legge n. 2247 del 3 aprile 1926, “ente morale per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù”27.
Con il Regio decreto legislativo n.798 dell’8 maggio 1927 si stabilirono le “Norme sull’assistenza degli illegittimi abbandonati o esposti all’abbandono”.
Art. 1. “In ogni provincia il servizio d'assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono è affidato, sotto le direttive e il controllo dell'Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia, all’Amministrazione Provinciale la quale vi provvede o mediante la concessione di adeguati sussidi alle madri che allattino o allevino i rispettivi figli, o col ricovero e mantenimento dei fanciulli nei brefotrofi e in altri congeneri istituti, curando di ricoverarli, per quanto sia possibile, insieme alle madri, quando sono poppanti, o mercé il collocamento dei medesimi a baliatico e in allevamento esterno”.
Art. 4. “Sono ammessi all'assistenza, a norma dell'art. 1 del presente decreto:
a) i fanciulli abbandonati, figli di ignoti, che siano rinvenuti in un luogo qualsiasi della Provincia;
b) i fanciulli per i quali sia richiesta la pubblica assistenza, nati nei Comuni della Provincia da unioni illegittime e denunciati allo stato civile, come figli di ignoti;
c) ogni fanciullo nato da unione illegittima, riconosciuto dalla sola madre, quando questa possa dimostrare di trovarsi in stato di povertà e provveda inoltre direttamente all'allattamento o allevamento del proprio figlio, salvo i casi in cui sia riconosciuta fisicamente incapace di allattare o si oppongano ragioni d'indole igienico-sanitaria, o gravi motivi d'ordine morale”.
Art. 5. “…l'assistenza è dovuta, sin dal giorno della nascita, a tutti indistintamente i fanciulli che per essa abbiano titolo, senza riguardo al luogo di nascita o di domicilio, all'età, allo stato civile, al numero dei precedenti parti, ed alle condizioni morali ed economiche della madre”.
Art. 6 bis. “La direzione dei servizi tecnico-sanitari e assistenziali nei brefotrofi e nelle case di ricezione deve essere affidata ad un medico specializzato in pediatria o in puericoltura, il quale è direttamente responsabile dei servizi di fronte all'amministrazione”.
Nel 1932 il direttore Sileno Fabbri avviò la costruzione, in tutto il Paese, delle “Case della madre e del bambino” (Fig. 2).
 |
| Fig. 2. Casa della madre e del Bambino (a sn Terni, a dx Belluno). |
Ognuna di esse riuniva in un’unica sede le principali attività medico-sociali in favore delle madri e dei minori: il consultorio specialistico ostetrico e pediatrico, i servizi sociali, l’asilo-nido per lattanti e divezzi, il refettorio materno per gestanti dal sesto mese di gravidanza e nutrici fino al settimo mese di allattamento.
L’Opera disponeva di ambulatori specialistici, di istituti profilattici e delle colonie permanenti situate in località climatiche marine e montane per l’assistenza ai fanciulli predisposti, deperiti e deboli per prevenire patologie invalidanti (Fig. 3).
 |
| Fig. 3. Colonie dell’O.N.M.I., a sn Apuania (Marina di Massa), a dx Villa Patt, Sedico (Belluno). |
L’obiettivo era combattere in particolare la tubercolosi infantile. Si promosse l'istituzione di asili nido per bambini fino al terzo anno d'età, in prossimità delle fabbriche o, dove possibile, all'interno delle stesse, insieme alla camera di allattamento. Della refezione dei bambini più poveri, cui la scuola doveva provvedere anche nei mesi estivi, si occupò non soltanto l'O.N.M.I., ma anche e soprattutto l’Opera Nazionale Balilla e l’Ente Opere Assistenziali. L’O.N.M.I. provvedeva che, se necessario, fossero acquisiti e distribuiti alimenti specializzati, per integrare l’alimentazione dei neonati e dei bambini.
Tra gli altri provvedimenti vanno ricordate le 59 Cattedre ambulanti attive in quelle province dove non erano presenti consultori fissi, soprattutto nei centri più piccoli prevalentemente rurali. Ogni Cattedra svolgeva la sua azione in un territorio comprendente una ventina di comuni. Uno di questi era scelto come sede principale in cui risiedevano il medico e l’assistente sanitaria, i quali ogni mattina visitavano due o tre municipi, secondo un calendario prestabilito in modo che in settimana erano raggiunti tutti quelli pertinenti alla cattedra. Il medico controllava gratuitamente tutte le donne che si presentavano e forniva gli elementi di puericultura d’igiene della gravidanza e dell’allattamento.
Con esse si volevano diffondere la profilassi antitubercolare, norme per la corretta nutrizione, ma soprattutto quelle per le cure prenatali e post-partum. Le contadine e in particolare quelle appartenenti alle classi meno agiate, erano le più prolifiche e avevano bisogno di maggiori cure puerperali e post-natali, ed era particolarmente nelle campagne che bisognava intensificare la lotta contro la mortalità infantile. Dal 1927 al 1931 furono controllate 29.000 gestanti e visitati oltre 650.000 bambini. Il regolamento del 1926 prevedeva anche un’assistenza domiciliare che si concretizzò con fornitura di alimenti, medicinali e sussidi in denaro.
L’Opera ebbe la funzione di porre rimedio al fenomeno dell’abbandono procurando di allontanare giovanetti e adolescenti che vivevano di espedienti o erano sfruttati da genitori violenti, avviandoli a un percorso educativo, ricoverandoli in strutture poste sotto il suo controllo. Dal momento della sua fondazione alla fine del 1931 collocò negli istituti 20.437 minorenni in stato di abbandono materiale e morale assumendo l’onere delle spese per un totale di £ 35.000.000. I giovani erano ospitati fino al compimento del 18° anno e orientati ad attività lavorative. Alla presenza di rei minorenni il compito d’intervenire fu affidato ai magistrati che in ogni provincia facevano parte del Consiglio Direttivo dell’ente che ben conoscevano le rispettive zone e mantenevano continui contatti con la realtà in cui vivevano gli adolescenti con il fine di evitare la detenzione in carcere. Con il Regio decreto n. 1404 del 20 luglio 1934 fu istituito il Tribunale per i minorenni. L’Opera favorì l’incremento della popolazione in accordo con la politica del governo che con un decreto legge del novembre 1926, poi inserito nel Codice Penale del 1930, considerò l’aborto non terapeutico, come “delitto contro l’integrità e la sanità della stirpe”, mentre il codice Zanardelli del 1889 lo definiva come reato contro la persona.
All’obiettivo per l’assistenza, si aggiunse quello politico: “mettere in atto quelle previdenze atte a mantenere forte la razza e a garantire a essa il continuo incremento attraverso individualità sane nel fisico e nella mente, perché l’itala gente possa rivolgersi sicura verso il compimento dei suoi grandi destini”28.
La propaganda fu un carattere presente nella politica dell’istituzione come testimonia una circolare del 1931: “La propaganda patriottica deve essere infine parte integrale dell’assistenza, affinché nell’aiuto prestato non si veda soltanto un gesto di carità, qualche volta male accetto, ma il frutto di un interessamento costante ed amorevole del Regime verso la madre e il fanciullo, esponenti della potenza demografica del paese29.
La Giornata della Madre e del Fanciullo dal 1933, celebrata il 24 dicembre fino al 1950, in seguito il giorno dell’Epifania, assunse particolare rilevanza e aveva l’obiettivo di suscitare l’attenzione della popolazione sulle attività svolte. Durante la ricorrenza erano assegnati premi di nuzialità, di natalità, di allevamento igienico del bambino e incoraggiamento alle famiglie numerose. Fino al 1942, ogni anno si radunavano a Roma 95 coppie prolifiche. Ognuna, proveniente da una provincia diversa, riceveva un premio di £ 5.000, una polizza assicurativa dell’importo di £ 1.000 a favore dell’ultimo nato (£ 2.000 se gemelli), un diploma di benemerea e una medaglia d’argento.
L’O.N.M.I. pubblicò, dal novembre 1926 fino alla sua soppressione, una rivista, Maternità e Infanzia, inizialmente diretta dal medico legale Attilio Lo Monaco-Aprile. A essa collaborarono pediatri come il professor Girolamo Taccone, Direttore dell’Ospedale dei bambini di Milano e il professor Nicola Latronico, primario pediatra dell’Ospedale di Lecco. Questo bollettino mensile ebbe il compito di diffondere norme di Pediatria, di Puericoltura e di Pedagogia oltre informazioni igienico-sanitarie tra la popolazione e di rendere pubblico l'operato dell'ente. Furono riportati gli atti ufficiali, studi e articoli di propaganda. Diffuse inoltre materiale divulgativo quali opuscoli e libri. A Cremona patrocinò il periodico Mamma e bimbi, supplemento a Il Regime fascista, dal 1938 al 1943. L’attività scientifica fu caratterizzata dalla costante organizzazione di simposi, congressi e conferenze. I suoi rappresentanti parteciparono ai convegni delle diverse società scientifiche ed ebbero rappresentanze in seno ad organismi internazionali. Furono organizzati corsi di Puericultura pre e post-natale per medici, ostetriche e assistenti sanitarie e corsi popolari di igiene e assistenza infantile per le insegnanti e le mamme. Nel 1937 ebbe il compito d’istituire, nelle scuole medie, corsi di Puericultura e nel 1940 fu introdotto l’insegnamento che fu soppresso nel dopoguerra. Furono anche avviate scuole professionali per Puericultrici.
L’Opera fu un vanto per il governo e fu apprezzata dalle molte delegazioni giunte in Italia per conoscerne il funzionamento. La rivista, Maternità ed Infanzia, ne diede puntuale riscontro. Grande risalto ebbe la visita della delegazione giapponese e quella del Mahatma Gandhi. Nel 1937 gli uffici centrali dell’Opera e le sue istituzioni assistenziali furono visitate dalle rappresentanze di 33 nazioni.
Nel 1934 la legge n. 654 estese la protezione della maternità delle lavoratrici. Restavano escluse le addette ai lavori domestici, la moglie, le parenti ed affini del datore di lavoro, le lavoranti a domicilio e le occupate negli uffici dello Stato, delle provincie e dei Comuni nonché degli Istituti di beneficenza. L’astensione obbligatoria era estesa anche all'ultimo mese precedente la data del parto e quella post partum era aumentata a sei settimane. Entrambi i periodi potevano essere ridotti, su richiesta della donna, fino a tre settimane se il certificato medico attestava che la prosecuzione del lavoro anche oltre detti periodi poteva avvenire senza pregiudizio per le condizioni di salute della gestante. L’art. 8 consentiva il diritto di assentarsi dal lavoro “fin dall'inizio della sesta settimana antecedente la data presunta del parto”. Il datore di lavoro aveva l’obbligo di preservare l’impiego; in caso di malattia in conseguenza della gravidanza per cui la lavoratrice dovesse astenersi dal lavoro oltre detti periodi, l'obbligo era esteso a un ulteriore mese. “L’aborto spontaneo o terapeutico – escluso quello procurato- sono considerati, agli effetti dell’interruzione del lavoro e della conservazione del posto, come malattia prodotta dalla stato di gravidanza e di puerperio”.
L'art. 11 vietava il licenziamento della donna, che continuava, dopo la presentazione del certificato di gravidanza a prestare la propria opera, “durante il restante periodo di gestazione in cui può essere addetta al lavoro, se non in caso di colpa costituente giusta causa di risoluzione del rapporto, ovvero nel caso di sospensione a tempo indeterminato del lavoro nell’azienda o nel reparto cui è addetta”.
La legge disponeva che le lavoratrici madri potessero provvedere all'allattamento al seno dei propri figli senza conseguenze negative o pregiudizievoli per la loro posizione lavorativa. Gli articoli 14 - 17 obbligavano i datori di lavoro a concedere alle madri “che allattano direttamente i propri bambini” due periodi di riposo durante la giornata per provvedere all'allattamento, per un anno dalla nascita del bambino. La legge fissava la durata dei riposi in un'ora ciascuno con il diritto della donna di uscire dall'azienda, se il datore di lavoro non avesse messo a disposizione un'apposita camera di allattamento, obbligatoria nel caso nell'azienda fossero occupate almeno 50 lavoratrici di età compresa fra i 15 e i 50 anni.
“La camera di allattamento deve essere illuminata e ben ventilata; ben riscaldata nella stagione fredda. Deve essere altresì convenientemente arredata e tenuta in istato di scrupolosa pulizia e provvista di acqua. Per le aziende che occupino almeno 100 donne, dai 15 ai 50 anni, l’ispettorato corporativo può prescrivere che alla camera di allattamento sia adibito personale idoneo per la custodia dei bambini durante le ore di lavoro delle madri”.
Era prevista l’assicurazione obbligatoria per la maternità con lo scopo di corrispondere un sussidio di £ 300 in caso di parto e £ 100 in caso di aborto spontaneo. Per l’assicurazione obbligatoria era stabilito un contributo annuale di £ 7, di cui £ 3 a carico della lavoratrice e £ 4 a carico del datore di lavoro.
Nella situazione di emergenza provocata dalla guerra, l'Opera fu costretta a rinunciare alla sua vocazione di ente specializzato, per passare a fornire aiuti concreti a una popolazione stremata dalla fame e dalla miseria. I consultori pediatrici e materni diventarono luoghi di distribuzione di alimenti e medicinali. Furono forniti servizi sanitari a tutta la popolazione e in moltissimi usufruirono dei pasti gratuiti nei refettori dell'ente. Si occupò inoltre di dare un sostegno agli sfollati.
Con la caduta del fascismo e la successiva costituzione della Repubblica Sociale, la sede centrale con i fondi e il magazzino viveri fu spostata da Roma a Pedrengo in provincia di Bergamo. Nella Capitale restò un ufficio stralcio guidato da Giovanni Festa.
Si ebbe in pratica una spaccatura, nell’Italia sotto il controllo degli alleati furono sollevati dall’incarico i dirigenti delle federazioni provinciali, mentre al nord l’Opera, in grande sofferenza economica, svolse oltre i compiti statutari anche assistenza ai profughi e agli sfollati. Con la fine della guerra le difficoltà economiche non risolte dalle divisioni tra i nuovi e i passati responsabili non aiutarono la ripresa delle attività. I funzionari e gli impiegati della sede centrale nell’Italia settentrionale nominati dal governo della R.S.I. furono epurati. Il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia voleva mantenere la sede centrale al nord con elementi di propria fiducia scontrandosi con la dirigenza della ricostituita sede centrale romana avvenuta il 28 giugno 1944. L’intervento di Ferruccio Parri, Ministro dell’Interno, portò a una soluzione di compromesso: la sede O.N.M.I. dell’Alta Italia con sede a Milano diveniva Delegazione con controllo sulle altre federazioni del nord e restava alle dipendenze della sede centrale di Roma. Nell'immediato dopoguerra il neo istituito Alto Commissariato all'Igiene e alla Sanità pubblica (ACIS), riconobbe la provvisorietà di tale accordo e infatti, nel marzo 1946, tutte le federazioni tornarono a far capo alla sede centrale di Roma.
L’O.N.M.I. fu riorganizzata e fece fronte alla situazione di emergenza del dopoguerra, ma non poteva tuttavia risolvere i gravi problemi di sovraffollamento nelle città, né debellare la mancanza di igiene. Il problema fondamentale fu la limitatezza dei fondi a disposizione.
Dal 1943 al 1947 l’United Nations Relief and Rehabilitation Administration (U.N.R.R.A.) fornì aiuti per un miliardo e mezzo di lire, tuttavia non sufficienti a ricostruire quanto distrutto. Le persistenti difficoltà economiche specialmente nel sud del Paese non furono compensate dagli aiuti economici provenienti dall’estero.
Durante il periodo bellico erano state rese inservibili 3266 istituzioni delle 9.959 presenti sul territorio nazionale all’inizio del conflitto. Al termine di questo, nonostante le difficoltà finanziarie vi fu l’impegno di ricostituire quello che la guerra aveva distrutto (Tab. 3).
Il finanziamento statale nel 1946 fu di 1 miliardo e 200 milioni, che l’anno successivo raggiunse la cifra di 3 miliardi e 200 milioni a cui si aggiunse un contributo straordinario di 2 miliardi30.
 |
| Tab. 2. Danni causati dalla guerra. |
La Costituzione della Repubblica Italiana (27 dicembre 1947) riconobbe essenziale la protezione della maternità e dell’infanzia:
“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31)”.
“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione (art.37)”.
Il 26 agosto 1950 fu emanata la legge n. 860 “Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri”, ampliava la legge n. 654 del 1934 e si applica “alle lavoratrici gestanti e puerpere che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, comprese le lavoratrici dell'agricoltura, (.), nonché a quelle dipendenti dagli uffici o dalle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti pubblici e Società Cooperativistiche anche se socie di queste ultime”.
L’art. 3 stabilisce il divieto di licenziare le lavoratrici durante la gestazione e durante il periodo, pari ad otto settimane dopo il parto. Il divieto di adibire al lavoro è altresì sancito per i tre mesi precedenti la data presunta del parto in caso di lavoratrici addette all'industria, per le otto settimane precedenti per quelle adibite ai lavori agricoli e nelle sei settimane precedenti per tutte le altre categorie. L’assenza può essere estesa dall'Ispettorato del lavoro qualora le condizioni possano essere pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino. Alla lavoratrice, trascorse le otto settimane successive al parto, è concessa altresì la facoltà di assentarsi per un periodo di sei mesi durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell'anzianità, senza però aver diritto all'indennità giornaliera dell'80% della retribuzione previsto a carico dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le malattie o degli altri Istituti o Enti che provvedono all'assicurazione obbligatoria contro le malattie per il periodo di assenza obbligatoria. È mantenuto l'obbligo per le aziende che impieghino almeno trenta donne coniugate di età non superiore ai 50 anni di istituire le camere di allattamento. Rispetto alla legge n. 654 del 1934 il numero era stato ridotto da cinquanta a trenta e si specificava che le donne fossero coniugate, contrariamente alla precedente disposizione che non richiedeva la necessità del vincolo matrimoniale. L’impresa poteva essere esonerata da tale obbligo se finanziava o partecipava all’istituzione di asili nido interaziendali in luoghi convenienti per le lavoratrici dipendenti. Le camere di allattamento e gli asili nido devono essere mantenuti in modo da rispondere alle norme igieniche La loro violazione era sanzionata dalla legge con l'ammenda da lire 5.000 a lire 30.000.
Il 20 novembre 1959 fu approvata all’unanimità dall’assemblea Generale delle Nazioni Unite la “Dichiarazione Universale dei Diritti del Fanciullo”:
• “Principio primo: il fanciullo deve godere di tutti i diritti enunciati nella presente Dichiarazione. Questi diritti debbono essere riconosciuti a tutti i fanciulli senza eccezione alcuna, e senza distinzione e discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua la religione o opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, le condizioni economiche, la nascita, o ogni altra condizione sia che si riferisca al fanciullo stesso o alla sua famiglia”.
• “Principio secondo: il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti, in modo da essere in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico intellettuale morale spirituale e sociale in condizioni di libertà e di dignità. Nell'adozione delle leggi rivolte a tal fine la considerazione determinante deve essere del fanciullo”.
• “Principio terzo: il fanciullo ha diritto, sin dalla nascita, a un nome e una nazionalità”.
• “Principio quarto: il fanciullo deve beneficiare della sicurezza sociale. Deve poter crescere e svilupparsi in modo sano. A tal fine devono essere assicurate, a lui e alla madre le cure mediche e le protezioni sociali adeguate, specialmente nel periodo precedente e seguente alla nascita Il fanciullo ha diritto ad un’alimentazione, ad un alloggio, a svaghi e a cure mediche adeguate”.
• “Principio quinto: il fanciullo che si trova in una situazione di minoranza fisica, mentale o sociale ha diritto a ricevere il trattamento, l’educazione e le cure speciali di cui esso abbisogna per il suo stato o la sua condizione”.
• “Principio sesto: il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale. Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre. La società e i poteri pubblici hanno il dovere di aver cura particolare dei fanciulli senza famiglia o di quelli che non hanno sufficienti mezzi di sussistenza. È desiderabile che alle famiglie numerose siano concessi sussidi statali o altre provvidenze per il mantenimento dei figli”.
• “Principio settimo: il fanciullo ha diritto a un’educazione, che, almeno a livello elementare deve essere gratuita e obbligatoria. Egli ha diritto a godere di un’educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consenta, in una situazione di eguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla società. Il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori. Il fanciullo deve avere tutte le possibilità di dedicarsi a giuochi e attività ricreative che devono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto”.
• “Principio ottavo: in tutte le circostanze, il fanciullo deve essere fra i primi a ricevere protezione e soccorso”.
• “Principio nono: il fanciullo deve essere protetto contro ogni forma di negligenza, di crudeltà o di sfruttamento. Egli non deve essere sottoposto a nessuna forma di tratta. Il fanciullo non deve essere inserito nell’attività produttiva prima di aver raggiunto un'età minima adatta. In nessun caso deve essere costretto o autorizzato ad assumere un’occupazione o un impiego che nuocciano alla sua salute o che ostacolino il suo sviluppo fisico, mentale, o morale”.
• “Principio decimo: il fanciullo deve essere protetto contro le pratiche che possono portare alla discriminazione razziale, alla discriminazione religiosa e ad ogni altra forma di discriminazione Deve essere educato in uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia fra i popoli, di pace e di fratellanza universale, e nella consapevolezza che deve consacrare le sue energie e la sua intelligenza al servizio dei propri simili”.
In questo panorama normativo in cui diversi e autorevoli consessi riaffermavano la centralità dell’assistenza all’infanzia, in Italia si svolgeva un dibattito sulla prosecuzione dell’attività dell’O.N.M.I. Non tutti i partiti politici ne riconoscevano la validità e non tutti volevano tenerla in vita e non solo per un motivo ideologico. Il patrimonio dell’ente rientrava nell’interesse di molti. Le incertezze e difficoltà durarono nel tempo come dimostra il continuo ricambio dei Commissari Straordinari chiamati a presiedere l’Opera. Dal 16 maggio 1944 al 17 maggio 1950 furono ben otto. Solo nel 1950 fu ricostituito un Consiglio Centrale che doveva restare in carica per un quadriennio presieduto da Urbano Cioccetti. La presidenza di quest’ultimo fu rinnovata per il quadriennio 1954-58. In questo periodo l’intreccio tra ceto politico e dirigenti dell’ONMI si fece più pressante30. I partiti e le associazioni vollero inserire nella dirigenza, non sempre riuscendovi, uomini di loro riferimento.
Nella nuova geografia assistenziale l’Opera si dovette confrontare con l’Ente Nazionale per la Protezione Morale del Fanciullo nato nel 1945 e nel 1948 con il riconosciuto Ente Nazionale di Assistenza agli Orfani dei Lavoratori Italiani già istituito nel 1941. Continuò a svolgere la sua funzione l’Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra fondata nel 1929 e l’Ente Comunale di Assistenza presente dal 1937.
La contrarietà dei partiti di sinistra è ben evidente dall’intervento che il sen. Umberto Terracini svolse, durante i lavori della 1° Commissione il 18 novembre 1954, sul disegno di legge “Composizione degli organi direttivi centrali e periferici dell’Opera nazionale maternità e infanzia: Il disegno di legge in esame è di grandissima importanza. Credo che la nostra Commissione non abbia mai avuto l’incarico di approvare, in sede deliberante, un disegno di legge di tanta importanza. Mi pare che i colleghi lo abbiano considerato uno di quei piccoli provvedimenti di legge che passano in fretta e su cui facilmente si trova l’accordo o il compromesso in seno alla Commissione. Voglio subito dire che, su questo disegno di legge, non solo nessun accordo, ma nessun compromesso da parte nostra sarebbe possibile, perché è un disegno di legge che, sotto l’aspetto più innocente e modesto, in realtà mira, ad affidare, anzi a consegnare interamente nelle mani – dirò – nello Stato, da una parte, e dall’altra di certe forze politiche, un organismo di enorme potenza finanziaria ed economica e di straordinaria capacità di influenza e di suggestione sopra le masse popolari del nostro Paese”.
La battaglia contro l’Opera proseguì nel tempo. Tre proposte di legge (n. 1527, n. 1528, n. 1652) furono presentate alla Camera dei Deputati il 24 luglio 1959 e il 21 ottobre dello stesso anno con l’obiettivo di trasferire gran parte dei servizi forniti dall’O.N.M.I. ad altri enti, fornendo loro i fondi necessari al loro funzionamento.
Nel 1960 il deputato comunista Luciana Viviani ne chiedeva la soppressione e il trasferimento delle sue funzioni alle Regioni, Provincie e Comuni31.
 |
| Tab. 3. Istituzioni assistenziali gestite direttamente dall’O.N.M.I. dal 1926 al 196026. |
Mentre proseguiva il dibattito sull’utilità dell’ente, questo era impegnato, pur con molte difficoltà, a ricomporre il tessuto assistenziale su tutto il territorio nazionale (Tab. 3). Dal 1926 al 1960 ricevettero assistenza 43.038.740 fanciulli e 11.914.753 donne.
Durante lo svolgersi del dibattito sull’esistenza dell’Opera, nel 1971 fu promulgata la legge 1204 che ripropose molti degli istituti già regolamentati dalla legge 654 del 1934 prima e poi dalla legge 860 del 1950. L'art. 3 ribadiva il divieto di adibire le donne al trasporto e al sollevamento dei pesi durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto ampliandolo più genericamente ai lavori pericolosi ed insalubri. Il datore di lavoro deve “consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata”; la donna ha diritto ad un solo riposo quando l'orario di lavoro giornaliero è inferiore a sei ore. La legge del 1950 concedeva il diritto a due periodi di riposo giornaliero “alle lavoratrici madri che allattano direttamente i propri bambini”. La nuova formulazione, eliminando ogni riferimento all'allattamento, consentiva di fruire di periodi di riposo alle lavoratrici madri.
I successivi provvedimenti legislativi ampliarono le disposizioni e ne ribadirono altre già impartite (Tab. 4).
 |
| Tab. 4. Provvedimenti legislativi. |
La riforma del sistema sanitario previde l’istituzione di Unità sanitarie locali (USL), oggi Aziende Sanitarie locali (ASL) e l'applicazione dell'ordinamento regionale (1970), in base al quale molte delle competenze in precedenza affidate all'O.N.M.I. furono trasferite alle regioni.
Il decentramento delle funzioni assistenziali affidato alle province, ai comuni, alle USL e agli Enti comunali di assistenza (ECA) rese difficile un possibile coordinamento con l'Opera, che - oltre a vedersi svuotata di molte funzioni - ebbe la difficoltà a trovare i mezzi per rinnovare le proprie strutture. Nel dibattito che si svolse in commissione Igiene e Sanità della Camera (novembre 1975) quasi tutti i gruppi, ad esclusione del M.S.I che si astenne, pur con distingui differenti, concordarono sullo scioglimento dell’Opera. Il socialista Zaffanella espresse un giudizio negativo affermando come la mortalità e morbilità infantile e la mortalità materna facevano avvicinare l’Italia a un paese del terzo mondo. Inoltre affermò come la gestione dell’ente fosse clientelare e responsabile di uno spreco di miliardi che avevano causato nel 1972 un deficit di 16 miliardi. Al contrario il gruppo democristiano esprimeva un parere positivo riconoscendo tuttavia le mancanze ma addossando la responsabilità ai singoli. Tuttavia anch’esso si espresse per l’abolizione dell’ente perché non vi era più motivo perché restasse in vita poiché l’assistenza era di fatto affidata alle regioni30.
L'Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia istituita con legge 10 dicembre 1925, n. 2277, fu soppressa alla data del 31 dicembre 1975 (legge 23-12-1975, n. 698: “Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia”).
Dal 1° gennaio 1976 le funzioni amministrative esercitate dall'O.N.M.I. furono trasferite alle regioni a statuto ordinario e speciale per il rispettivo territorio. Furono ugualmente passati “alle regioni i poteri di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia”. Restarono attribuite allo Stato e furono esercitate dal Ministero della Sanità le funzioni di carattere internazionale.
L’amministrazione degli asili nido e dei consultori fu attribuita ai comuni. Mentre spettarono “alle province tutte le funzioni amministrative, di fatto, esercitate dai comitati provinciali dell'ONMI”. Il patrimonio immobiliare, con il relativo arredamento e attrezzature e quanto altro costituiva patrimonio dell'Opera, fu spostato alle province e ai comuni, dove i beni si trovavano. La sede centrale fu trasferita allo Stato.
Il personale che assommava a circa 8.000 unità fu trasferito in gran parte alle Provincie e ai Comuni con lo stesso trattamento economico goduto in precedenza. I dipendenti della Sede centrale furono dislocati, con compiti di vigilanza, alle regioni. Alcuni, in seguito a loro richiesta, furono inseriti in un ruolo unico cui attinsero altre amministrazioni statali. In attesa di essere chiamati passarono alle dipendenze del Ministero della Sanità30.
Per il 1976, furono ripartiti tra le regioni e le province di Trento e Bolzano £. 70.163.000.000 in proporzione alla spesa mediamente sostenuta per ognuna nel precedente triennio 1973-75. Le regioni assegnarono alle province e ai comuni le somme necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
Terminò cosi l’attività svolta dall’Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell’Infanzia, istituzione unitaria che svolse la sua azione su tutto il territorio nazionale, creata nel 1925, abolita nel 1975 perché ritenuta un ente inutile. Oggi la sua funzione può essere considerata anacronistica, ma non vanno sottovalutati i risultati ottenuti in un determinato periodo storico. Probabilmente sarebbe stato più lungimirante mantenerla attiva e modernizzarla, provvedendo alle sue criticità, estendendo la rete dei consultori, dei centri medico-psico-pedagogici, degli istituti educativi assistenziali incrementando il numero delle assistenti sociali, senza operare scomposizioni le quali probabilmente andarono a detrimento dell'assistenza vera e propria, anche alla luce degli attuali problemi sociali. In Italia l’indice di natalità nel 2023 è stato pari a 1,22 figli per donna ed è stato valutato che 5.752.000 individui e 1.300.000 bambini vivano in povertà assoluta (ISTAT).
Prof. Pasquale Alessandro Margariti, già Direttore UOC Ginecologia Columbus–Fondazione Policlinico Gemelli, Università Cattolica Sacro Cuore-Roma
Per la corrispondenza: pamarga@yahoo.it
BIBLIOGRAFIA