Anno Accademico 2024-2025
Vol. 69, n° 1, Gennaio - Marzo 2025
Seduta Inaugurale
05 novembre 2024
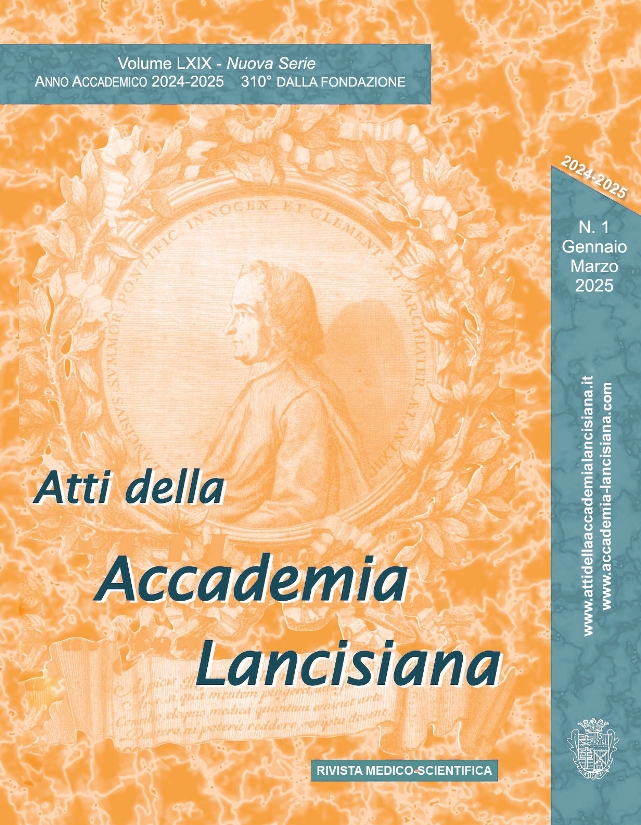
Professore Ordinario Emerito di Chirurgia Vascolare, Università degli Studi di Pavia
Seduta Inaugurale
05 novembre 2024
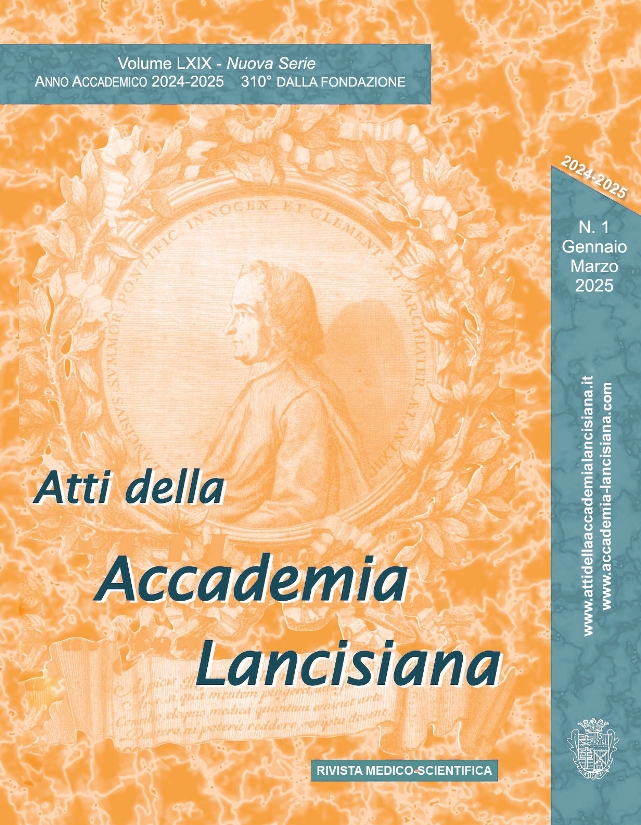
Versione PDF dell'articolo: Download
“più ammirato che compreso”
E.H. Gombrich
La morte di Leonardo, come in tutte le sue espressioni artistiche, si presenta dai contorni sfumati e per taluni aspetti curiosi; come nella sua arte è stato il “genio dell’imperfezione”, secondo una definizione di Sgarbi, altrettanto è stato negli eventi della sua vita1.
Del suo stato clinico possiamo invece conoscere dettagli che ci permettono di delineare un soggetto longevo rispetto la media della popolazione del momento, affetto come vedremo da un disturbo psichico e da una patologia cronica sistemica. Sarà quest’ultima la causa di un deficit funzionale ed alla base del decesso a 67 anni.
Va subito detto che i rapporti tra Leonardo e la classe medica sono pessimi: è chiaro il suo suggerimento a non frequentare i medici e non fruire dei loro farmaci per il mantenimento della salute: “Insegnati di conservare la sanità la qual cosa tanto più ti riuscirà quanto più dal fisico ti guarderai poiché le sue composizioni son di spezie e d’alchimia”.
La rottura con il mondo della Medicina ufficiale nasce, come di sovente accade, da un conflitto personale con il medico Mariano Santo da Barletta (1488-1577). Il Santo, dopo aver coperto come successore di Giovanni da Vigo (1450-1525) la cattedra di Chirurgia a Bologna, si trasferisce a Roma dove acquisisce notorietà come urologo. Opera nell’Ospedale di Santa Maria della Consolazione sito ai piedi del Campidoglio (dal lato opposto dell’odierna Piazza Venezia). È qui che a metà del cinquecento eserciterà Bartolomeo Eustachi (1500-1574) e un secolo più tardi sarà sede di un’Accademia di Anatomia con dissezioni pubbliche. L’ospedale, insieme a quello di Santo Spirito, accoglierà Leonardo nel suo periodo romano per essere sede degli studi anatomici tradotti poi nei ben conosciuti disegni che insieme a quelli del periodo milanese in collaborazione con il veronese Marcantonio della Torre (1481-1511), anatomico all’Università di Pavia, avrebbero dovuto costituire un atlante anatomico. La prematura morte per peste a Desenzano del della Torre impedirà la comparsa dell’opera.
La presenza di Leonardo infastidisce il Santo che vede un’ennesima abusiva invasione di campo ad opera degli artisti e barbieri a cui la classe medica ha dovuto abituarsi e ne nasce una diatriba che diventa pubblica. Dal canto suo Leonardo non lesina esplicite critiche al Santo; con chiara polemica invita un conoscente a consultare il Santo, ed un altro medico, su un particolare caso clinico; secondo Leonardo potrà in tal modo rendersi conto di quanto il Santo sia ignorante: “fatevi dare la definitione e riparo del caso al Sancto e all’altro e vedrete che omini sono eletti per medici di malattie da lor non conosciute”2.
La maggior parte di notizie sulla vita di Leonardo ci pervengono da Giorgio Vasari (1511-1574) nella sua opera sulla vita degli artisti rinascimentali. I suoi scritti, pur se da alcuni ritenuti troppo “fantasiosi” pertanto non sempre veritieri, sono tuttavia quanto di più reale possiamo conoscere sulla persona e su alcuni suoi aspetti particolari; “Vasari ci dice di Leonardo tutto quanto è utile per capirne il carattere”1, 3.
Nello scritto vasariano emerge subito un atteggiamento caratteristico della personalità di Leonardo: “Vedasi bene che Lionardo per l’intelligenza dell’arte cominciò molte cose e nessuna mai ne finì”3.
In pratica Leonardo si fa conquistare da ogni novità che stimola la sua ricerca dedicandosi totalmente ad essa e tralasciando gli aspetti pratici che ne hanno determinato la comparsa. Come ben sottolinea lo storico dell’arte austriaco Ernst Gombrich (1909-2001) ne consegue un ritardo in ogni commessa artistica: “Leonardo non portava a termine le commissioni affidategli. Cominciava con un quadro per poi lasciarlo incompleto nonostante le sollecitazioni del cliente”4.
È papa Leone X (1475-1521, Giovanni Medici figlio del Magnifico) a definirlo un fannullone perditempo: gli commissiona due piccole Madonne per il suo confessionale ma l’artista temporeggia e ritarda l’opera dedicandosi allo studio di una lacca composta da olii ed erbe da stendere sui dipinti come vernice finale e la cosa irrita il Pontefice, come riferito dal Vasari: “Gli (a Leonardo) ha allogato un’opera dal papa, perché subito cominciò a stillare olii et erbe per farne vernice perché fu detto da Papa Leon: oimè costui è per far nulla, da che comincia a pensare alla fine innanzi il principio dell’opera”3.
Nel 1489 Ludovico Sforza detto il Moro (1452-1508) vuole onorare il padre Francesco Sforza (1401-1466) con un monumento equestre, in analogia a quello di Verrocchio per il Colleoni o di Donatello per il Gattamelata, e si rivolge a Lorenzo il Magnifico (1449-1492) che gli raccomanda Leonardo che propone al Moro “un cavallo di bronzo di meravigliosa grandezza per mettergli in memoria l’immagine del duca e tanto grande lo cominciò e riuscì che condur non si potè mai”3. Arrivato a Milano per l’opera Leonardo chiede di frequentare le scuderie degli Sforza per meglio studiare l’anatomia equina; vuole infatti analizzare le parti più belle dei purosangue per creare il cavallo ideale. Ben presto la sua attenzione si rivolge al “collo di Morel Fiorentino” o alle “cosce di Ronzone” di cui esegue numerosi disegni; nella sua mente il progetto del monumento si attenua per lasciare spazio all’anatomia equina. Ma anche questa in tempi brevi è sostituita ad un altro progetto: è stimolato dalla necessità di pulizia delle stalle ed idea un sistema idraulico per l’igiene delle stalle. Il progetto del monumento intanto langue e si limita ai disegni equini (sparsi nella collezione di Windsor, nel Codice atlantico dell’Ambrosiana e nella Biblioteca Nazionale di Madrid) e ad infruttuosi di prototipi, ben presto abbandonati per motivi tecnici. I tentativi di creare un cavallo immenso frutto di un’unica colata di bronzo falliscono per lasciare il posto al solo stampo. Questo diventerà poi il bersaglio preferito dagli arcieri francesi nella seguente dominazione francese del ducato. L’opera non sarà mai realizzata ma dopo cinque secoli grazie la fondazione statunitense “Leonardo da Vinci’s Horse Fundation” (LVHF) finalmente il monumentale cavallo vedrà la luce: creato secondo i disegni leonardeschi dall’artista giapponese Nina Akamu e donato nel 1999 al comune di Milano troneggia oggi nel piazzale dell’Ippodromo di San Siro in Milano.
Sempre Vasari riporta i tentennamenti di Leonardo, in terra francese, all’invito del monarca Francesco I a ritoccare il manto azzurro di Sant Anna su un cartone, attualmente al Louvre: “Re Francesco desiderava che colorisse il cartone di Sant Anna ma egli secondo il suo costume lo tenne in gran tempo in parole”3.
L’atteggiamento di Leonardo è chiaro: come ha sottolineato Isacson, “in lui è più forte l’amore per l’ardua impresa del concepimento che per la routine del completamento”5.
Questi curiosi aspetti della vita professionale leonardesca hanno suggerito la presenza di uno stato psichico studiato dai ricercatori Mazzarello e Catani che hanno ricondotto il fenomeno ad un quadro patologico comportamentale etichettato come Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), un’alterazione deficitaria dell’attenzione associata ad una spiccata iperattività6. Il disturbo si presenta come una procrastinazione continua dei compiti e dei progetti con incapacità a portarli a compimento singolarmente. A tale aspetto corrisponde un’attività intellettuale sfrenata con curiosità elevata verso nuovi ambiti sempre alla ricerca di nuovi stimoli progettuali. Ne scaturisce una creatività illimitata dove la mente si rivolge in maniera incontrollata a lidi inesplorati: ad un progetto ne subentra un altro altrettanto urgente e monopolizzante che blocca il precedente. La spinta verso nuovi progetti è continua ed impedisce di portare a termine quello in atto. La capacità ad iperfocalizzarsi su un nuovo percorso inibisce così l’attenzione sulla realtà restante determinando così uno stato di disattenzione relativa. Il soggetto affetto da ADHD è vulcanico e fantasioso in fase creativa ma nullo nella concretizzazione; allo sviluppo della fase iniziale di un progetto ne subentra immediatamente un altro che lo annulla totalmente. Come descrive Gombrich: “Intraprendeva le sue ricerche e i suoi esperimenti solo per curiosità insaziabile e che una volta risolto per uso personale un problema se ne disinteressa”4.
Ne sono prova i trattati scientifici di Leonardo densi di intuizioni esplosive di cui nessuna tradotta in pratica; lo stesso trattato sulla pittura costituito da preziosi consigli e regole sarà redatto dall’allievo Francesco Melzi (1491-1570) diversi anni dopo la morte del maestro.
Leonardo ha l’abitudine di portare con sé un taccuino su cui annota di tutto; nei vari taccuini Leonardo lascia elenchi dettagliati di temi vari da sviluppare ma uno svolgimento in extenso e le conclusioni non compaiono mai poiché tutti si fermano ad una fase iniziale per lasciare il posto a nuovi interessi.
Adesso Leonardo è a Roma grazie alla benevolenza del suo protettore Giuliano de’ Medici duca di Nemours (1479-1516), il fratello minore di Leone X, che gli trova una sistemazione in un’ala del Belvedere. È un palazzo adiacente ai giardini vaticani progettato dal Pollaiolo come sede estiva del pontefice in cui alloggiano numerosi artisti di vario genere impegnati in Vaticano; il trasferimento romano è una scelta obbligata poiché a Firenze molte porte gli si sono chiuse.
Spera nella città papale dove però più giovani ed agguerriti rivali, come Raffaello (1483-1520) e Michelangelo (1475-1564), dettano legge; il primo vive più da principe che da pittore diviso tra i palazzi pontifici e la Villa Farnesina del banchiere Agostino Chigi mentre il secondo, formalmente agli antipodi, ha saputo strabiliare con le gigantesche figure della cappella Sistina. Leonardo ha poco più di sessant’anni, gli artisti in Roma sono numerosi e riuscire ad avere una commessa è diventato una competizione. Commercialmente inizia ad essere in seconda linea: lo stesso suo protettore e mecenate Giuliano de Medici nel 1515 commissiona un suo ritratto, oggi al Metropolitan di New York, addirittura a Raffaello.
A Leonardo inoltre manca la costanza necessaria alla pittura ed i suoi interessi ultimamente si sono rivolti alle scienze speculative, soprattutto all’anatomia.
Tutti questi aspetti sfociano in uno stato depressivo; è in tale fase che disegna in sanguigna su carta un autoritratto, che tutti conosciamo, oggi alla biblioteca reale a Torino.
Nel 1515 un evento lo segna: Leone X vuole finalmente completare la facciata della Chiesa fiorentina di San Lorenzo costruita dal Brunelleschi ma ferma da tempo ed indice una gara a cui partecipa Leonardo insieme a Michelangelo, Raffaello, Giuliano da Sangallo, Jacopo Sansovino, Baccio d’Agnolo. L’incarico viene dato a Michelangelo e comunque la facciata resterà incompiuta. Vasari lo racconta: “Era sdegno grandissimo fra Michele Agnolo Buonarroti e lui, ed essendo esso (Michelangelo) chiamato dal Papa per la facciata di San Lorenzo, Lionardo intendendo ciò partì ed andò in Francia”3.
Leonardo comprende immediatamente che lo spostamento romano al seguito di Giuliano de’ Medici non è stato conforme alle sue aspettative e soprattutto che la sua collocazione nel nuovo ambito artistico è diventata problematica. Deve ancora rivolgersi altrove. Sa che nel 1515 a Bologna avverrà l’incontro tra il Papa Leone X e il nuovo monarca francese Francesco I (1497-1547). Il giovane re, della dinastia dei Valois Angouleme, è succeduto appena ventunenne al suocero Luigi XII degli Orleans.
L’occasione di un contatto con Francesco I è propizia: si reca a Bologna al seguito di Leone X ma un incontro personale con il monarca non è facile; sono in molti a voler avvicinare il re franco che è protetto da un cerchio magico di cortigiani che gli fanno da filtro. Riesce a conoscere Artur Boissif, il maestro reale di camera che chiaramente ha contatti intimi con il monarca e che lo segue in tutti i suoi spostamenti; facendo leva sull’ambizione e narcisismo di Boissif gli esegue un ritratto ad inchiostro su carta con la promessa di trasferirlo in tempi brevi su tela. La promessa non avrà seguito ma gli si aprono così le porte della corte francese. Del ritratto non avremo mai traccia.
Francesco I conosce Leonardo già da alcune sue opere: “il re avendo avuto opere sue gli era molto affezionato”, il colloquio tra i due è breve ma l’intesa immediata ed il re gli propone di seguirlo in Francia dove restaura e gli mette a disposizione il maniero di Saint Cloux.
È un elegante castellotto di campagna della fine del XIII secolo nella valle della Loira a duecento kilometri a sud-ovest da Parigi; inizialmente di proprietà dell’armaiolo di Luigi XI, poi di Pierre Morin, tesoriere di Francia. In mattoni rossi con portali in gotico fiammeggiante in tufo bianco è lambito dall’Amas, modesto affluente della Loira, tra le zone boschive più belle di Francia su una collinetta antistante il castello reale di Amboise. Alla fine del XVIII secolo la costruzione diventerà il castello di Clos Lucè per poi essere acquistato nel 1854 dalla famiglia Saint Bris, nobili di Perigueux della Dordogna ed attuali proprietari.
La proposta di Francesco I è quanto Leonardo ha sempre cercato: un luogo tranquillo dove può dedicarsi ai suoi studi in assenza di assilli economici grazie l’appannaggio mensile di un vero mecenate, è una somma generosa di duemila scudi pari all’entrata mensile di un cardinale di modesti introiti. Sarà ufficialmente nominato “primo pittore, ingegnere ed architetto del re”.
Leonardo accetta ma come sempre è indeciso, temporeggia ritardando la partenza malgrado i reiterati solleciti che Francesco I gli invia tramite il suo ambasciatore: “Esorto il Maestro Leonardo a presentarsi al cospetto del re, stia pur certo che sarebbe stato accolto di cuore sia dal re sia da madame sua Madre”. La stessa Luisa di Savoia, madre di Francesco I, sollecita la venuta tramite la sorella Filiberta di Savoia moglie del protettore Giuliano de’ Medici.
Finalmente alla fine dell’estate del 1516 Leonardo si decide per il trasferimento prima che le nevi rendano difficoltoso il valico delle Alpi a dorso di mulo. Sono con lui il favorito Giacomo Caprotti detto Salai, l’allievo Francesco Melzi, ed il servitore Battista de Vilannis. Alla compagnia si aggiungerà in terra francese la fantesca Mathurine, una popolana di Tours. La comitiva risale la Val d’Ossola per valicare il Sempione, discende l’alto corso del Rodano verso il lago di Ginevra e si dirige a Lione; dal porto fluviale di Roanne si imbarca per navigare la Loira e raggiungere Amboise.
Per Leonardo inizia la fase finale della vita attorniato dal suo gruppo (il Salai in rotta con il Maestro si fermerà a Milano per poi raggiungere saltuariamente Close Lucè) e dall’ammirazione ed affetto sincero di Francesco I che lo visita quasi quotidianamente; si narra di un tunnel sotterraneo di circa trecento metri che mette in comunicazione il castello di Amboise, la residenza reale, con Clos Lucè. Comunque durante i lavori di ristrutturazione nella metà del XIX secolo la struttura sotterranea non verrà mai identificata.
Negli incontri i due conversano sugli argomenti più disparati; Francesco venera la cultura poliedrica e la saggezza di Leonardo come ci riferisce Benvenuto Cellini (1500-1571) “io non voglio mancare di dire le parole che io sentii dire dal Re di lui (Leonardo), disse che non credeva mai che altro uomo fusse nato al mondo, che sapessi tanto quanto Lionardo, non tanto di pittura, scultura ed architettura quanto che gli era grandissimo filosofo”7.
Il 3 maggio 1519 Leonardo muore nella sua stanza al piano superiore di Clos Lucè tra le braccia di Francesco I. È sempre Vasari che ci informa: “Onde gli (a Leonardo) gli venne un parossismo messagggiero della morte: per la qual cosa rizzatosi il re presagli la testa per aiutarlo e porgergli favore, acciochè il male lo alleggerisse, lo spirito suo che divinissimo era, conoscendo non potere avere maggior onore, spirò in braccio a quel re”3. La presenza del monarca secondo alcuni è frutto della fantasia del Vasari: il 3 maggio Francesco I rilascia un proclama a Saint Germain en Laye a due giorni di cavallo da Amboise ma va sottolineato che il proclama, pur se emanato dal monarca, porta la firma del Cancelliere ed inoltre i documenti del Consiglio relativi dell’evento a Saint Germain non parlano della presenza del re. Nulla vieta quindi di ritenere vero quanto riferito dal Vasari.
La scena diventerà famosa tre secoli dopo grazie il pennello di Jean August Ingres in un quadro attualmente al Petit Palais di Parigi. Il dipinto ritrae Francesco I chino in un abbraccio ad un Leonardo agonizzante. Nella stanza assistono il Melzi, un cardinale con il giovane primogenito reale Francesco ed un monaco domenicano. In maniera fin troppo sfacciata Ingres ha copiato la figura di Francesco dettagliatamente e in toto da un famoso quadro di due secoli prima di Tiziano Vecellio e rappresentante il monarca. Quarant’anni prima di Ingres un altro pittore francese, François Guillame Menageot, aveva ritratto la stessa scena in un dipinto attualmente nel castello di Amboise; in questa tela è presente anche un medico intento a palpare il polso a Leonardo, Mathurine ed oltre a Francesco, primogenito del re, il secondogenito Enrico. I due saranno merce di scambio da parte di Francesco I per ottenere la libertà dopo la sconfitta nella battaglia di Pavia.
Il decesso di Leonardo non sembra ascrivibile ad un evento acuto ma preceduto da una fase prodromica di alcuni giorni: il 23 aprile infatti, quindi nove giorni prima dell’exitus, Leonardo intuisce la criticità della sua salute e convoca il notaio Guillaume Boreau a cui detta verbalmente il testamento.
Nel 1517 alla corte papalina si verifica un evento le cui sequele ci permettono in maniera indiretta di conoscere un aspetto fondamentale del quadro clinico di Leonardo e del suo decesso: nell’ambito del Collegio dei cardinali si concretizza un complotto con l’intento di eliminare Leone X. Il suo atteggiamento e l’andazzo dell’ambiente pontificio hanno ben presto suscitato antipatie ed anticorpi tali da configurare un gruppo di congiurati capeggiati dal porporato senese Alfonso Petrucci e dal Raffaele Sansoni Riario della Rovere insieme ai cardinali Francesco Soderini, Adriano Castellesi, Bandinello Sauli con la connivenza di Marcantonio Nini, segretario del Petrucci. Tra le quinte del complotto c’è Francesco Maria della Rovere, nemico giurato dei Medici, e la famiglia Colonna; il progetto prevede l’eliminazione di Leone X per poi coronare con la tiara papale il Riario, il potente decano del collegio cardinalizio.
È il secolo in cui il veleno e il pugnale sono i protagonisti di ogni omicidio ma in tal caso la sua somministrazione per via orale non è percorribile: un rigido protocollo espletato dai “pregustator” (assaggiatori) tutela il pontefice nell’assunzione di cibi o bevande da un possibile delitto “per veneficium”.
È necessario quindi identificare un’altra via: Leone X è portatore da tempo di una fistola anale cronica e secernente che necessita di frequenti medicazioni; sarà il medico incaricato della medicazione ad introdurre nel tragitto fistoloso la “cantarella”, una polvere incolore ed insapore a base di sale di arsenico la cui preparazione molto empirica ed artigianale è alla portata di tutti.
Viene pertanto allontanato il medico personale del Papa Jacopo da Brescia per incaricare della medicazione e del delitto il chirurgo Battista da Vercelli (1465-1517). Al sanitario oltre ad un compenso in oro è stata promessa una carica accademica di rilievo all’Università romana La Sapienza. Ma gli informatori papali, infiltrati ovunque, intercettano e riescono a decifrare una lettera indirizzata al Petrucci in cui, pur se vagamente, si fa cenno della congiura che viene pertanto scoperta. La reazione di Leone X è immediata e terribile tramite il temuto inquisitore papale Mario Peruschi. Con la tortura tutti gli inquisiti diventeranno rei confessi: i cardinali Petrucci, Soderini, Castellesi e Sauli verranno imprigionati in Castel Sant’Angelo seguiti poi dal Riario, dal Battista da Vercelli e dal Nini.
Il Petrucci viene giustiziato per strangolamento mentre il Battista ed il Nini sono impiccati e squartati tra due cavalli sul ponte Aelius, quello di Castel Sant’Angelo. Gli altri congiurati saranno risparmiati ma confiscati i loro beni e soggetti a pesanti pene pecuniarie oltre alla cancellazione del potere contrattuale ed economico della porpora (non avranno comunque diritto di voto in Conclave).
Va aggiunto che sull’evento sono state recentemente avanzate perplessità sulla vera natura del presunto complotto; secondo lo storico Simonetta le confessioni di colpevolezza furono estorte con la tortura e il tutto fu una diabolica macchinazione architettata da Leone X per epurare una fazione del Collegio cardinalizio a lui ostile fin dal suo insediamento pontificio. Va anche ricordato che l’allontanamento di alcuni componenti del Collegio permetterà a Leone X la nomina di ben trentun nuovi cardinali accompagnati dal relativo pesante obolo obbligatorio; in pratica si tratterebbe anche di un operazione finanziaria atta a sanare le sofferenti casse papali8.
Ma torniamo a Leonardo in Loira ospite di Francesco I; nel pomeriggio del 10 ottobre 1517 riceve la visita del cardinale napoletano Luigi d’Aragona (1474-1519) accompagnato dal suo segretario il chierico Antonio de Beatis di Molfetta. Il d’Aragona, nipote del re di Napoli, è un personaggio di spicco nella corte papale: è stato stretto consigliere di Giulio II ed ora grazie le sue capacità diplomatiche e qualità salottiere è tra gli intimi di Leone X; è lui l’organizzatore delle fiabesche feste papali alla villa della Magliana. Ma dopo il presunto complotto il Papa sospetta di tutto e di tutti e lo stesso d’Aragona, poiché amico dei congiurati Castellesi e Soderini, capisce che il momento è delicato e che potrebbe facilmente risultare compromesso; decide pertanto di allontanarsi per un lungo viaggio in Austria, Germania, Fiandre e Francia, ufficialmente per recarsi nei Paesi Bassi a rendere omaggio a Carlo V per la sua recente salita al trono di Spagna e per visionare alcuni arazzi commissionati da Leone X alle manifatture di Bruxelles.
Il gruppo di viaggio è costituito da una quarantina di persone oltre il porporato con il chierico segretario. Il tour ha inizio da Ferrara il 9 maggio 1517 con ritorno il 16 marzo 1518 a Roma dove il cardinale verrà comunque accolto benevolmente da Leone X; resterà poi sempre a Roma per riposare oggi nella Chiesa di Santa Maria sopra Minerva.
Durante tutto il tour il segretario de Beatis, ligio al suo ruolo, tiene un diario estremamente preciso e redatto in modo molto ordinato in “lingua vulgare” (italiano) dove riporta luoghi, tempi, contatti ed eventi con una calligrafia perfettamente leggibile e con annotazioni esplicative di rimando ai bordi laterali delle pagine9.
Il destino immediato del diario al rientro dal viaggio è sconosciuto; presumibilmente data la parentela dell’Aragona con la casata reale napoletana rimarrà nella città partenopea per essere più tardi depositato nella biblioteca reale Vittorio Emanuele di Napoli dove resterà nascosto in uno scaffale per essere finalmente rinvenuto nel 1873 dall’austriaco Ludwig von Pastor (1854-1928), storico e diplomatico autore di una ponderosa storia dei Papi in 40 volumi. Il Pastor comprende subito la valenza storica del manoscritto e lo pubblicizza.
Durante il rientro in Italia nel tragitto in terra francese il d’Aragona vuole fermarsi per un saluto a Leonardo con cui ha avuto frequenti contatti in Roma: il palazzo Della Rovere (attualmente Dei Penitenzieri sede di un hotel in via della Conciliazione) dove abita il porporato è vicino al Belvedere dove alloggia Leonardo. La visita del porporato a Leonardo gli permette anche di rendere omaggio a Francesco I.
L’incontro avviene a Clos Lucè al piano terreno dove Leonardo ha stabilito il suo studio-laboratorio: sono presenti il d’Aragona con il de Beatis e Leonardo con il Melzi e il de Vilanis. Non sappiamo della presenza di Francesco I.
È a pagina 76 del diario del de Beatis, relativa all’incontro, in cui troviamo notizie sulla salute di Leonardo.
Leonardo mostra al d’Aragona alcuni suoi disegni anatomici srotolando egli stesso i carteggi e i quadri che si è portato dall’Italia (la Gioconda, San Giovannino e Sant’Anna); ce ne parla il de Beatis: “il nostro eccellentissimo (Leonardo) mostrò ai signori Illmi tre quatri, uno di una certa dama fiorentina (la Gioconda), l’altro di San Johanne Baptista jovane ed uno della Madonna et del figliuolo che stanno posti in grembo di Sancta Anna”9, 10.
Il chierico molfettano è un acuto osservatore e ha modo di notare un certo impaccio e difficoltà nei movimenti fini del braccio e mano destri di Leonardo e fa risalire il disturbo ad una probabile pregressa paresi dell’arto superiore. Si domanda inoltre come Leonardo, data la menomazione, potrà continuare a creare quadri di bellezza e con delicatezza di colori come i tre appena presentati. Trae una sua conclusione: fortunatamente il Maestro ha saputo formare un ottimo allievo, quale il Melzi di Milano, che potrà sostituirlo nella pittura mentre potrà invece continuare nell’insegnamento e nel disegno: “..tutti perfectissimi (i quadri), ben vero che da lui per esserli venuta certa paralesi ne la dextra, non ci si può expectare più cosa buona. Ha ben formato un creato milanese che lavora assai bene. Benché il predetto messere Leonardo non possa colorare con quella dolcezza solita che solea, pure può fare disegni ed insegnare agli altri”.
Quanto riferito dal de Beatis è ascrivibile ad un’alterata funzionalità dell’arto superiore destro secondaria ad un deficit postparetico. Prende quindi forma e diventa lecita la diagnosi di un pregresso ictus cerebri (nella letteratura scientifica anglosassone: stroke) emisferico focale sinistro con conseguente paralisi dell’arto superiore destro da un’ipotizzabile etiologia ischemica secondaria ad una vasculopatia cerebrale intra o extracranica. In pratica la responsabile del danno ischemico in una zona specifica dell’emisfero sinistro del cervello di Leonardo fu una lesione stenotico ostruttiva, verosimilmente di natura ateromasica, a carico del circolo carotideo extracranico o dei vasi cerebrali intracranici sinistri. Il quadro clinico rilevato dal de Beatis si configura pertanto identificabile come i residuati di un evento acuto di insufficienza cerebrovascolare: le difficoltà nei movimenti dell’arto superiore destro di Leonardo sono gli esiti stabilizzati di grado moderato di un pregresso stroke.
Il quadro clinico di deficit funzionale parziale è definito secondo la stadiazione un “minor stroke” o stadio III A: in pratica Leonardo fu vittima di un’ischemia cerebrale la cui evoluzione si stabilizzò poi con reliquati di impotenza funzionale di grado medio-moderato all’arto superiore destro.
La comparsa dell’evento è databile nell’anno 1515 durante il soggiorno romano: è desumibile da una lettera del 1515 di Leonardo al suo protettore Giuliano de’ Medici: “Io ho quasi avuto la sanità mia, sono all’ultimo del mio male”. Con la frase Leonardo si riferisce ad una fase finale di un decorso graduale, lento ma progressivo, di una ripresa e un recupero funzionale dalla paralisi che lo ha colpito. È quanto di norma avviene in maniera, tempi e modalità variabili, nei pazienti vittime di uno stroke.
Circa le conclusioni del chierico sull’impossibilità di Leonardo di dipingere come prima va sottolineato che non tengono conto del mancinismo di Leonardo: l’arto superiore sinistro è infatti indenne. Ne è prova che Leonardo anche nelle fasi finali della vita continuerà a produrre disegni come “I diluvi” o ritocchi come quelli al manto azzurro di Sant Anna.
Sul riscontro della pregressa paresi dell’arto superiore destro di Leonardo si sono nel tempo sviluppate congetture varie poggianti su elementi non sempre plausibili e dalle conclusioni opinabili e fin troppo fantasiose.
Un’interpretazione piuttosto articolata si riconduce al disegno n.834, conservato nel Gabinetto Disegni e Stampe dell’Accademia di Venezia, di Giovanni Ambrogio Figino (1552-1608), pittore manierista lombardo. Il disegno rappresenta Demostene ed Eraclito; quest’ultimo con le presunte sembianze di Leonardo analoghe al conosciuto autoritratto di Leonardo. Il personaggio presenta il quinto e quarto dito della mano destra contratti in una flessione che è stata identificata spastica come può configurarsi negli esiti di una paralisi con comparsa della “spasticità post ictus”. Infatti nei pazienti vittime di uno stroke con conseguente paresi dell’arto superiore alla ripresa graduale della motricità, dopo un periodo congruo e variabile, può residuare nel 35-40% dei casi un aumento del tono muscolare con conseguente difficoltà ad estendere le dita che restano in flessione contratta persistente e talvolta dolorosa. Il Figino farà seguire al disegno un dipinto ad olio su tavola di quercia (attualmente in collezione privata) i cui personaggi presentano le stesse analogie morfologiche alla mano riportate nel disegno. Secondo alcuni il Figino ha voluto ritrarre Leonardo nella fase post stroke con uno stato di spasticità post ictus. L’ipotesi della supposta spasticità post paretica diventa comunque labile: il Figino in tutta la sua pittura ritrae infatti le mani dei personaggi anziani in maniera marcatamente contratta, talvolta deforme. Diventano una sua cifra pittorica. Ne sono prova il suo San Luca nella cappella destra della chiesa di San Raffaele in Milano o il San Giovanni Evangelista (stranamente anziano) con San Michele in una tela conservata a Brera: in ambedue i personaggi sono ritratte le dita marcatamente contratte.
L’invocata spasticità risulta quindi un vezzo del Figino privo di ogni significato clinico applicabile a Leonardo.
Nulla conferma inoltre che il Figino volesse ritrarre Leonardo nei panni di Eraclito: potrebbe avere preso a modello il viso dell’autoritratto e non va dimenticato che Leonardo muore nel 1519 mentre il pittore lombardo nasce nel 1553: difficilmente poteva quindi essere al corrente della supposta spasticità.
Secondo un’altra teoria più articolata ma ancor più opinabile la spasticità riportata dal Figino fu la risultante di un trauma del nervo ulnare occorso a Leonardo durante una caduta.
Dagli aspetti descritti diventa pertanto lecita una diagnosi di minor stroke ischemico sinistro, ascrivibile ad un’insufficienza cerebrovascolare secondaria ad una patologia stenotico ostruttiva dei vasi cerebroafferenti: in pratica Leonardo fu vittima di un ipoafflusso ematico all’emisfero cerebrale sinistro con conseguente sofferenza di un territorio del parenchima cerebrale.
Il deficit fu l’espressione di lesioni vascolari (nel territorio carotideo sinistro) verosimilmente di natura ateromasica e sintomatiche con un meccanismo fisiopatologico emodinamico e/o emboligeno.
È la constatazione della natura anatomopatologica di tali lesioni vascolari che ci indica il percorso per comprendere il decesso di Leonardo; sono lesioni stenosanti di natura verosimilmente ateromasica compatibili con l’età biologica ed anagrafica del soggetto (Leonardo ha 67 anni), secondarie ad un quadro di aterosclerosi.
È curioso come Leonardo avesse già identificato il problema di uno stato ischemico ed intuito in maniera corretta la causa: “la qual causa trovai venir per mancamento di sangue che nutrisce il cuore e li altri membri inferiori, li quali li trovai aridi stremati e secchi”.
Ha saputo anche comprendere il potenziale stenosante emodinamico di una lesione della parete vasale: “L’arteria e la vena si fa di tanta grossezza di pelle ch’ella serra il transito del sangue”.
L’aterosclerosi si presenta come una patologia (degenerativa ed inizialmente infiammatoria) cronica con due caratteristiche peculiari: è sistemica e polidistrettuale.
Colpisce infatti tutto il sistema arterioso ed in maniera variabile i suoi vari distretti con localizzazioni secondo associazioni ben definite; frequente è infatti l’accoppiata stereotipata di lesioni vasali del distretto sopra aortico e/o a destino cerebrale con analoghe al distretto coronarico.
Ne è prova che in pazienti vittime di uno stroke secondario ad una lesione carotidea nei tre anni seguenti l’evento ischemico cerebrale si ha un’incidenza nel 43% dei casi di un infarto miocardico da concomitante lesione coronarica.
La comparsa di un evento ischemico miocardico diventa pertanto una diagnosi di sospetto proponibile come causa del decesso di Leonardo.
È probabile che Leonardo avesse manifestato sintomi cardiaci (precordialgia, angina) alcuni giorni prima all’exitus inducendolo a stilare il testamento in data 23 aprile (nove giorni prima); fu pertanto una decisione obbligata dettata da una situazione di necessità.
Non si trattò quindi di una possibile recidiva di stroke (come prospettato da alcuni) poiché, come riferisce Vasari, scese dal letto in maniera autonoma, pur se con l’aiuto di amici, per comunicarsi: “Sostenendosi nelle braccia di suoi amici e servi volse divotamente pigliare il Santissimo Sacramento fuor dal letto”3.
Inoltre alla comparsa di Francesco I si rizzò sul letto: “…per il che egli per riverenza rizzatosi sul letto”.
In ambedue i casi la cosa diventava non possibile in un soggetto vittima di un danno neurologico ischemico.
Il Vasari descrive poi gli ultimi istanti di Leonardo: “Onde gli venne un parossismo messaggero della morte: per la qual cosa rizzatosi il re e presagli la testa per aiutarlo e porgergli favore, acciochè il male lo alleggerisse, lo spirito suo che divinissimo era, conoscendo non poter aver maggior onore, spirò in braccio a quel re”.
Un’interpretazione attenta di quanto descritto permette di identificare due aspetti significativi e probanti di una morte cardiaca: il “parossismo messaggero della morte” è identificabile come il sintomo soggettivo classico di “sensazione di morte imminente” tipico di un paziente in preda ad una sindrome coronarica in fase acuta, mentre “il male” che il re tenta di mitigare è ascrivibile al dolore anginoso coronarico.
In pratica Leonardo portatore di una coronaropatia (verosimilmente fino a quel momento asintomatica) presentò la comparsa di un quadro anginoso circa dieci giorni prima del decesso obbligandolo a redigere il testamento e che sfociò poi in un infarto miocardico mortale.
Una diagnosi completa del decesso di Leonardo da Vinci è pertanto: “Infarto miocardico acuto secondario a coronaropatia in pregresso minor stroke focale sinistro (stadio III A). Sindrome ADHD”.
Ma anche dopo la morte Leonardo non cessa di stupirci: le sue spoglie sono avvolte nel mistero. È una storia che, pur se frammentaria, vale la pena essere conosciuta.
Dopo un’immediata sepoltura provvisoria ne segue una definitiva nella vicina Collegiata di Saint Florentin che sarà poi distrutta durante le guerre religiose del 1560. Nel 1863 Arsène Houssaye, scrittore amico di Baudelaire ed ispettore generale dei musei francesi, nella ricerca tra i ruderi di Saint Florentin reperisce resti di ossa ed un cranio con un’iscrizione latina su due pezzi marmorei con le iniziali di Leonardo da Vinci.
Gli eventi seguenti restano ignoti fino al 1874: Louis Philippe Albert d’Orleans (1838-1894) rampollo della casata degli Orleans con il nome di Luigi Filippo II di Francia entra in possesso delle spoglie e dice di tumularle nella cappella di Saint Hubert nel parco del castello di Amboise.
Nella storia compare poi un elegante personaggio da romanzo storico discendente di Houssaye: è Henry d’Orleans Comte de Paris (1908-1999), Enrico VI di Francia.
All’invasione nazista della Francia Henry d’Orleans si rifugia a Londra dove si arruola con il nome di Henry d’Orliac nella Legione straniera il cui contingente è espatriato in territorio inglese; viene formata la XIII Demi Brigade de Légion étrangère, un battaglione di legionari volontari per la Francia libera a cui Henry d’Orliac aderisce. Il battaglione aggiunge allo stemma della Legione la croce di Lorena simbolo della Francia libera. Il d’Orliac combatterà valorosamente con le forze alleate ad El Alamein e nella liberazione della Francia.
Quando durante l’occupazione nazista francese Hitler ordinerà capillari ricerche in tutta la valle della Loira delle spoglie di Leonardo per farne omaggio a Mussolini il fronte clandestino di liberazione francese (France Libre) riuscirà ad allertare Henry d’Orleans come discendente di Louis Philippe d’Orleans; temono che i tedeschi possano impossessarsi dei resti ufficialmente sepolti da Louis Philippe nella Cappella di Saint Hubert. Ma la risposta di Henry d’Orleans sarà rassicurante: i resti di Leonardo sono al sicuro a Londra in una valigia sotto il letto del suo maggiordomo11.
Sarà lui stesso al rientro in patria dopo la liberazione nell’agosto del 1944 a sotterrare le spoglie in un luogo nascosto ed ancor oggi ignoto nel parco di Amboise.
Nella ristrutturata cappella di Saint Hubert le spoglie attualmente presenti sono definite “presunte”.
Prof. Angelo Argenteri, Professore Ordinario Emerito di Chirurgia Vascolare, Università degli Studi di Pavia
Per la corrispondenza: angeloargi@libero.it
BIBLIOGRAFIA