Anno Accademico 2024-2025
Vol. 69, n° 1, Gennaio - Marzo 2025
Conferenza: Medicina e humanities: Slow Medicine, Narrative Medicine, Alternative Medicine
10 dicembre 2024
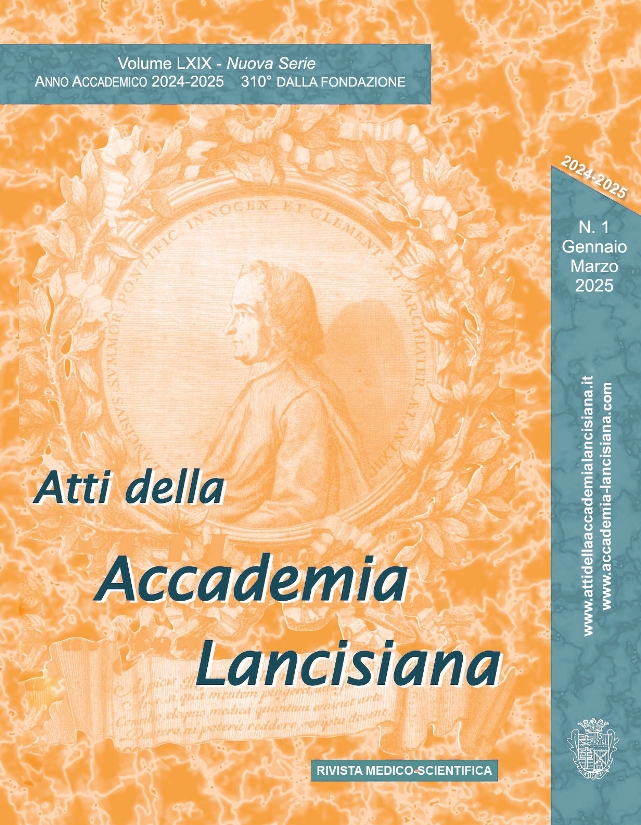
Conferenza: Medicina e humanities: Slow Medicine, Narrative Medicine, Alternative Medicine
10 dicembre 2024
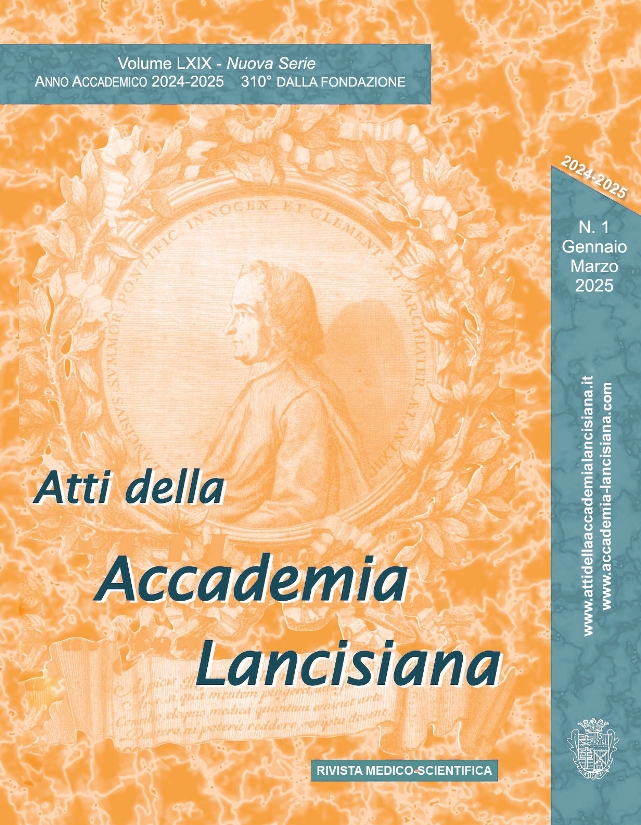
Versione PDF dell'articolo: Download
In una chiacchierata del febbraio 2024 alla Accademia Lancisiana1, io feci qualche critica alla Medicina basata sulle prove (Evidence Based Medicine) e giustamente mi fu fatto osservare che però questa Medicina - sostanzialmente fondata sulla utilizzazione medica di altre discipline, dalla fisica alla chimica alla statistica e basata su quello che si suole indicare come il paradigma riduzionistico, per cui un sistema complesso non è fondamentalmente se non la somma delle sue parti - divenuta “scienza” ha indotto enormi progressi che hanno a loro volta avuto eccezionali ripercussioni anche sociali, dall’aumento della vita media, ai trapianti e alle tecniche protesiche, alle nuove tecniche chirurgiche e anestesiologiche, tanto per ricordarne alcune assolutamente innegabili.
Anticipo subito una interessante osservazione di Leopardi2 sulla durata della vita, che egli scrive nello Zibaldone nel 25 novembre 1820, recensendo un volumetto di un tedesco dal titolo “L’arte di prolungare la vita umana”3 che aveva naturalmente avuto un certo successo: “Ho veduto le lezioni di un tedesco, il signor Hufeland, dell’arte di prolungare la vita, lezioni da lui dettate per una cattedra. Prima bisognava insegnare a rendere la vita felice e quindi a prolungarla… Invece di fondare queste cattedre che sono contrarie alla natura dei tempi, i principi dovrebbero procurare che la vita fosse più felice”; una notazione che mi pare tuttora attuale e che anticipa di un paio di secoli il titolo di un libro di Rita Levi Montalcini4.
Come sempre capita, però, il successo di cui si parlava ha portato con sé alcune conseguenze che, se sono abbastanza presenti ai più attenti tra gli addetti ai lavori, nel nostro caso i medici e qualche filosofo, hanno allo stesso tempo indotto in via generale delle conseguenze e delle attese a volte, e anche sovente, erronee. Anche a non considerare quella che ormai è stabilito essere solo una leggenda metropolitana5 e cioè quanto avrebbe dichiarato di fronte al Congresso nel 1969 il Surgeon General, la massima autorità statunitense in campo sanitario, secondo cui l’umanità avrebbe presto “chiuso il capitolo delle malattie infettive”; resta il fatto che nel 1972 MacFarlane Burnet, premio Nobel per la Medicina, scrisse6: “La previsione più attendibile che si possa fare circa il futuro delle malattie infettive è che non avranno un grande futuro”; e che uno degli infettivologi statunitensi più noti, il prof. Petersdorf, nel 1986 assicurò7 che “è ormai prossimo il millennio in cui i cultori delle malattie infettive si cureranno l’un l’altro”; resta però il fatto, dicevo, che i mezzi di comunicazione di massa hanno indotto alcuni convincimenti: “il nuovo è meglio”; “le pratiche che si adottano in Medicina sono assolutamente efficaci e sicure”; “ogni problema medico viene risolto al meglio utilizzando al caso le più sofisticate tecnologie”; “fare ‘più Medicina’ significa migliorare la vita”; “individuare una malattia prima ancora che essa produca qualche segno è sempre utile”; “i potenziali fattori di rischio vanno trattati al meglio”; “la Medicina può e deve intervenire su situazioni emozionali e su stati d’animo per un loro adeguato controllo” che sono a un tempo erronei nella loro assoluta sicurezza e molto diffusi (Tab. 1)8-18.

È comunque un dato di fatto che, malgrado i suoi incredibili e innegabili successi, negli ultimi anni (o meglio decenni) la insoddisfazione dei malati e in genere del pubblico nei confronti della Medicina ufficiale è andata aumentando esponenzialmente, con il conseguente ricorso a quelle che ormai si indicano come Medicine Complementari o Alternative19, dall’agopuntura all’ayurveda all’omeopatia all’ipnoterapia all’osteopatia e chi più ne ha più ne metta, alcune delle quali sono riconosciute dallo Stato20. I cultori di queste Medicine particolari sono moltissimi; in Italia ad esse si rivolgono ormai quasi 13 milioni di persone9 che diventano 100 milioni in Europa21, cioè grosso modo il 20% della popolazione; nel mondo esiste un Academic Consortium for Integrative Medicine and Health che fa regolari Congressi22.
Tiziano Terzani, un giornalista di viaggio che conosceva bene le Medicine alternative, nel suo ultimo libro23 scritto poco prima di morire, scrive: “Uno degli aspetti più attraenti delle terapie alternative è che il paziente deve partecipare al processo di guarigione, che molto dipende da lui, dalla sua volontà. Questo però vuole anche dire che se qualcosa non funziona, non lo si può imputare alla cura; è lui che non ce l’ha messa tutta. I ciarlatani hanno una perfetta giustificazione per la loro inefficienza”. Ne riparleremo.
Un medico di famiglia canadese riassume di recente24 brevemente la situazione della Medicina occidentale non solo nel suo Paese, ma quasi ovunque: “Esiste un rammarico, che è anche delusione, rabbia, rimpianto, dispiacere da parte del malato; esiste un rammarico, che è anche delusione, rabbia, rimpianto, dispiacere da parte del medico; ed esiste una incapacità di entrambi ad assaporare il lavoro significativo che facciamo”.
Nel tentativo di spiegare questo stato di cose, da un lato si è pensato che il metodo riduzionistico non fosse completamente adeguato ad interpretare in maniera soddisfacente un fenomeno altamente complesso come l’insieme salute/malattia (qualunque cosa si intenda esattamente con questi due termini25); e dall’altro si sono cercati dei metodi per migliorare, in definitiva, il deteriorato rapporto tra medico e paziente. In realtà questi due approcci si integrano a vicenda26 perché il pensare il paziente non come una macchina da riparare ma come una persona con il suo modo di pensare, di vivere, di relazionarsi, di provare emozioni cambia sostanzialmente il modo con cui i due poli della relazione, il medico e il paziente, si connettono. Inoltre, non considerare più la cura soltanto come la correzione di meccanismi fisiopatologici alterati, ma come un tentativo di far qualcosa sull’insieme dei fattori che agiscono a vario livello sulla persona, impone che non si adotti più un intervento settoriale, specialistico, magari isolato, ma che in essa cura intervengano diverse competenze con interferenze informative molteplici. Infine l’ambito in cui si muovono il paziente e il medico non rimane più limitato agli aspetti per così dire “standardizzati” della relazione - l’applicazione di modalità stabilite su sempre più vaste masse di soggetti: tipico esempio le linee guida1 - ma si amplia fino a dover considerare elementi personali, ambientali, variabili, spesso sconosciuti e raggiungibili solo attraverso intuizioni, anche queste ovviamente imperfette. In tutto ciò - che diventa un molto più complicato e difficile insieme, si attuano intricate relazioni tra medico, paziente e ambiente (inteso in senso lato) - da ormai non breve tempo si invoca il ritorno, si potrebbe dire, di quello che in passato era il medico umanista; la figura cioè capace - come invoca in un libro27 di qualche tempo fa, ormai, ma rimasto famoso un famoso paziente, Anatole Broyard, critico letterario preso forse28 come modello da Philip Roth per il protagonista Coleman Sick del suo “La macchia umana”a - capace, dicevo, di divenire quasi un metamedico; di trattare ovviamente il corpo, ma di sollevare con la sua sensibilità lo spirito del malato; di capire veramente, anche per un solo ma lunghissimo attimo, cosa il malato prova, sente, accoglie dentro di sé (quello che un mio piccolo paziente chiamava “il baco”); di stringere veramente la mano che il malato gli tendeb.
C’è una bellissima novella di Pirandello29 a proposito di una mano che è l’unica cosa che il protagonista può vedere di un malato in una di quelle antiche corsie di ospedale in cui “si aveva la squisita attenzione di impedire che l’uno vedesse la faccia dell’altro”; ma quella mano - “magra, ingiallita sulla bianca coperta, ora sul dorso con la palma in su e le dita un po’ aperte e appena contratte in un atto di totale remissione alla sorte che l’inchiodava; ora serrando il pugno o per un fitto spasimo o per un moto d’ira e di impazienza al quale succedeva un rilassamento mortale di stanchezza”- parla e racconta la sua storia; perché anche le mani - “quella gracile e fina, quasi femminea, col pollice un po’ troppo ripiegato in dentro che spesso s’assoggettava da sé alla pressura della punta dell’indice…la mano d’un sarto…”- raccontano, a chi le sa ascoltare, le storie dei malati; come fanno tante altre parti del corpo e tanti atteggiamenti e tante parole, anche quelle non dette e queste forse più delle altre.
Mi pongo ora due domande difficili: quei malati che si rivolgono, come abbiamo visto sopra, alle Medicine alternative, non stanno forse cercando - per meglio dire - un medico alternativo? E, ancora: si può essere veramente un buon medico - come quello invocato da Broyard - se non si è mai stati veramente anche dalla parte del malato, cioè - per dirla chiaramente - se non si è mai stati malati?c Gianni Bonadonna, un grande medico che incontrai più volte tanti anni fa per la malattia di mia moglie, in uno dei suoi libri30 invocava l’introduzione nel curriculum di studi medici dell’“esame di umanità” e scriveva: “Quello che mi infastidiva era quel modo di superiorità che hanno molti professori universitari di fronte a un malato privo di ogni difesa” e ricordava il grido di fra Cristoforo “verrà un giorno!!”: “come il nobile di fronte al povero frate, nemmeno il luminare si aspettava quel carico d’ira… e anch’io pronunciai mentalmente il manzoniano “Verrà un giorno””. Ma Bonadonna- come Sandro Bartoccioni, cardiochirurgo, come Francesco Sartori, chirurgo toracico (i tre descrissero ormai molti anni fa la loro condizione di malati e il loro rapporto coi medici in un libro31 che andrebbe letto e capito molto di più di quanto non lo sia stato) - visse anche da malato.
Però è il momento in cui il medico si trasforma in malato che coglie l’attimo fondamentale; è quello che fa Solgenitsin in “Divisione cancro”32: la dottoressa Ludmilla Afans’evna Doncòva è la direttrice del reparto raggi di un ospedale dell’Asia centrale e ad un certo punto si sottopone essa stessa a degli esami radiologici. “Nel prendere il primo bicchiere di bario dall’infermiera ne lasciò cadere un poco; la mano che tante volte, guantata di caucciù, aveva palpato ventri in quella stessa stanza, ora tremava…Non volle neppure vedere la grande radiografia principale ottenuta a fine giornata. Perduti gli abituali movimenti virili stava afflosciata su una sedia e aspettava le parole conclusive di Orescenkov…. Parole, decisioni… Non la diagnosi… «Dunque, spettabile collega- incominciò Orescenkov con tono faceto - le opinioni delle celebrità sono divise» e intanto la guardava da sotto in su e vedeva il suo smarrimento ….Quante volte, con quel bolo da inghiottire, i malati avevano aspettato da lei una decisione e questa decisione era sempre basata sulla ragione.... «Se non ci crede, prenda la radiografia e giudichi da sé» «No, no» si ritrasse la Doncova «Non voglio». Il malato, in questo caso, la malata, abbandona il suo ruolo di medico e assume quello di paziente, rimettendosi a quello dei colleghi; ormai è in una macchina difficile da fermare.
Allo stesso modo, anche per ogni malato c’è un momento in cui si lascia “la terra dei sani” e si entra in quella della malattia; lo dice molto bene Susan Sontag33, ci torneremo alla fine, ma anche Tolstoj all’inizio del famosissimo racconto “La morte di Ivan Il’ic”34: “Tutti godevano di buona salute. Non si poteva certo chiamare malattia quello strano sapore che Ivan Il’ic sentiva di tanto in tanto in bocca o quel fastidio alla parte sinistra del ventre…”. E si va dal medico. “Egli ci andò. Tutto fu come si aspettava, come sempre avviene, attesa in anticamera, il tono di importanza dottorale. Le domande che richiedevano risposte predeterminate e inutili e quell’aria solenne…Per Ivan Il’ic una sola cosa era importante, sapere se la sua situazione era grave oppure no. Ma il dottore ignorava quella richiesta inopportuna…. Non era in gioco la vita di Ivan Il’ic, ma la disputa” tra due diagnosi.
Negli ultimi decenni la Medicina, quella stessa che ha cercato di divenire una scienza adottandone sempre più i metodi nella EBM, si è più volte posta le domande che ho ricordato sopra, trovando anche alcune risposte. Di recente35 la American Association of Medical Colleges ha pubblicato un rapporto sul “Ruolo fondamentale delle arti e delle ‘humanities’ nella educazione medica”, in cui vengono riassunte svariate esperienze degli ultimi 30/40 anni e in cui si affermano quegli elementi che si ritengono ormai essenziali nella formazione dei medici nel XXI secolo. Si premette che i primi venti anni del secolo hanno visto una profonda modificazione del mondo della salute, con le sempre crescenti divaricazioni sociali, i marcati disordini pubblici che arrivano persino in ambito ospedaliero, un mai prima così marcato numero di suicidi e burn-out fra i medici, crisi sanitarie sempre più gravi nel campo - tra gli altri - delle epidemie da oppiacei e nelle pandemie da agenti infettivi. Certamente alcune di tali emergenze sono oggi più marcate negli States, ma l’esperienza insegna che - giusto o sbagliato che ciò sia - l’Europa importa molto di quello (di solito il meno buono) che inizia a ovest, al di là dell’Oceano. Tutto ciò implica, continua il rapporto, che i medici oggi e nel prossimo futuro devono e dovranno rispondere alle nuove sfide che non sono solo mediche ma sociali. Per questo si impone che essi sviluppino, oltre ovviamente a conoscenze scientifiche specifiche, una capacità di intelligenza emotiva, di pensiero critico e di comprensione dei contesti sociali in cui operano. A tal fine persino l’abituale pragmatismo americano pensa36 finalmente che sia essenziale che nella Medicina si integri un modo di pensare e di valutare le diverse situazioni di tipo genericamente indicato come umanistico e artistico.
Nella tradizionale querelle se la Medicina sia alla base una scienza - come si è venuta sempre più configurando specie in ambito anglosassone e, di riflesso, da noi - o un’arte, come la si è pensata, almeno per alcuni aspetti, più o meno coscientemente a lungo nei Paesi latini, si inserisce molto bene un pensiero del filosofo Hans-Georg Gadamer37, 38: “Quelle caratteristiche che in passato rendevano il medico di casa un amico di famiglia rimandano ad aspetti dell’attività medica di cui oggi avvertiamo dolorosamente la mancanza. Ma ancora oggi la forza di persuasione del medico, come la fiducia e la collaborazione del paziente, rappresentano un essenziale fattore terapeutico che appartiene a una dimensione totalmente diversa rispetto a quella in cui si collocano l’azione fisico-chimica dei farmaci o l’intervento chirurgico”. Si potrebbe semplicemente tradurre ricorrendo a quel nocciolo di irrazionalità, o meglio di oltre-razionalità39 o, ancor più, a quella nota di intuizione bergsoniana o di “pensiero rapido”39 che c’è nel “mestiere di medico”; o anche ricordando e sottolineando che in campo biomedico ciò significa26 che l’uomo non può essere “ridotto” solo a un insieme di molecole; e che di conseguenza le malattie non sono solo l’espressione di qualcosa che non funziona a livello biochimico. Pensare così e operare di conseguenza - sulla base del pensiero cartesiano - ha portato a concentrarsi sui meccanismi fisiopatologici delle malattie, sulla biologia molecolare, sull’applicazione di tecniche diagnostiche e sul controllo dei sintomi, tutte cose utilissime e senza le quali non sarebbe nata la Medicina come è oggi. Sul piano terapeutico, i singoli organi sono stati presi in carico da un numero crescente di specialisti, ognuno dei quali concentra l’interesse su parti del corpo sempre più piccole. In questo modo però i saperi si parcellizzano e conseguentemente i processi di cura si frammentano in una miriade di atti e di procedure a cui è sempre più difficile dare un senso. E si giunge ancora una volta al vero problema: da un lato il medico deve mettere in campo la propria competenza per formulare una diagnosi, indicare una prognosi, proporre le possibili scelte terapeutiche ed essere quindi fondamentalmente cartesiano, idee chiare e distinte, scienza; dall’altro deve anche acquisire specifiche competenze sul piano della comunicazione e della relazione in modo da prendere in considerazione anche l’attitudine al rischio, i valori, le paure, le aspettative e le circostanze sociali del paziente e delle persone a lui vicine; deve cioè porsi anche, per non limitarsi al to cure ma arrivare al to care, mettersi per quanto possibile nei panni del malato. Considerare che il corpo non è solo organismo (Leib)d, ma vita (Leben) e forse anche, per essere-nel-mondo, anche relazione e quindi amore (Liebe).
Va o andrebbe anche comunicato (e non è certo semplice nel mondo di oggi) - magari non dal medico, ma come un’aura che si diffonde, come quella che ha portato agli eccessi di aspettative alla quale ho accennato - che una certa parte di ciò che riguarda le malattie e la loro cura resta tuttora ignoto. A tale riguardo mi pare opportuno ricordare una novella di Italo Svevo40, certo non recentissima, nella quale il dottor Paoli proprio nel momento in cui la febbre è passata al protagonista Roberto e tutti ne sono contenti, sente la impellente necessità di dire alla moglie che ”in Medicina ci sono tutte le prospettive e il futuro è sempre incerto”; e non è, questo, il segno di una resa41, ma la manifestazione tutta popperiana sui limiti che l’azione e la conoscenza umane devono sempre scontare, ma che - dopo Svevo - abbiamo sovente dimenticato. La gente, infatti, è stata portata a credere, come si è detto sopra, che la Medicina ormai non abbia limiti e che vi sia sempre una soluzione a tutti i problemi. L’assenza di risposte o la mancata guarigione sono considerate quindi l’effetto dell’incompetenza del medico e innescano rivendicazioni di natura medico-legale o anche violenta, soprattutto quando tra il medico e il paziente non si è instaurato un rapporto schietto di reciproca fiducia (“farò al meglio tutto quello che posso, ma non posso tutto sempre”). Antonio Tabucchi42 in un romanzo surreale, quasi un sogno, racconta la domanda di un padre, morto per una serie di circostanze che hanno visto protagonisti dei medici, alcuni “davvero bravi”, altri un po’ meno; tra questi ultimi uno che con un sondino gli perfora l’esofago e il padre che appare al figlio vuol sapere come questi ha reagito con quel medico. Ecco la risposta: “Senti, padre, non so se ho fatto bene forse avrei fatto meglio a comportarmi in un altro modo, se lo avessi preso a schiaffi, quel tipo, sarebbe stata una soluzione più coraggiosa, ma non l’ho fatto, è per questo che ho questo senso di colpa, invece di prenderlo per il bavero ho scritto un raccontino sulla conversazione che avevamo avuta e lui mi ha denunciato…ma preferirei aver fatto in un altro modo, preferirei avergli dato un cazzotto, sarebbe stata una azione onorevole e drastica, come si faceva una volta…”. Come si vede, gli scrittori non la perdonano facilmente ai medici.
Molto di quanto detto finora è alla base di un movimento di opinione (la “Slow Medicine”) che, nato in Italia43, ha avuto ampio risalto anche nel mondo medico anglosassone44 col progetto “Choosing Wisely” [“Scegliere saggiamente”] che si è affiancato, ampliandolo ad altre componenti del sistema salute/malattia, ad un altro progetto nato quasi contemporaneamente, la “Narrative Medicine”45. Se volessimo in due parole indicare le caratteristiche fondamentali dei due approcci, potremmo dire che la “Slow Medicine” implica un vero cambiamento di paradigma, secondo la teoria di Thomas Kuhn46, nella concezione della Medicina; questa deve aver tempo per ascoltare e capire, per individualizzare la terapia, per condividere le decisioni da prendere in vista di quel che viene definito un atteggiamento positivo per il malato (ma anche per il medico). La “Narrative Medicine” cerca di migliorare non solo il rapporto medico/paziente, ma anche la relazione del medico con sé stesso, con i colleghi e con la società; e ciò mediante una implementazione della figura del medico che tenga conto, anche e soprattutto nella sua formazione, dei vari elementi delle “humanities” e in particolare della letteratura. A riportarne la formalizzazione che ne dette dieci anni fa la Consensus Conference promossa dall’ISS47, 48, la “Narrative Medicine” è una “metodologia di interesse medico assistenziale basata su specifiche competenze comunicative” dal momento che “la narrazione è strumento fondamentale per acquisire, comprendere e integrare i diversi punti di vista di quanti intervengono nella malattia e nel processo di cura”47.
Naturalmente, a me sembra che il medico-letterato non sia - come pure scrive Spinsanti49 - una “figura anomala”; basta pensare a Cechov, a Conan Doyle (che medico lo era, e laureato a Edimburgo con Joseph Bell, grande chirurgo e medico legale) a Bulgakov, a Khaled Hosseini, a Somerset Maugham, o addirittura a Schiller e a Keats (che non arrivò mai alla licenza medica ma solo a quella di speziale) o a Michael Crichton che si è laureato a Harvard (ma anche lui senza pervenire poi alla abilitazione, per così dire, visto il suo successo letterario e televisivo); e ancora Axel Munthe, Celine con la sua tesi su Semmelweiss e la sua celebre frase50: “Nelle agonie io resto là, fino all’ultimo. Gli altri se la squagliano, prendono un’aria imbarazzata. Io, io resto, sto di picchetto, io li aiuto. E in questi momenti si è utili, quando se no. È per morire che si ha bisogno di qualcuno” (sovente, se non spesso, il medico scompare quando si avvicina la morte: lo ricorda Proust quando descrive51 la rapida (s)comparsa del professor Dieulafoy a letto di morte della nonna: “A un letto di morte, era lui il gran signore, non il duca di Guermantes. Dopo aver guardato la nonna senza stancarla, e con un eccesso di riserbo che era un atto di omaggio verso il medico curante, rivolse poche, sommesse parole a mio padre, si inchinò rispettosamente davanti a mia madre, e notai che mio padre dovette trattenersi per non dirle: ‘Il professor Dieulafoy’. Ma già questi aveva voltato la testa, e se n’era andato nel più incantevole dei modi dopo aver accettato con semplicità l’onorario per la visita”); o tra i nostri Carlo Levi (“Cristo si è fermato a Eboli”); Giulio Bedeschi (“Centomila gavette di ghiaccio”); Mario Tobino (“Le libere donne di Magliano”); Bruno Tacconi, Giuseppe Bonaviri, Andrea Vitali e tutti quelli che ho certamente dimenticato. Per tutti costoro, e per tutti i qui non menzionati medici che furono e sono scrittori (come pure per gli scrittori che furono e sono medici: Achille Mario Dogliotti che fu chirurgo esimio, fondò nel 1951 come si sa una Associazione di medici scrittori) vale l’osservazione di Cechov, quando scrive all’amico Suvorin52: “Voi mi consigliate di non inseguire due lepri in una volta e di non pensare a occuparmi di Medicina; non so perché non si possano inseguire due lepri, anche nel senso letterale della frase… La Medicina è la mia legittima moglie e la letteratura la mia amante; quando la prima mi secca, vado a dormire dall’altra”. Ci sono scrittori che sembrano proprio a loro agio nella Medicina; uno di questo è certamente Dickens che descrive addirittura per la prima volta quella che ancora oggi è nota come la “Pickwick syndrome”53, 54 e infarcisce i suoi racconti delle più varie malattie74, 52, dall’asma del maggiore Bagstock all’epilessia del fratellastro di Oliver Twist, alla -naturalmente - tubercolosi di sua sorella e del figlio di questa, ma che descrive anche nel suo “La vita e le avventure di Nicolas Nickelby” del 1838, fino persino a qualcosa che è riportabile al deficit di attenzione e iperattività (ADHD) o alla sindrome di Gilles de la Tourette che non era stata ancora descritta, ma di cui soffre il signor Panks del racconto “La piccola Dorrit” del 1855.
Ma non è di questi che qui ci si occupa, ma di come le loro opere entrano nella Medicina e, forse, aiutano a ottenere medici migliori. Perché il problema è: in che cosa la letteratura può aiutare un medico a entrare nel suo vissuto e nel vissuto del malato? Le arti insegnano metodi creativi di espressione; la comprensione di prospettive diverse; la capacità di apprendere cognizioni e emozioni per mezzo delle esperienze umane; la capacità di plasmare e condividere all’esterno ciò che si percepisce per mezzo della creazione artistica. Le “humanities” insegnano come la lettura sia un cardine essenziale; insegnano inoltre a valutare e apprezzare i vari contesti nel tempo e nello spazio; una analisi qualitativa delle strutture sociali e delle loro relazioni; l’importanza di una visione prospettica, di una comprensione empatica, di una analisi di come un argomento si struttura…
Un aspetto può essere nel fatto che la letteratura offre casi per meglio comprendere il ruolo del medico quando è in gioco la qualità della vita; quando bisogna prendere decisioni etiche; quando bisogna migliorare il rapporto col malato, quando bisogna capire il punto di vista del malato sulla malattia e anche quel che il malato pensa del medico. La letteratura può servire a migliorare il linguaggio, a scegliere le parole, a usare le giuste metafore e a capire quelle usate dal malato. Ma la letteratura può anche aiutare a capire meglio il racconto che della sua malattia fa il malato. La letteratura può migliorare il pensiero rapido, la intuizione, il ragionamento deduttivo, la capacità di cogliere l’attimo utile nelle parole del malato; tutto questo, naturalmente insieme agli aspetti scientifici, può offrire mezzi adeguati ad affrontare meglio situazioni difficili e può aiutare a comprendere meglio la posizione del malato nel contesto ambientale ed umano.
Capire il malato; di recente ho riletto un classico del famoso british humour, il “Tre uomini in barca”55 di Jerome Klapka Jerome. La storiella è nota: tre amici di una certa età parlano, come capita, delle loro malattie: uno ha le vertigini, l’altro ha il fegato che non va, il terzo zoppica per via di una artrosi e così via. Leggono i foglietti delle medicine che assumono (oggi noti come bugiardini e anche questo termine è tutto da interpretare, come acutamente notava il linguista Serianni56) e uno di loro si accorge improvvisamente di avere tutti i sintomi che vi sono elencati; terrorizzato, passa in biblioteca e sfoglia un libro di Medicina, una sorta di dizionario in ordine alfabetico (non c’era internet che funziona molto meglio o peggio a seconda dei punti di vista57), convincendosi di avere dalla anemia fino al morbo di Bright al colera alla difterite e così via, escludendo solo il ginocchio della lavandaia. Corre al colmo dell’angoscia dal medico (“un medico vecchio amico che quando credo di essere malato mi sente il polso, mi osserva la lingua, chiacchiera del tempo, il tutto senza essere pagato…”) questi lo visita come si faceva al tempo di Jerome Klapka Jerome e, come da prassi, scrive una ricetta. Ecco il seguito: “Non aprii la ricetta, presi per strada il primo farmacista e gliela consegnai. L’uomo la lesse, poi me la restituì. Disse di non disporre di quella roba. Gli chiesi: ‘Lei è un farmacista?’ rispose: ‘Sono un farmacista. Se fossi una catena di negozi potrei esserle utile; l’essere solo un farmacista mi è d’ostacolo’. Lessi la ricetta. Elencava: 1 bistecca da una libbra con una pinta di birra amara ogni 8 ore. 1 passeggiata di dieci miglia ogni mattina. A letto alle 11 in punto ogni sera. E non riempirti la testa di cose che non capisci”. Forse bisognerebbe anche oggi essere e divenire vecchi amici dei nostri pazienti, conoscerli bene e magari evitare anche di sostituire la bistecca e la pinta di birra con qualche integratoree.
Tornando seri e provando a esserlo, faccio qualche esempio. Il primo incontro del medico col malato è un momento fondamentale. La pittura ce ne dà qualche esempio relativo al passato: il famoso dipinto di Luca Fildes che era in molti studi medici ancora ai miei tempi, ed è quasi copiato qualche anno dopo da un giovane Picasso, evidenzia i dubbi, l’impotenza e l’attesa del medico di una volta (che abbiamo anche ora un poco rimpianto). In letteratura potrei riandare alla famosa descrizione che Giovanni Verga58 fa della scoperta della “roba” che cresce nella pancia di mastro-don Gesualdo Motta, “una pancia che le gambe non la reggevano più: ‘Don Gesualdo, siete un uomo… non siete più un ragazzo, eh? .... Bene, qui ci vuole un consulto. Non avete mica una spina di fico d’India nel ventre! È un affare serio, capite! ...Chiamate i migliori medici forestieri, don Vincenzo Capra, il dottor Muscio di Caltagirone, chi volete…’. … Lo lasciò finire, stando zitto... Infine volle sapere: ‘Il consulto? Che mi fa il consulto?’ …. ‘Va bene, facciamo il consulto’ …
...c’erano al mondo dei buoni medici che lo avrebbero fatto guarire, pagandoli bene... Voleva che i medici forestieri gli trovassero la miglior cera, contava le ore… si tirò svelto a sedere sul letto... Salutò quella brava gente con un bel sorriso… essi invece gli badarono appena; erano tutt’orecchi per il dottor Margheritino che narrava la storia della malattia con gran prosopopea…volgevano qualche occhiata distratta sull’ammalato…. ‘Parlate, signori miei! -esclamò allora il pover’uomo pallido come un morto- Sono io il malato, infine!!...’”.
Vale invece la pena di arrivare all’oggi, con un romanzo (“L’ultima estate”59) che vinse il Premio Campiello opera prima nel 2009 ed è scritto da una signora, Cesarina Vighy, più o meno della mia età e che aveva allora 76 anni. È un romanzo autobiografico di chi si scopre una SLA: “…Un amico medico mi procura la presentazione per un luminare del passato prossimo (e cinque!). Vado e trovo una persona che mi piace, capelli e baffetti bianchi, modi pacati e amabili… lui mi aggiorna en passant dell’esistenza di malattie rare ma non troppo, che sono degenerative (cioè che vanno sempre peggio) e croniche (cioè che non guariscono mai) ... Mi prega cortesemente di rifare le TAC e le TIC presso il suo ospedale, di cui si fida molto …. ma con calma, non c’è alcuna fretta…mi stringe la mano tra le sue come un vecchio amico, quasi uno zio…Mi ripresento da lui dopo pochi giorni. Secondo atto. Al posto dell’elegante zio trovo un vecchietto che nasconde male la sua irritazione nel vedermi piombare lì… esamina le lastre (di cui evidentemente già sa il contenuto), mormora un riferimento vago a quelle tali malattie. E mi liquida con una di quelle frasi che si pronunciano al cimitero quando non si sa più cosa dire: ‘Signora, ognuno ha le sue disgrazie’. Un latinista cinico.
Ormai voglio, vorrei desidererei la verità. Un altro luminare (e sei!) ma carico anche lui di alloro accademico. Per fortuna, ha un carattere un po’ più allegro dell’altro e si diverte a far domandine a bruciapelo per saggiare l’animus del paziente: ‘Ha paura del cancro?’ ti chiede lieto... ‘No’ rispondo subito. ‘Ha paura dell’Alzheimer?’ ‘Sì!’ .…. Beccata. Ma almeno lui non si vergogna a visitare come si faceva una volta. Poi l’illuminazione. Il professore illustrissimo si fa uscire le parole magiche: ‘Sclerosi laterale primaria’ ... Quel ‘primaria’ poi non me l’ha saputa spiegare nessuno. Lasciamo perdere le finezze. Il luminare guarda poi le carte e quando scopre il risultato negativo per la SLA qualifica il precedente dottore… con un sonoro ‘somaro’ e guarda me scuotendo la testa… Con l’audacia degli offesi cerco di sapere il perché e il percome del mio stato. Lui allarga le braccia e, rasserenandosi, mi risponde: ‘Lei deve mandare una raccomandata con ricevuta di ritorno al Padreterno, che è l’unico a saperlo, girandogli la domanda’. Con l’umiltà dei vinti, chiedo allora cosa devo fare. Regalandomi un largo sorriso incoraggiante, il professore si mette all’opera e con telefonate frenetiche mi combina subito un appuntamento col suo migliore allievo, professore a sua volta … (e sono finalmente sette!!). … A me tocca il baroncino e cercherò di farmelo piacere; il che avviene molto presto, quando, firmando una email, aggiunge: ‘Con amicizia non solo medica’.
Ma dove le imparano queste furbate, in corsi speciali? Dove imparano, mentre ti ripetono che sei perfettamente libero nelle tue scelte, ad avviarti alla fiducia più completa fino a posare volontariamente la tua testa su quello che non ti appare più come un ceppo, ma un comodo cuscino?”. È il racconto, romanzato se si vuole, ma di come un malato, una malata, vive (oggi, non nel 1800) i suoi incontri con i medici che dovrebbero occuparsene (to care).
Claudio Magris col suo dottor Ongaro che si incontra nei “Microcosmi”60 fa conoscere invece un medico diverso, esistente (morì nel 2003) ma diverso: “La sua pacatezza rassicurante e la sua mite e ferma precisione danno subito un senso di sollievo… lui ascolta, disponibile, senza fretta: qualcosa nel suo viso e nel suo tratto, ricorda la linda dirittura e la malinconica bontà di Freud, corrette da una sorniona ironia… si addentra nelle spirali dell’angoscia con la paziente leggerezza di un gatto…. E spesso dopo qualche tempo le persone braccate dai demoni ritornano capaci di vivere”, ma Ongaro appartiene a una categoria un po’ particolare di medici, è uno psichiatra: ha pubblicato dei libri alla chetichella, presso piccole case editrici impossibilitate a entrare nella circolazione culturale, ricevendo stima e apprezzamenti ma non la notorietà; è insomma, un medico che come scrittore è rimasto a metà.
Un altro aspetto dell’incontro medico/malato è offerto da Ludovico Guarnieri61, che si definisce “scrittore per forza” e “malato esperto”: “I medici si potrebbero valutare qualitativamente con un voto… che sale in proporzione alla loro bravura, ma anche e soprattutto all’aiuto psicologico e umano che riescono a dare al malato. Spesso i medici con i voti più bassi sono assolutamente sicuri che la Medicina sia una scienza esatta, un dogma di cui si sentono i depositari… come se giocassero una scommessa con la vita e con la morte si sostituiscono a Dio e si permettono di dire: ‘lei vivrà un anno… sei mesi… una settimana…’. Il paziente si trova davanti a un bivio: o si abbatte e sprofonda nella classica rassegnazione e depressione del morituro; oppure si arrabbia e giura di far perdere la scommessa al medico campando ben più a lungo di quanto sentenziato...” il che mi fa venire in mente Giovannino Guareschi62 quando dal campo di concentramento scriveva: “Non muoio neanche se mi ammazzano”.
E l’ospedale? Certo le cose sono molto migliorate dal tempo del lazzaretto descritto da Manzoni63: “Si immagini il lettore il recinto del lazzaretto, popolato di sedicimila appestati; quello spazio tutto ingombro, dove di capanne e baracche, dove di carri, dove di gente; quelle due interminabili fughe di portici piene, gremite di languenti e di cadaveri confusi, sopra sacconi o sulla paglia e su tutto quel quasi immenso covile, un brulichio come un ondeggiamento, un andar e venire, un fermarsi, un correre, un chinarsi un alzarsi…”. Per l’oggi, prendiamo sempre Cesarina Vighy59 che ce ne dà una descrizione dal punto di vista del malato e dei suoi parenti: “L’ospedale di Venezia è bellissimo per gli amanti delle cose d’arte; per i malati indigenti, un po’ meno. I saloni oscuri dalle volte altissime, così suggestivi, non sono l’ideale per chi è costretto a giacervi in un affollata e sgradevole promiscuità. Il paravento intorno al letto non basta ad arginare la paura che da quel poco misterioso segnale si propaga nelle corsie… A mio padre, almeno, erano risparmiate queste umiliazioni, ma forse nemmeno le avrebbe colte. Stava in un reparto nuovo, sul retro, dove poteva permettersi una stanza solo per noi due. Le finestre affacciavano sulla laguna, proprio dirimpetto al cimitero. A qualche superstizioso quella vista non piaceva; aveva torto, perché quell’isola, esclusivamente dei morti, dedicata a san Michele, unica in tutto il mondo, prometteva una pace elitaria… Mia madre mi aveva detto che papà, con la poca forza che gli rimaneva, con le dita aveva mimato una rivoltella e il gesto di chi se la punta alla tempia; la malinconia e la consapevolezza del proprio degradarsi aveva portato quell’uomo così mite e così inimmaginabile con un’arma in mano, a quello scatto violento….”; una situazione molto simile a quella che ho vissuto quando un mio carissimo amico dai tempi del liceo e divenuto poi il mio dentista per quarant’anni, mi fece cenno di avvicinarmi al suo letto e, sapendo da sempre che mi occupo un po’ di farmacologia, mi sussurrò all’orecchio: “Non c’è una iniezione…?”.
Questo grande problema è affrontato da Pirandello64: “Avresti dovuto morire. Non essendo morto…” “Ma sarei morto -riprese il Corsi… additando fieramente il dottor Vocalopulo- sarei morto se lui non avesse fatto di tutto per salvarmi!” “Come…io?” - balbettò il Vocalopulo...- “Voi! Sì, per forza! Io non volevo le vostre cure. Per forza avete voluto prodigarmele, ridarmi la vita…. Viene un dottore, codesto nostro dottore. Mi salva. Con quale diritto mi salva? ...” “Un bel modo di ringraziarmi, codesto. Che dovevo fare?” “Ma lasciarmi morire” - proruppe il Corsi… “Ma noi medici, scusate -rispose smarrito il Vocalopulo- noi medici non abbiamo questi diritti: noi medici abbiamo il dovere della nostra professione”. Naturalmente41 il problema che pone Pirandello è molto più complesso di quanto non veda il povero Vocalopulo; è il problema - cui si è già accennato - di una Medicina e di una sociologia (e persino di un’etica sociologica) che si pongono come scienza esatta, che eleggono la funzionalità come loro unico criterio, mentre per il filosofo e scrittore siciliano solo uno sguardo d’insieme può cogliere la complessità della vita, individuare le strategie più efficaci per raggiungere veramente una salute che non è mai una “salute” assoluta.
La Medicina è molto cambiata, lo dicevamo, anche dai tempi di Kafka, ma in fondo il dilemma di base della nostra professione non è cambiato. C’è un suo racconto (“Un medico condotto”65) in cui il dottore del dipinto di Luca Fildes arriva in una povera casa: “Il giovane si solleva senza camicia da sotto i cuscini, mi si attacca al collo, mi sussurra all’orecchio: ‘Dottore, lasciami morire’. Mi guardo intorno, nessuno ha udito… il giovane dal letto non smette di allungar le mani verso di me per ricordarmi la sua preghiera… la miglior cosa sarebbe buttarlo giù dal letto con uno scappellotto…. Scriver ricette è facile, ma intendersi con la gente è difficile”. Anche questo ragazzo vuole, chiede di essere lasciato a morire, come - salvato da Vocalopulo - fa il Corsi pirandelliano. Ma il medico di Kafka è scrupoloso (“faccio il mio dovere fino in fondo…”) ed ecco che appare la ferita. Non sappiamo se la ferita “prima” non c’era o era sfuggita; ma ora c’è (“una ferita grande come il palmo della mano, rosea, tutta sfumata, più scura dove è più profonda, lievemente granulosa, aperta in mezzo come una miniera; così da lontano. E da vicino appare ancora più grave”) e la presenza della malattia dà un senso alla presenza del medico e, incredibilmente, ora la gente intorno, i familiari “sono felici perché mi vedono agire, la sorella lo dice alla madre (il dottore ha scoperto la malattia!!), la madre al padre, il padre ad alcuni visitatori che in punta di piedi… entrano dalla porta aperta. ‘Mi salverai?’ mormora singhiozzando il fanciullo”. È lo stesso fanciullo che poco prima aveva chiesto al medico, quasi imposto, “Lasciami morire”. Ecco: ed è lo stesso Kafka a scriverlo: “Così è la gente del mio paese. Pretende sempre l’impossibile dal medico.... il medico deve saper fare di tutto”.
Commenta da par suo Eugenio Borgna38: “Le luci e le ombre, le antinomie e le contraddizioni, le speranze e la disperazione, le possibilità e le impossibilità, i naufragi fatali e i labili trionfi che contraddistinguono l’essere-medici (l’arte medica. Borgna usa proprio il termine “arte”) riemergono dal discorso elusivo e implacabile, realistico e magico di Franz Kafka. Dal suo discorso scaturisce anche l’insieme vertiginoso delle cose concrete e utopiche che vengono richieste ai medici, ai medici di ogni tempo e di ogni luogo, ieri e oggi”.
Il tempo è passato e mi accorgo che - a parte il fugace e ironico cenno che ho riservato a Proust (sui rapporti del quale con la Medicina nel 2018 è stato addirittura scritto un intero libro66 e ha scritto un bell’articolo Ettore Campailla67) non ho neanche citato Thomas Mann e la sua “Montagna magica”68, versione recente del titolo originale “Zeuberberg” in cui all’incanto69 della prima traduzione si è preferita la magia69 che ricorda quella del celebre Flauto magico (Die Zeuberflote) di mozartiana memoria e su cui notevoli e preziose pagine ha scritto Vito Cagli70, 71 il quale faceva notare come Mann abbia molto indagato sui due aspetti della malattia: da un lato la disease, condizione oggettiva, processo biologico alterato che segue le leggi del mondo fisico; e dall’altro la illness, il rapporto che il paziente stabilisce con il processo morboso e con tutto ciò che vi è connesso: medici, organizzazione sanitaria, ricadute sulla vita abituale diventando allora sickness. Una dicotomia di cui anche qui oggi abbiamo un poco parlato. Ma Cagli nella sua ammirazione che è quasi una venerazione per Mann ne sottolineava più volte la incredibile precisione tecnica nella descrizione della clinica delle malattie, non solo nella tubercolosi, ma anche per il colera (ne “La morte a Venezia”), per la neurosifilide (nel “Doctor Faustus”) e così via, al punto da ricordare che lo stesso Mann in una sua lettera al direttore di una importante rivista medica tedesca71 diceva di essere “un estimatore e un ammiratore della scienza medica”. Ma una analoga ammirazione Cagli la riserva anche alla descrizione che Italo Svevo fa in una sua poco conosciuta novella72 di una crisi coronarica (“Si destò coperto da un sudore freddo:… moriva! Era la morte stessa che era penetrata in lui assieme alla spada velenosa che s’arcuava nel suo braccio e nel suo petto. Egli era tutto dolore e paura”); e ancora alla lunga e “perfetta” (parola di Cagli) descrizione che Gianna Manzini73 ha fatto delle interpretazioni minimizzatrici che per molti anni - specie al tempo del racconto ambientato nel 1925 - hanno ostacolato un pronto riconoscimento dell’infarto del miocardio e che la scrittrice (ma quarant’anni dopo) viceversa coglie in tutte le sue sfumature.
E qui troviamo forse un elemento di riequilibrio nei confronti di quella ironia caustica e scettica che abbiamo visto caratterizzare la Medicina quale appare in molti scrittori (e anche qui non ho fatto neanche cenno ai sarcasmi ben noti di Molière e dello stesso Proust nei confronti dei medici66 - dal dottor Diaforetico al dottor Cottard al dottor de Boulbon al prof. E - e della Medicina): Cagli, ma certamente non solo lui74, ha una sconfinata ammirazione per quegli scrittori che, occupandosi nei loro racconti e nelle loro fantasie di quella cosa così profondamente umana che è la sofferenza e quindi della professione che del lenire la sofferenza ha fatto da secoli il suo statuto, narrano - sia pure con una sottile vena di ironia distaccata ma con amore per il dettaglio e perfezione descrittiva - gli atti medici.
Voglio però terminare, prima di concludere, con una ultima citazione di Tiziano Terzani, forse un po’ lunga ma che mi farà forse da voi perdonare la scelta che ho or ora operato di alcuni brani letterari connessi alla Medicina. Dice, più che “scrive”, Terzani23: “Innanzi tutto dovevo scegliere dove curarmi e in particolare come curarmi... Oggi che tutto è messo in discussione, che tutto quello che è ufficiale è visto con sospetto, che ogni autorità ha perso prestigio e che ognuno si sente in diritto, senza alcun ritegno, di giudicare tutto e tutti, è diventato sempre più di moda dir male della Medicina classica e un gran bene di quelle ‘alternative’… E poi sono stato io a dire e a scrivere che l’uomo occidentale, imboccando l’autostrada della scienza, ha troppo facilmente dimenticato i sentieri della sua vecchia saggezza.. Non avevo cambiato idea, ma quando si trattò della mia sopravvivenza non ebbi un momento di esitazione: dovevo affidarmi a ciò che mi era più familiare, alla scienza, alla ragione occidentale... Era che nel fondo dell’altro non mi fidavo”.
Terzani, come si sa, è morto nel 2004, più o meno nel momento in cui - come si è visto - nascevano i movimenti tesi a integrare nella Medicina scientifica almeno alcune componenti umanistiche. C’è da sperare che nel suo processo di malattia, il malato Terzani abbia incontrato medici che siano stati capaci di distinguere la sua storia di vita dalla classica anamnesi e che abbiano posto attenzione ai significati che tale storia sicuramente offriva loro. Ricordando ancora Susan Sontag33, accanto a quel passaporto per la vita con scadenza variabile che tutti abbiamo ricevuto alla nascita, un medico - un cittadino del mondo della Medicina occidentale - avrà consegnato ad un certo punto a Terzani quel passaporto per la terra di malattia che iniziavano insieme a percorrere e a scoprire. Insieme, speriamo; perché il malato non deve e non può essere considerato un esiliato o un emarginato, ma - se non, certo - un turista, un viaggiatore diverso, un esploratore di quella terra per lui nuova in cui il medico gli può e forse gli deve fare da guida. Nel viaggio attraverso la malattia, il malato cambierà, ma cambierà pure il medico, sia pure in maniera diversa (lo scrivo soprattutto per i giovani colleghi). In questo viaggio, il medico che abbia un buon rapporto con la letteratura, che la legga (l’abbia letta) “da presso”, con quella modalità che Rita Charon75 (l’iniziatrice quasi della Medicina Narrativa) indica come “close reading” (che non è solo “leggere con attenzione”, ma un leggere da vicino, da presso, da dentro), piano piano raccoglie un testo quasi multimediale: parole (l’anamnesi come l’abbiamo imparata); segni corporei (l’esame obbiettivo); numeri (i dati di laboratorio); immagini (TAC, ecografia, RMN..) che poi però va elaborato come narrazione per essere restituito al malato, ai familiari, ai colleghi e anche al medico stesso perché possa servire come una guida esperta e affidabile. Ho detto, con altri48 “anche al medico”, intendendo colui che più da vicino e con costanza accompagna il viaggio del malato nella “terra della malattia” (esistono ancora tali medici? certamente sì); perché anche il medico, malgrado la corazza che la professione, scientificamente intesa, induce, ha - e non può non avere - le sue emozioni76; e queste, se opportunamente canalizzate, possono non essere interferenti con la lucidità dell’operatore, ma sovente hanno un ruolo non secondario nelle decisioni che vanno prese. La Charon75 parla addirittura di “cartella parallela”, dove si raccoglie tutto ciò che possa servire a comprendere meglio il viaggio nella malattia: vi trovano posto l’ammirazione per il coraggio della sofferenza, il senso di impotenza, i ricordi personali che il medico ha76: la gioia, la tristezza, la paura, la colpa, la stanchezza, la frustrazione, a volte persino la felicità. E questo deposito di emozioni, delle quali moltissimo si è perduto e si perde ma che per fortuna si mantiene nei grandi romanzi e nelle brevi novelle della letteratura - viene bene quando - come i colleghi più giovani di me hanno vissuto nei trascorsi anni della pandemia, ma come io ricordo di aver vissuto proprio all’inizio della mia vita di medico per la influenza del 1957 (venivo dai laboratori lucidati della Farmacologia e mi trovai proiettato in una borgata di periferia romana di quegli anni) - si ha (io ebbi) la sensazione di essere perduti in una terra vuota e desertica, senza oasi. La terra in cui il medico ha deciso - chi sa per quali misteriosi motivi - di trascorrere, in compagnia del malato e accanto a lui, la sua vita; una terra però in cui qualche volta, quasi inspiegabilmente, fioriscono rose accanto ai crisantemi.
Prof. Giovanni Ceccarelli, Libero Docente in Pediatria
Per la corrispondenza: giovanni.ceccarelli@alice.it
a. Philip Roth28 ha sempre smentito di essersi riferito a Broyard, ma ciò non cambia sostanzialmente la cosa.
b. Due dipinti (“La malata” di Roger de la Fresnaye e “Valentine malata” di Ferdinand Hodler sono esempi di questi “appelli” che il malato rivolge silenziosamente al medico.
c. Eugene Ionesco scrive (“La cantatrice calva”, atto I, scena I) una frase ovviamente da intendere nell’ambito del suo teatro dell’assurdo: “Un medico coscienzioso deve morire con il malato, se non possono guarire insieme”.
d. Leib in tedesco è il corpo vivente, il corpo vissuto mentre Koerper (o Koerperlaenge) è il corpo fisico, l’organismo.
e. Il mercato degli integratori alimentari in Italia vale oltre 4,5 miliardi di euro; l’Italia è il primo paese in Europa con un fatturato che vale il 26% di quello europeo (Il Sole 24 ore, 2 luglio 2024).
f. Claudio Magris in un articolo divulgativo apparso su “La lettura”, supplemento al “Corriere delle sera” del 12 gen 2016 ricordava come Roberto Finzi, studioso di storia economica e autori di libri “rigorosi e godibili”, avendo richiesto la cartella clinica di sua moglie morta all’ospedale di Bologna ricevette 450 pagine che - afferma Finzi - “dissuadono da ogni lettura”.
BIBLIOGRAFIA
AA.VV. Specchi di carta. Percorsi di lettura in tema di medicina narrativa. A cura di Lippi D. Bologna: Clueb, 2010.
AA.VV. Ambienti narrativi, territori di cura e formazione. A cura di Alastra V. Milano: Franco Angeli, 2016.
AA.VV. Littérature et médicine. Le cas de Proust. Sous la direction de M. Naturel. Paris: Heramann Editeurs, 2018.
AA.VV. Letteratura e medicina. A cura di Di Maro M, Merola V. Pisa: Edizioni ETS, 2023.
Binetti P, De Marinis MG. Il dolore narrato: pagine di letteratura. Roma: Critical Medicine Publishing Ed, 2005.
Cagli V. Malattie come racconti. Roma: Armando Editore, 2004.
Cagli V. La medicina nella “Montagna magica” di Thomas Mann. Roma: Armando Editore, 2019.
Ceccio J. Medicine in Litérature. New York: Longman, 1978.
Di Lieto C. La scrittura e la malattia. Venezia: Marsilio, 2015.
Di Napoli M. La malattia e la morte raccontate dai grandi della letteratura. Roma: Armando Editore, 2019.