Anno Accademico 2024-2025
Vol. 69, n° 1, Gennaio - Marzo 2025
Simposio: La Sclerosi Multipla secondo una prospettiva biopsicosociale
17 dicembre 2024
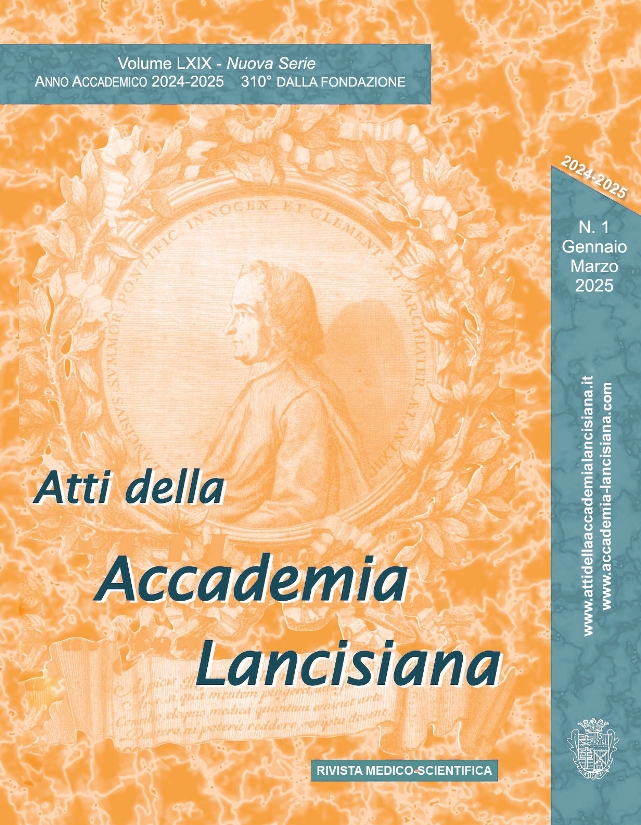
Simposio: La Sclerosi Multipla secondo una prospettiva biopsicosociale
17 dicembre 2024
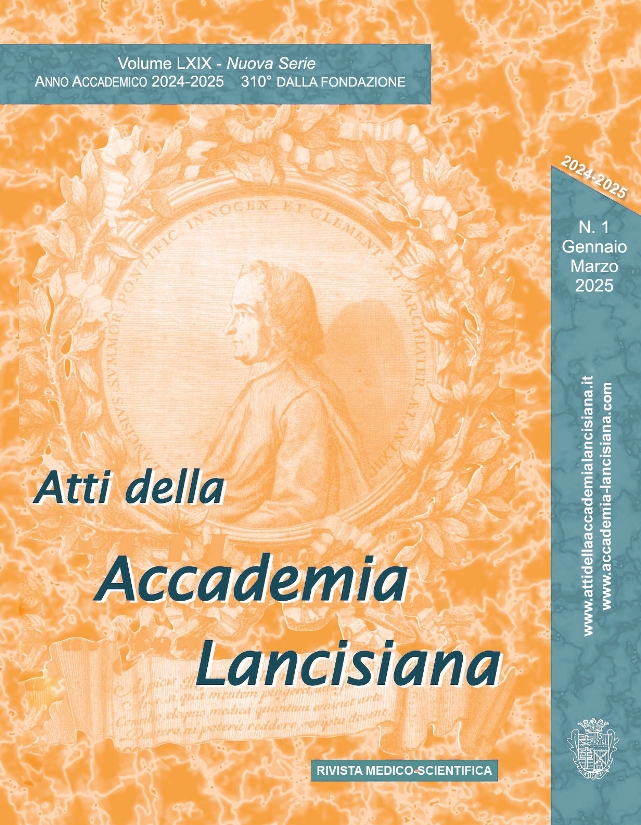
Versione PDF dell'articolo: Download
Nella concezione comune, salute e malattia vengono considerate due condizioni che si escludono reciprocamente: lo stato di salute di una persona implica l’assenza di malattia e lo stato di malattia implica l’assenza di salute. Tale concezione binaria della relazione tra salute e malattia si scontra con l’importante definizione di salute fornita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 1946), secondo cui la salute non corrisponde alla mera assenza di malattia o infermità, bensì a uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. In altri termini, una persona che soffre di una malattia organica può manifestare uno stato di salute, così come l’assenza di stati negativi (e.g., sintomi depressivi) non implica che la persona sia felice o in uno stato di benessere1. La definizione dell’OMS riflette i risultati di diversi contributi empirici che suggeriscono come la relazione tra salute e malattia, benessere e malessere, non sia binaria, bensì bipolare2, 3 o bivariata4-11. Ad esempio, nello studio di Ryff et al.11 è emerso che per sette marcatori biologici, tre neuroendocrini (deidroepiandrosterone, cortisolo, norepinefrina) e quattro cardiovascolari (colesterolo HDL, colesterolo totale/HDL, pressione arteriosa sistolica, circonferenza vita-fianchi), le correlazioni significative osservate con il benessere psicologico (o il malessere) non si accompagnavano a correlazioni significative con il malessere psicologico (o il benessere, rispettivamente) per lo stesso biomarcatore, sostenendo una concezione bivariata. Al contrario, per due marcatori biologici (peso corporeo ed emoglobina glicata), il pattern di correlazioni significative risultava in parallelo, coinvolgendo sia il benessere che il malessere, sostenendo la concezione bipolare. Al di là di rilevanti distinzioni tra la concezione bipolare e quella bivariata, la conclusione è la medesima3: dato che il malessere non implica necessariamente l’assenza di benessere (e viceversa), occorre lavorare sia sulla promozione del benessere che sulla riduzione del malessere, due obiettivi relativamente indipendenti. In questo modo è possibile ampliare il paradigma attraverso il quale si osservano alcuni accadimenti e conseguenze della realtà umana, come quelli relativi ad eventi traumatici o avversi. Approcciamo esclusivamente il malessere della persona o approcciamo anche il suo benessere?
Il 30-70% di persone che hanno affrontato un trauma riferiscono di aver fatto esperienza di cambiamenti positivi come conseguenza dell’evento avverso12. Questo fenomeno è stato definito crescita post-traumatica, che si riferisce ai cambiamenti positivi conseguenti alla lotta o sfida psicologica nei confronti di un evento di vita traumatico13. Le principali manifestazioni di tale crescita rientrano in tre categorie: la percezione di sé, come la percezione di una maggiore forza personale; le relazioni interpersonali, connotate da un senso di maggiore significatività, vicinanza e profondità; la filosofia di vita, in cui si possono riscontrare un maggiore apprezzamento della vita e credenze spirituali più forti13. Secondo una prospettiva esistenziale, la crescita post-traumatica non implica necessariamente un aumento del benessere (e.g., felicità) né una riduzione del disagio; essa riflette il fatto che le persone che la sperimentano vivono una vita più piena, significativa e ricca14. Tuttavia, questa ricchezza di significato può essere accompagnata dal disagio emotivo che spesso deriva da eventi tragici o da perdite14. Gli eventi di vita che rappresentano una minaccia reale o potenziale alla propria sopravvivenza implicano che la persona, probabilmente per la prima volta, veda alcuni fatti dell’esistenza e della condizione umana, tra cui la sua transitorietà. L’apparente paradosso riguarda ciò che potenzialmente ne deriva: l’opportunità di sviluppare nuovi significati. La sofferenza può non corrispondere a mera sofferenza e può condurre verso un’individuazione, che non implica necessariamente felicità.
Diverse teorie sottolineano come un evento avverso possa mettere in discussione o distruggere gli assunti e i presupposti circa sé stessi, il mondo e le altre persone14, 15. Si tratta di credenze fondamentali che includono, ad esempio, le aspettative su come le persone dovrebbero comportarsi, su come gli eventi dovrebbero svilupparsi e sulla nostra capacità di influenzarli16. Questi assunti conferiscono struttura agli eventi, permettono alla persona di pianificare e prevedere, e influiscono su come le persone e gli eventi vengono percepiti e compresi17. L’accadimento traumatico può provocare un evento sismico interno che devasta gli assunti fondamentali della persona: la nuova informazione associata al trauma non può coesistere con le credenze di base. La violazione di queste credenze di base è considerata il principale catalizzatore di una possibile crescita post-traumatica: la nuova realtà imposta dall’evento avverso conduce a una lotta personale che riflette il tentativo di riesaminare le proprie credenze di base14-17. In questo processo subentra un altro aspetto fondamentale: la ruminazione. La ruminazione è stata spesso concettualizzata come un pensiero negativo e auto-centrato sui sintomi ed è stata associata a processi ed esiti psicopatologici, come la depressione e il disturbo da stress post-traumatico18, 19. Tuttavia, il pensiero ruminativo può assumere diverse forme, tra le quali è possibile distinguere la ruminazione intrusiva e quella deliberata20, 21: mentre la prima riflette un insieme di pensieri indesiderati riguardanti un evento, invasioni del proprio mondo cognitivo (e.g., “Non riesco ad allontanare dalla mia mente immagini o pensieri legati all’evento”), la seconda si riferisce a quei pensieri che sono intrapresi volontariamente e possono essere orientati intenzionalmente alla comprensione degli eventi e delle loro implicazioni (e.g., “Mi sono chiesto se fossi in grado di trarre un significato dalla mia esperienza”). Quest’ultima permetterebbe di attribuire un significato a esperienze avverse e di contribuire a riesaminare le proprie credenze di base. Infine, la ruminazione intrusiva e quella deliberata non sono due processi che si escludono reciprocamente. Al contrario, la ruminazione intrusiva è considerata un precursore di quella deliberata, sottolineando come pensieri intrusivi possano far parte dell’elaborazione del trauma per condurre a una successiva e migliore comprensione dell’evento avverso20. Questi modelli teorici della crescita post-traumatica trovano supporto empirico in letteratura. La violazione delle credenze nucleari e la ruminazione deliberata predicevano una maggiore crescita post-traumatica, mentre la violazione delle credenze nucleari e la ruminazione intrusiva predicevano esiti negativi (e.g., disturbo da stress post-traumatico) in sopravvissuti a terremoti22, 23, sfollati a causa di attacchi terroristici24, persone con malattia oncologica25, 26 e in situazioni di perdita di una gravidanza27. La crescita post-traumatica è stata spesso indagata nel contesto delle malattie croniche, quali le malattie oncologiche28, l’HIV29, le malattie cardiovascolari30, la malattia renale cronica31, il dolore cronico32, le malattie reumatiche33-35 e le malattie infiammatorie intestinali36. Pochi studi hanno indagato la crescita post-traumatica nella sclerosi multipla.
Ricevere la diagnosi di sclerosi multipla può rappresentare un evento altamente stressante e avverso, e può essere caratterizzato da un ampio spettro di risposte e reazioni alla malattia e alle sue sequele. Alcuni studi qualitativi hanno identificato diverse dimensioni di tale esperienza, tra le quali la reazione alla diagnosi, che può implicare paura, rabbia e negazione; implicazioni negative, come cambiamenti significativi nella routine quotidiana e nella funzionalità, in cui spesso l’astenia esercita un ruolo cruciale; infine, è stata riscontrata anche una nuova filosofia di vita in termini di, ad esempio, una rivalutazione e maggior apprezzamento della propria vita37, 38. Spesso la diagnosi di sclerosi multipla non può coesistere con il modo in cui la persona si è narrata fino a quel momento: l’evento della diagnosi di sclerosi multipla, oltre alle sue sequele, può mettere in discussione l’impianto identitario della persona, a tal punto da necessitare una ridefinizione e ricostruzione dell’identità38. È proprio da tali cambiamenti dei valori e sistemi di credenze che può derivare una trasformazione positiva. Ad esempio, il concetto di sé come attivo, indipendente, capace di sostenere gli altri e competente nel lavoro, a seguito della diagnosi di sclerosi multipla, viene sostituito da un concetto di sé negativo; la crisi di identità che ne consegue può condurre a un ridimensionamento e revisione delle proprie credenze, conducendo la persona verso una prospettiva più ottimistica, ad apprezzare la vita, ad affrontare l’incertezza sul futuro concentrandosi sul presente e "vivendo il momento", ad atteggiamenti gentili verso le altre persone e a credenze spirituali più forti38. Nonostante questi dati qualitativi suggeriscano che l’esperienza di cambiamenti positivi sia possibile anche conseguentemente alla sclerosi multipla, pochi studi hanno indagato con un approccio quantitativo la crescita post-traumatica in questa popolazione. Ad oggi, i dati quantitativi indicano che la crescita post-traumatica aumenta significativamente nell’arco di 36 mesi (misurate in tre tempi con un intervallo di 18 mesi) in un campione di pazienti a cui è stata diagnosticata la malattia mediamente 12 anni prima39. I livelli medi identificati in questo studio suggeriscono che i pazienti con diagnosi di sclerosi multipla sperimentano una maggiore crescita post-traumatica rispetto ad altre malattie croniche39. Per quanto riguarda i correlati/predittori della crescita post-traumatica, gli studi hanno principalmente indagato le variabili sociodemografiche e cliniche, le strategie di coping, la salute mentale e i sentimenti di vergogna, colpa e demoralizzazione39-42. La disabilità provocata dalla sclerosi multipla (i.e., Expanded Disability Status Scale, EDSS), l’intensità del dolore e l’ansietà/insonnia erano significativamente associate a una maggiore crescita post-traumatica39. Ciò sembra riflettere come una più intensa sofferenza percepita possa condurre nel tempo all’esperienza di una crescita personale39, potenzialmente provocata da una violazione delle credenze di base. Al contrario, sentimenti di vergogna, colpa, demoralizzazione, l’interferenza del dolore e la disfunzione sociale, ovvero le difficoltà significative nell’affrontare i ruoli e le responsabilità quotidiane, influivano negativamente sulla crescita post-traumatica39, 41, 42.
Lo studio della crescita post-traumatica conseguente alla diagnosi di sclerosi multipla è ancora ai suoi albori. Tra tutti gli aspetti che necessiterebbero di un’indagine più approfondita, alcuni sono particolarmente degni di nota. Innanzitutto, occorre indagare la controparte complementare della crescita post-traumatica, ovvero i cambiamenti negativi conseguenti a un evento avverso, definita posttraumatic depreciation16, 43. Infatti, la maggior parte della letteratura si è focalizzata sulla crescita post-traumatica ignorando il costrutto della posttraumatic depreciation, con il rischio di esposizione a bias di positività (i.e., sovrastima di fenomeni di crescita tra i partecipanti). La misurazione congiunta della crescita e della depreciation permetterebbe, quindi, di considerare simultaneamente due possibili esiti che possono essere anche compresenti, poiché i dati suggeriscono che siano due costrutti relativamente indipendenti17, 43, 45, 46. Una seconda area di indagine riguarda la violazione delle credenze nucleari e la ruminazione, due processi particolarmente enfatizzati nei modelli teorici sulla crescita post-traumatica. È rilevante sia da un punto di vista teorico che clinico indagare se questi processi trovano supporto empirico anche nel caso della sclerosi multipla. Infine, la regolazione emotiva, una caratteristica psicologica clinicamente rilevante da un punto di vista trans-diagnostico, non è stata ancora indagata. Le strategie di regolazione emotiva giocano un ruolo importante sia nell’adattamento psicologico alla sclerosi multipla47 che nella crescita post-traumatica. La violazione delle credenze nucleari generate da un trauma elicita uno stato di stress48. Nel tentativo di ricostruire le proprie credenze nucleari, la persona può regolare le proprie emozioni in modo tale da favorire un pensiero costruttivo, permettendole di approcciare deliberatamente a memorie ed emozioni associate all’evento avverso, piuttosto che evitarle49.
In conclusione, una crescita personale conseguente alla diagnosi di sclerosi multipla è possibile e sembra raggiungere livelli più elevati rispetto a quanto avviene in altre malattie croniche. I dati qualitativi suggeriscono come la crescita post-traumatica possa essere un esito del processo di ricostruzione di una nuova identità successivamente alla diagnosi di sclerosi multipla e delle sue sequele. I dati quantitativi mostrano come alcune caratteristiche demografiche, cliniche e psicologiche possano predire la crescita post-traumatica. Questi dati dovrebbero incentivare ulteriori studi al fine di comprendere quali siano i principali fattori e itinerari che conducono alla crescita post-traumatica e/o a una depreciation post-traumatica. Tra le implicazioni cliniche di questi studi si annovera la possibilità di comprendere quali persone possano rimanere bloccate nel processo di elaborazione della sclerosi multipla e delle sue conseguenze e, al contrario, quali risorse permettono ad altre persone un migliore processo di elaborazione.
Prof. Francesco De Vincenzo, Psicologo e Psicoterapeuta, Docente presso Università Europea di Roma
Per la corrispondenza: francesco.devincenzo@unier.it
BIBLIOGRAFIA