Anno Accademico 2024-2025
Vol. 69, n° 1, Gennaio - Marzo 2025
Simposio: La Sclerosi Multipla secondo una prospettiva biopsicosociale
17 dicembre 2024
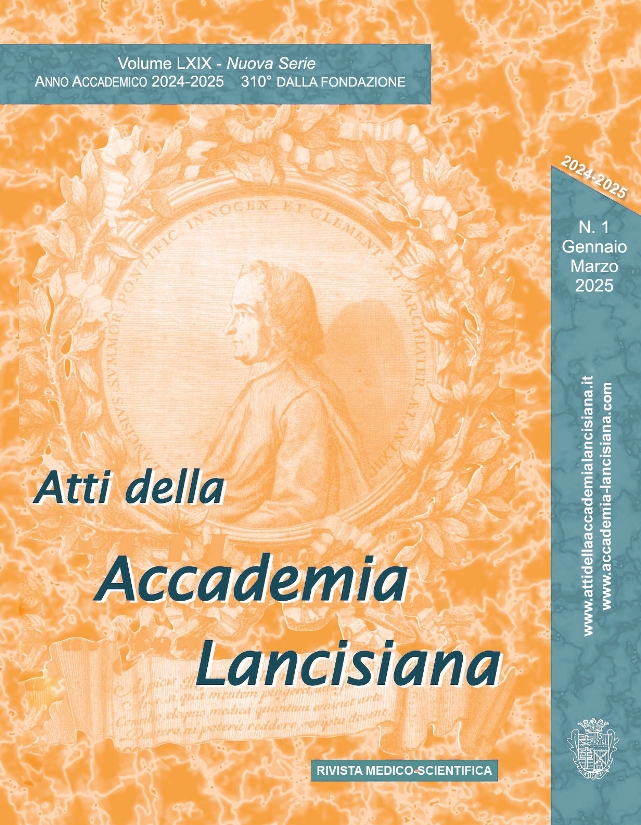
Simposio: La Sclerosi Multipla secondo una prospettiva biopsicosociale
17 dicembre 2024
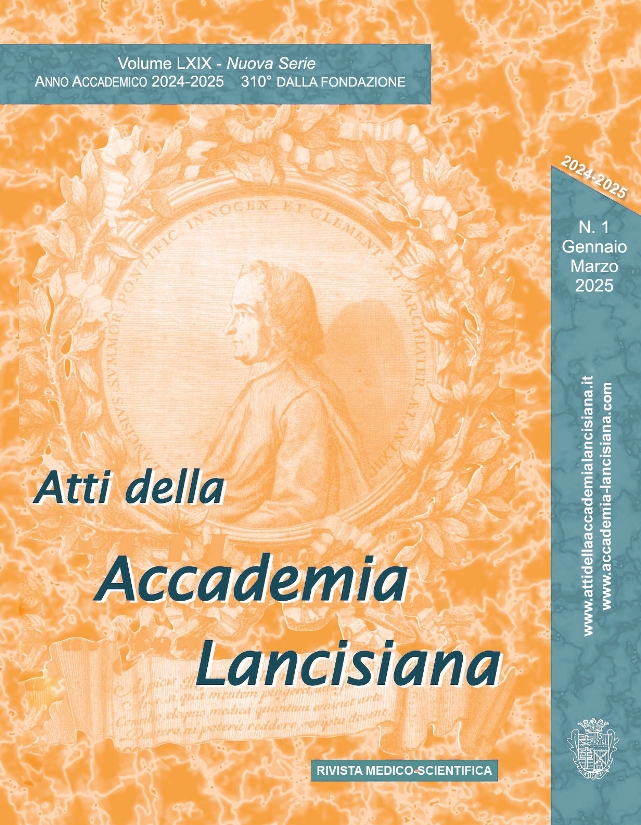
Versione PDF dell'articolo: Download
Il modello della crescita post-traumatica1 propone che gli eventi traumatici violino le credenze nucleari di una persona, ovvero quelle convinzioni di base che strutturano la comprensione del mondo e guidano la pianificazione e l'interpretazione degli eventi2. Questa violazione genera stress e innesca un processo di revisione cognitiva volto a integrare nuove informazioni associate al trauma. Tale processo è stato empiricamente associato alla crescita post-traumatica3, 4 ed è considerato il catalizzatore principale di una successiva crescita5. Un elemento chiave del modello è la ruminazione, che può essere di due tipi: intrusiva, caratterizzata da pensieri involontari e disturbanti, e deliberata, costituita da riflessioni controllate e volontarie che cercano di dare senso all’esperienza6. La ruminazione deliberata, in particolare, è stata associata ripetutamente ad elevati livelli di crescita post-traumatica7.
Un ulteriore aspetto centrale nel processo di crescita è la regolazione emotiva, che supporta l’elaborazione costruttiva delle emozioni e dei ricordi legati al trauma, piuttosto che il loro evitamento. La rivalutazione cognitiva, la strategia che modifica l'interpretazione di un evento o stimolo per alterare la risposta emotiva, è stata associata alla crescita post-traumatica in diversi studi8-10. La regolazione emotiva trova le sue radici nella mentalizzazione, definita come il processo di interpretazione delle azioni proprie e altrui sulla base di stati mentali intenzionali, come desideri, credenze ed emozioni11. La mentalizzazione è cruciale per l'organizzazione del Sé e la modulazione delle emozioni, poiché consente una riflessione consapevole sugli stati mentali12. Su queste basi, è stato sviluppato il concetto di affettività mentalizzata (mentalized affectivity), che si riferisce alla capacità di attribuire significato alle emozioni attraverso la riflessione sulla propria esperienza emotiva13. Questo costrutto aiuta a gestire gli accadimenti, favorisce l’adattamento e promuove una visione più positiva della vita14.
Nella sclerosi multipla (SM), studi recenti hanno analizzato la crescita post-traumatica considerando predittori sociodemografici, clinici e psicologici. Ad esempio, uno studio15 ha evidenziato che, in un periodo di 36 mesi, dimensioni come un maggiore apprezzamento della vita mostrano un incremento significativo, sebbene i cambiamenti nella spiritualità restino invariati. Tra i predittori più rilevanti figurano il sesso femminile, il livello di scolarità, l’intensità del dolore e le strategie di coping, come la rivalutazione positiva, il supporto sociale e la religione. Tuttavia, pochi studi hanno esplorato il costrutto della “posttraumatic depreciation” (PTD), ovvero i cambiamenti negativi conseguenti al trauma, spesso trascurati per il rischio di bias di positività16-18. È fondamentale indagare la coesistenza di crescita e depreciation, considerati costrutti indipendenti ma complementari19, 20. Inoltre, la violazione delle credenze nucleari, la ruminazione e l’affettività mentalizzata non sono mai state studiate in pazienti con SM, sebbene possano offrire importanti implicazioni cliniche. L’integrazione di terapie cognitive, narrative ed esistenziali, unite alla comprensione empatica dei processi affettivi attraverso la mentalizzazione, potrebbe aiutare le persone a riflettere su stati interiori profondi, favorendo così il loro adattamento e benessere21.
ObiettiviIl presente studio si è posto l’obiettivo primario di identificare le caratteristiche sociodemografiche, cliniche e psicologiche che predicono il cambiamento nei livelli di crescita e PTD, valutati con il Post-Traumatic Growth and Depreciation Inventory-X (PTGDI-X)3, 20, in pazienti con diagnosi di SM. Ulteriori obiettivi risultano essere:
Il presente studio, tuttavia in corso, ha coinvolto un totale di 182 pazienti presso l’Unità Operativa Complessa di Neurologia e Neurofisiopatologia della A.O. San Camillo-Forlanini di Roma. Dal campione originale sono stati esclusi 4 pazienti poiché non rientravano nei criteri di inclusione (diagnosi conclamata; assenza di stato di gravidanza), un solo paziente ha deciso di revocare il consenso e 22 pazienti hanno rifiutato di partecipare allo studio. Date tali motivazioni, il campione finale in baseline è costituito da un totale di 155 pazienti.
Durante la seconda somministrazione, un paziente ha deciso di non proseguire lo studio. Dunque, allo stato attuale, il campione è costituito da 154 pazienti.
Il campione è stato reclutato dopo aver svolto il controllo di routine con il medico neurologo e invitato a compilare i quattro questionari dalla durata totale di circa 15 minuti. Tutti i partecipanti hanno firmato il consenso informato; per ciascuno è stato tutelato l’anonimato mediante la creazione di un codice di sei cifre.
Ad ogni partecipante è stata somministrata una batteria di test psicometrici standardizzati in forma cartacea in due tempi di valutazione, con un intervallo temporale di 4/6 mesi. Sono stati, inoltre, raccolti dati sociodemografici [sesso, età, nazionalità, scolarità, stato civile, professione] e clinici [peso e altezza per il calcolo dell’indice di massa corporea, durata di malattia, familiarità per SM, sottotipo di patologia (MS subtype), gravità di malattia] rientranti nella valutazione della patologia in esame.
La ricerca ha ricevuto l’approvazione del Comitato Etico Lazio Area 4 (Prot. N. 16/2023) e del Comitato Etico dell’Università Europea di Roma.
ProceduraIl campione target è stato reclutato durante il controllo di routine con lo specialista. Per poter partecipare allo studio, i pazienti hanno dovuto soddisfare i seguenti criteri di eleggibilità:
- avere una diagnosi di SM effettuata da un neurologo dell’Ospedale;
- aver letto il foglio informativo e firmato e datato il modulo di consenso informato;
- possedere una padronanza della lingua italiana;
- aver compiuto i 18 anni d’età.
Di seguito, ulteriori criteri di esclusione:
- la presenza di altre patologie e/o compromissioni neurologiche (ad esempio, epilessia; morbo di Parkinson; Alzheimer; mild cognitive impairment);
- la presenza di alterazioni e/o compromissioni del funzionamento psicologico (ad esempio, diagnosi di conclamata psicopatologia; presenza di fenomeni allucinatori e deliranti);
- la presenza di altre condizioni di malattia cronica diverse dalla SM che possano influenzare la capacità di completare il protocollo;
- la presenza, per le donne, di una condizione di gravidanza.
Inoltre, in fase di analisi dei dati, sono stati inclusi nel campione allo studio solo i questionari che avessero almeno il 75% di risposte analizzabili.
StrumentiLa batteria somministrata ha richiesto un tempo di compilazione di circa 15 minuti e comprendeva gli strumenti di seguito elencati:
Le analisi preliminari sono state condotte su 112 partecipanti completi (“completers”), ovvero coloro che hanno fornito dati completi sia al tempo 0 (T0) che al tempo 1 (T1). Non sono emerse differenze significative in baseline tra completers e non completers, come verificato mediante t-test per campioni indipendenti e test del Chi-quadro. Inoltre, un’analisi post-hoc della potenza statistica ha confermato una power di 0.82, garantendo l'adeguatezza delle analisi, e sono stati soddisfatti tutti gli assunti per le regressioni lineari.
Il campione è stato descritto nelle sue caratteristiche sociodemografiche, cliniche e psicologiche attraverso tecniche di statistica descrittiva. Le variabili quantitative sono state descritte attraverso la media e la deviazione standard, mentre le variabili categoriche sono state descritte in termini di frequenze assolute e percentuali. È stata verificata la normalità della distribuzione delle variabili attraverso gli indici di curtosi e asimmetria. La presenza di variabili anormali, sono state analizzate attraverso statistiche non parametriche, ovvero la correlazione Rho di Spearman.
Sono stati condotti due modelli di regressione gerarchica lineare per determinare se la PTG o la PTD (variabili dipendenti) si associassero all’Expanded Disability Status Scale (EDSS), agli anni trascorsi dalla malattia, alla violazione delle credenze nucleari, alla ruminazione e all’affettività mentalizzata in baseline: ulteriori due modelli sono stati condotti analizzando i valori raccolti a distanza di 6 mesi. L'ordine in cui le variabili indipendenti sono state inserite nei modelli è coerente con le ipotesi dello studio.
Infine, occasionali valori mancanti sono stati sostituiti calcolando, per ciascun partecipante, il punteggio medio della corrispettiva dimensione. Tutte le analisi statistiche sono state intese significative per p < .05. Tutte le analisi sono state effettuate mediante il programma Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).
RisultatiNella Tab. 1 sono riportate le caratteristiche sociodemografiche e cliniche dei pazienti con SM che hanno partecipato allo studio. Circa il 78% dei partecipanti era di sesso femminile; la media dell’età dell’intero campione era di 45 anni. La maggior parte dei partecipanti era sposato (69%) e diplomato (54%).
In merito alle caratteristiche cliniche, la durata media di malattia era di 13 anni e meno della metà dei pazienti presentava disturbi in comorbilità (38%). Infine, la quasi totalità dei pazienti presentava una forma di malattia recidivante remittente (93%) e la media dell’indice di disabilità era pari a 1.3.
 |
| Tab. 1. Caratteristiche sociodemografiche e cliniche. |
Analisi correlazionali
I coefficienti di correlazione Rho di Sprearman sono presentati nella Tab. 2.
Innanzitutto, dalle analisi correlazionali è emerso che l’età, il tempo trascorso dalla diagnosi e l’EDSS non presentavano correlazioni significative con le altre variabili mentre le variabili psicologiche erano risultate correlate nella maggior parte dei casi; per esempio, le strategie di regolazione emotiva erano positivamente correlate alla (PTG), così come la violazione delle credenze di base.
Inoltre, la PTG e la PTD risultavano correlate positivamente sia in baseline che a distanza di 6 mesi.
 |
| Tab. 2. Correlazioni tra le variabili di interesse. (Note. *p < .05; **p < .01; BMA S_Id = Brief Mentalized Affectivity Scale Identifying emotions; BMAS _Pro = Brief Mentalized Affectivity Scale Processing Emotions; BMAS_Exp = Brief Mentalized Affectivity Scale, Expressing Emotions; CBI = Core Beliefs Inventory; ERRI_Int = Event Related Rumination Inventory_Intrusive Rumination; ERRI_r = Event Related Rumination Inventory_Deliberate Rumination; PTG = Posttraumatic Growth; PTD= Posttraumatic Depreciation). |
Modelli di regressione
Per l’analisi dei predittori, sono stati svolti modelli di regressione lineare cross-sezionali e longitudinali.
Nelle analisi di regressione lineare, presentate nella Tab. 3, la violazione delle credenze risulta essere un predittore significativo in entrambi i modelli. Anche la ruminazione è presente in entrambi, ma in forme differenti. Infatti, mentre una riflessione deliberata e costruttiva è un catalizzatore chiave per una crescita, la presenza di pensieri intrusivi e disturbanti tende a favorire un maggiore cambiamento negativo in seguito ad un trauma, alimentando una percezione negativa di sé e della propria vita.
Infine, le strategie di regolazione emotiva sono risultate predittori solamente per la crescita post-traumatica, indicando come buone strategie di regolazione possano favorire cambiamenti positivi.
 |
| Tab. 3. Regressione lineare per le variabili in grado di predire la PTG e la PTD nei pazienti con SM in baseline. |
Dalla regressione longitudinale, vediamo come il tempo dalla diagnosi sia emerso come un predittore significativo e positivo di crescita post-traumatica, insieme alle altre variabili viste in precedenza (Tab. 4). Questi risultati confermano che i fattori psicologici come la ruminazione deliberata e la regolazione emotiva giocano un ruolo chiave nella crescita post-traumatica.
Un risultato interessante riguarda la PTD. Dalle analisi è emerso che la ruminazione deliberata in baseline predicesse maggiore attenzione dei pazienti verso i cambiamenti negativi.
 |
| Tab. 4. Regressione lineare per le variabili in grado di predire la PTG e la PTD nei pazienti con SM a distanza di 6 mesi. |
Infine, controllando statisticamente per i livelli basali degli outcomes, aggiungendo un’ulteriore variabile al modello, tutti i predittori psicologici perdevano la significatività statistica, tranne la PTD, in cui l’espressione emotiva continuava a giocare un ruolo cruciale. Tali dati sono importanti per garantire un approccio rigoroso, ovvero comprendere l’effetto dei predittori tenendo sotto controllo i livelli basali dell’outcome. Tuttavia, bisogna sottolineare che l’aggiunta di questi fattori riduce la potenza statistica delle analisi.
Statistiche per campioni accoppiatiPer valutare l’andamento temporale delle variabili indipendenti sono state svolte delle statistiche per campioni accoppiati.
Dalle analisi è emerso che nella PTG, la correlazione elevata coesiste con una riduzione significativa nel valore medio da T0 a T1, indicando che i partecipanti possono mantenere una stabilità relativa, mentre il livello medio della variabile può comunque cambiare nel tempo. La significatività del Paired t-test evidenzia un cambiamento assoluto che non è in contraddizione con la correlazione.
Nella PTD, la correlazione è elevata (Rho = .68), ma non vi è un cambiamento significativo nel punteggio medio. Questo riflette una stabilità sia relativa che assoluta: i partecipanti non solo mantengono posizioni simili nella distribuzione (stabilità relativa), ma non ci sono cambiamenti sostanziali a livello medio (stabilità assoluta).
La correlazione più bassa per PTD (Rho = .68) rispetto a PTG (Rho = .78) può indicare che i punteggi di PTD sono leggermente più soggetti a variazioni individuali nel tempo. Tuttavia, il Paired t-test evidenzia che, in media, queste variazioni individuali si bilanciano, risultando in un'assenza di cambiamento significativo per la PTD a livello di gruppo.
La media della PTG è diminuita significativamente dal Tempo 0 (M = 64,98, DS = 25,52) al Tempo 1 (M = 58,57, DS = 26,72). Il test t per campioni accoppiati evidenzia una differenza media di 6,413 punti (DS = 17,026), che risulta statisticamente significativa (t(108) = 3,932, p < 0,001). Difatti, la diminuzione della PTG nel tempo è significativa, indicando una riduzione dei livelli di PTG nei partecipanti.
Invece, la media della PTD è rimasta pressoché stabile dal Tempo 0 (M = 30,78, DS = 22,19) al Tempo 1 (M = 30,97, DS = 22,97). Il test t per campioni accoppiati evidenzia una differenza media di -0,193 punti (DS = 18,621), che non risulta statisticamente significativa (t 108 = -0,108, p = 0,914). Non ci sono variazioni significative nei livelli di PTD nel tempo.
La correlazione positiva elevata per la PTG (r = 0,788, p < 0,001) suggerisce che l'ordine relativo dei partecipanti nei punteggi è stabile tra T0 e T1. Tuttavia, il test t indica che, nonostante questa stabilità relativa, i punteggi medi diminuiscono in modo significativo.
Per la PTD, la correlazione moderata/alta (r = 0,660, p < 0,001) riflette una moderata/alta stabilità relativa, ma non vi è alcuna variazione significativa nei punteggi medi.
Le alte correlazioni per PTG (Rho = .78) e PTD (Rho = .68) indicano che, in generale, i punteggi a T1 sono fortemente predetti dai punteggi a T0. Questo suggerisce una certa stabilità relativa (rank-order stability) delle misurazioni, ossia che i partecipanti tendono a mantenere posizioni simili nella distribuzione delle variabili nel tempo.
DiscussioneI risultati di questo studio evidenziano come la PTG e la PTD siano fenomeni coesistenti nei pazienti con SM. Questo dato supporta quanto emerso in precedenti ricerche, che suggeriscono che PTG e PTD non siano concetti mutuamente esclusivi, ma piuttosto aspetti complementari della risposta psicologica al trauma17-19.
La riduzione dei punteggi medi di PTG nel tempo potrebbe essere interpretata come un adattamento progressivo al trauma iniziale della diagnosi di SM. È possibile che, con il passare del tempo, i pazienti riescano a integrare il trauma nella loro narrativa personale, riducendo la necessità di ristrutturazione cognitiva, un meccanismo associato alla crescita1. Parallelamente, la stabilità della PTD suggerisce che i cambiamenti negativi possano radicarsi più profondamente nel corso del tempo, confermando la necessità di interventi precoci per mitigare tali esiti18.
Un risultato interessante riguarda il ruolo predittivo della ruminazione deliberata nella PTG. Questo è coerente con la letteratura che sottolinea come la riflessione controllata e consapevole sulle esperienze traumatiche favorisca il cambiamento positivo e la rielaborazione cognitiva5, 6. Questi risultati supportano teorie consolidate come il modello di riferimento preso in considerazione1, che sottolineano l'importanza di processi cognitivi, come la ruminazione deliberata e la ristrutturazione delle credenze, e processi emotivi, come l’affettività mentalizzata, nella promozione di esiti positivi dopo un trauma. Tuttavia, l’associazione della ruminazione deliberata anche con la PTD suggerisce che, in assenza di un significato positivo attribuito al trauma, questa possa accentuare sentimenti di vulnerabilità e perdita2. Inoltre, si potrebbe ipotizzare che, in eventi particolarmente traumatici, la riflessione deliberata potrebbe portare ad una maggiore consapevolezza delle perdite, del senso di vulnerabilità o di mancanza di controllo, contribuendo così a una visione negativa di sé o del mondo. La ruminazione deliberata può comunque portare a un'accentuazione dei pensieri negativi e di auto-giudizio. In particolare, quando l'individuo tenta di comprendere il trauma, ma senza riuscire a integrarlo positivamente o ad attribuirgli un significato costruttivo, può rimanere bloccato in una visione negativa di sé e della propria esperienza, che è tipica della PTD. Tuttavia, studi futuri potrebbero aiutare a comprendere meglio tale fenomeno.
La regolazione emotiva emerge come un elemento cruciale per facilitare la PTG. In particolare, strategie adattive come la rivalutazione cognitiva sono state associate a un miglioramento dell’adattamento post-traumatico8, 9. Tali strategie sembrano promuovere una gestione efficace delle emozioni negative, riducendo l'impatto dei sintomi intrusivi. Al contrario, la mancata regolazione delle emozioni potrebbe contribuire alla stabilità della PTD osservata nel campione12.
Infine, la violazione delle credenze nucleari è risultata un predittore significativo sia di PTG che di PTD. Questo risultato rafforza il modello teorico di Calhoun e Tedeschi (2006), che identifica la crisi delle credenze preesistenti come un meccanismo chiave per l’innesco della PTG. Tuttavia, una violazione profonda e non elaborata delle credenze nucleari potrebbe generare effetti negativi persistenti, come suggerito in studi precedenti3, 17. Difatti, la crisi delle credenze fondamentali è uno dei meccanismi chiave per innescare la PTG. Tuttavia, un forte scossone alle credenze centrali può non solo favorire la crescita personale, ma anche generare conseguenze negative, come evidenziato precedentemente in letteratura3, e suggerendo che gli effetti cognitivi del trauma vanno oltre il semplice disagio emotivo.
Questi risultati sottolineano la necessità di approcci terapeutici integrativi che combinino strategie cognitive ed emotive per supportare i pazienti nel loro percorso di adattamento. Future ricerche potrebbero concentrarsi sull’esplorazione longitudinale di questi fenomeni, includendo campioni più diversificati e l’applicazione di interventi specifici mirati alla promozione della PTG e alla riduzione della PTD.
Conclusioni, limiti e prospettive futureI risultati di questo studio confermano che la PTG non è un processo automatico, ma richiede un supporto mirato che promuova una riflessione deliberata e strategie efficaci di regolazione emotiva6, 9. La coesistenza di PTG e PTD evidenzia la complessità delle risposte psicologiche al trauma, coerentemente con quanto riportato nella letteratura di riferimento19, 20. Inoltre, il ruolo della violazione delle credenze nucleari e dell’affettività mentalizzata suggerisce nuove direzioni per interventi clinici basati sulla mentalizzazione12, 13.
È cruciale considerare approcci terapeutici integrati per favorire non solo l'adattamento psicologico ma anche un miglioramento del benessere globale nei pazienti con SM21. Studi futuri dovrebbero approfondire i meccanismi cognitivi ed emotivi sottostanti, integrando campioni più ampi e follow-up prolungati per validare ulteriormente questi risultati3, 4.
Tuttavia, i risultati del presente studio vanno interpretati con cautela tenendo in considerazione una serie di limiti.
In primo luogo, la dimensione del campione è limitata, con il rischio di incorrere in un bias di campionamento. Studi futuri potranno indagare queste associazioni in un campione più ampio. Inoltre, la predominanza di partecipanti di sesso femminile (78%) potrebbe influenzare la generalizzabilità dei risultati, considerando che la SM può avere effetti differenti su uomini e donne, sebbene rappresenti la popolazione di riferimento; difatti, si stima che la SM colpisca maggiormente le donne, principalmente in età giovane adulta tra i 20 e i 30 anni26. In aggiunta, quasi la totalità del campione preso in esame presentava una forma recidivante-remittente di malattia. Sebbene sia il decorso più comune26, 27, i risultati presentati in tale studio potrebbero non rispecchiare la popolazione di riferimento.
In secondo luogo, l’arco temporale dello studio, limitato a sei mesi tra le valutazioni, potrebbe non cogliere appieno la traiettoria evolutiva della PTG. Studi longitudinali più estesi15 hanno mostrato che le dimensioni della PTG, ad eccezione della spiritualità, aumentano significativamente in periodi più lunghi, fino a 36 mesi. Un follow-up prolungato permetterebbe una comprensione più accurata delle dinamiche temporali della PTG e della PTD.
In terzo luogo, i dati sono stati raccolti attraverso questionari self-report, che possono introdurre bias legati alla desiderabilità sociale o alla capacità dei partecipanti di riflettere accuratamente sulle loro esperienze. Inoltre, la natura retrospettiva di alcune misurazioni può essere vulnerabile al bias del recall, con la possibilità che i ricordi siano distorti o imprecisi. L’integrazione di strumenti obiettivi e valutazioni cliniche potrebbe ridurre tali rischi e migliorare la qualità dei dati raccolti.
Studi futuri potrebbero integrare campioni più ampi, un arco temporale di follow-up esteso e strumenti di valutazione che combinino misurazioni self-report con metodi obiettivi. Approfondire i meccanismi cognitivi ed emotivi sottostanti alla PTG e alla PTD, con particolare attenzione al ruolo delle credenze nucleari e della regolazione emotiva, potrebbe fornire basi più solide per lo sviluppo di interventi clinici mirati. Inoltre, esplorare le differenze di genere e l’impatto di diverse tipologie di decorso della malattia arricchirebbe la comprensione delle risposte psicologiche al trauma nei pazienti con SM. Queste direzioni potrebbero rappresentare un importante passo avanti per promuovere un adattamento psicologico positivo e migliorare il benessere globale di questa popolazione clinica.
Dott.ssa Chiara Alessio, Psicologa, Università Europea di Roma, A.O. San Camillo-Forlanini, Roma
Per la corrispondenza: chiaraalessioo@icloud.com
BIBLIOGRAFIA